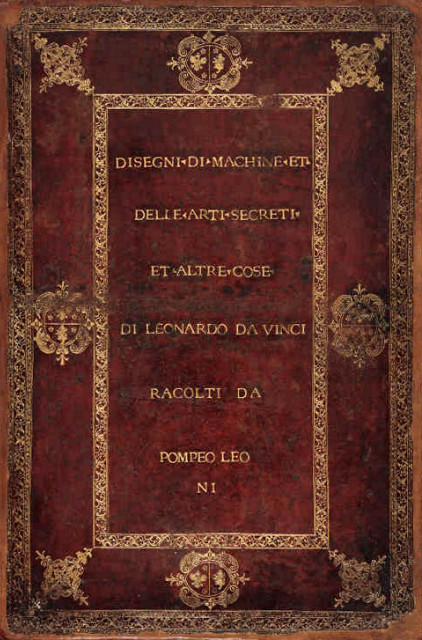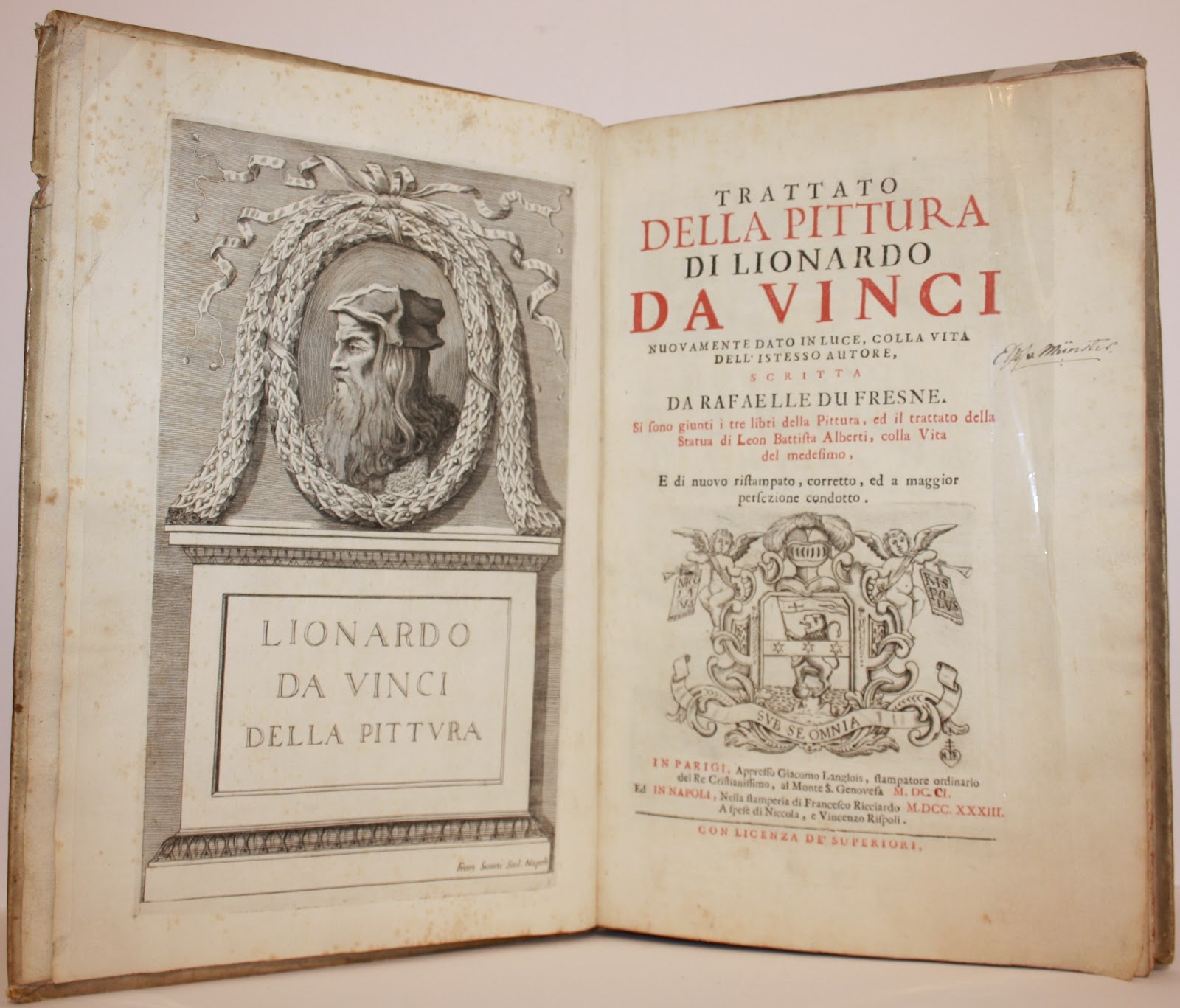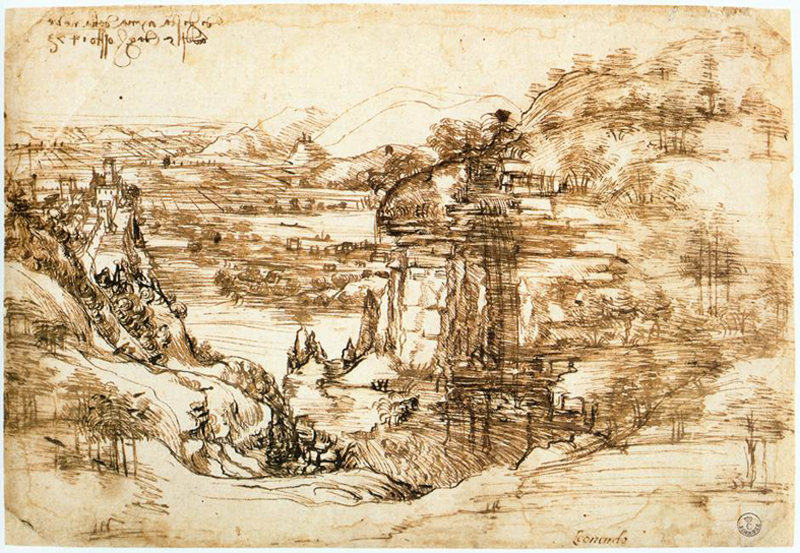di Loredana Fabbri
“Se i sacerdoti saranno santi, similmente sarà santo il popolo”.
(San Carlo Borromeo)
Alla memoria del Professor Domenico Maselli

La Valle Mesolcina dal Pizzo Uccello
PREMESSA
Il presente lavoro è un tentativo di ricostruzione della storia religiosa-politico-sociale dei territori sottoposti alla Visita Pastorale dell’Arcivescovo di Milano Carlo Borromeo nel 1583, una storia molto conosciuta, che ha riscosso tanti elogi ma anche tante aspre critiche per l’operato di colui che pochi anni dopo la sua morte divenne santo.

Ritratto di san Carlo Borromeo
Giovanni Ambrogio Figino (1548-1608)
Pinacoteca Ambrosiana, Milano
L’articolo si basa su documenti per la maggior parte editi da Paolo d’Alessandri e Rinaldo Boldini, i quali hanno pubblicato nelle loro opere i testi di documenti reperiti presso la Biblioteca Ambrosiana di Milano ed in altri Archivi, che sono stati preziosi ed indicativi per continuare la presente ricerca.

Antonio Noto, Statuta et capitula vallis Mexolcinae, 1942
Spesso nel testo riportiamo interi passi di documenti, poiché i riassunti con un linguaggio attuale non renderebbero bene certe “sfumature” come il lessico del tempo.
Non tutti i documenti trascritti ed editi da Paolo d’Alessandri sono fedeli agli originali, anche se i concetti restano gli stessi, ci sono molte parole omesse o cambiate e spesso sono riportati solo dei brani, tralasciandone altri, per noi di una certa importanza, anche perché la finalità di questo lavoro, come già accennato, è molto diversa da quella che si erano proposti i due summenzionati studiosi.
Molto interessante, non solo per la situazione religiosa, ma anche per le notizie storiche, geografiche ed economiche, è l’”Instruttione generale del Stato de Grisoni (diviso in tre parti) pertenente ad alcune cose temporali per maggior cognizione dello stato spirituale”, documento reperito presso la Biblioteca Ambrosiana, dove non troviamo né data né firme, ma da cui possiamo evincere che tale documento fu scritto poco prima della Visita Apostolica, con lo scopo, come recita il titolo, di dare una visione unitaria della situazione presente nei territori delle Tre Leghe. Altre notizie molto importanti le possiamo dedurre da una più sintetica relazione sulla Visita di quella edita dai due studiosi D’Alessandri e Boldini, e da altri documenti non riportati nei loro lavori qui citati.
Nei secoli del basso Medioevo, l’attuale territorio svizzero apparteneva al Sacro Romano Impero, cui facevano riferimento le varie città e comunità di valle per espandere la sovranità degli individuali confini ed essere direttamente soggetti alla giurisdizione imperiale, lontana e spesso astratta, era un modo per sfuggire all’invadente autorità dei vescovi e dei signori feudali.
Dopo la metà del secolo XIII, la decadenza delle istituzioni imperiali, con la conseguente precarietà e incertezza politica, indussero le città e le comunità rurali a stipulare intese difensive che furono anche l’occasione per affermare la propria indipendenza: nel 1291 l’unione dei cantoni montani di Unterwalden, Schwyz e Uri rappresentarono il nucleo della fondazione della Confederazione, anche se città come Zurigo, Berna e Lucerna continuarono ad avere un ruolo importante.[1]
Gli Asburgo, feudatari dell’Alta Valle del Reno, rappresentarono una grave minaccia per i Cantoni, specialmente quando nel 1273 ottennero la corona imperiale, ma agli inizi del secolo successivo, i Cantoni con un’abile mossa politica strinsero alleanza con Ludovico il Bavaro contro Federico d’Asburgo, infliggendo agli Asburgo una grave sconfitta nel 1315 e alla fine dello stesso secolo la Confederazione si attribuì un carattere più saldo e delineato con la Convenzione di Sempach del 1393, cui aderirono Zurigo, Zugo, Lucerna, Glarus e Berna.[2]
Nei primi anni del Quattrocento, la Confederazione, divenuta una potenza considerevole, cerca di estendere il proprio dominio al di là del passo del San Gottardo sui territori dell’attuale Canton Ticino, ma il tentativo rimane incompiuto a causa della vittoria dei Visconti ad Arbedo nel 1422.
A Vazerol nel 1471 venne sottoscritta la Repubblica delle Tre Leghe tra la Lega Caddea, la Lega Grigia e la Lega delle Dieci Giurisdizioni: si trattò di un accordo in cui le tre Leghe, pur restando indipendenti e separate, stipularono un patto per difendersi meglio dagli Asburgo, che continuavano ad asservire questi luoghi per ottenere il controllo sui passi esistenti nella regione. Dopo accordi con la Confederazione svizzera, prima nel 1497 poi l’anno successivo, lo Stato delle Tre Leghe fu considerato associato alla Confederazione elvetica, e dal 1512 anche la Valtellina con Bormio e Chiavenna fecero parte della Repubblica delle Tre Leghe, se pure con livelli diversi di sudditanza.
Continua, nel frattempo, il conflitto con gli Asburgo, ma una nuova minaccia per la Congregazione è costituita dall’espansione dello Stato borgognone, ma le sconfitte che i piccheri svizzeri inflissero ai cavalieri borgognoni nel 1476, diedero fama continentale alle truppe elvetiche che cominciarono ad essere richieste dalle potenze europee per il loro rivoluzionario modo di combattere, segnando il tramonto del cavaliere e della cavalleria medievale, e facendo dei piccheri svizzeri i mercenari più richiesti. Ad accrescere il peso internazionale della Confederazione, oltre le vittorie, ci furono anche le ammissioni a tale Confederazione di Basilea, Sciaffusa, Friburgo, Solothurn e Appenzell, ma le mire espansionistiche furono fermate dalla sconfitta subita a Marignano nel 1515 da parte di Francesco I, i Cantoni misero fine alle loro ambizioni sul Milanese, ma il Canton Ticino rimase sotto il potere della Confederazione svizzera.[3]
La diffusione del pensiero di Lutero inizialmente non causò una distinta contrapposizione nella vita della comunità cristiana, d’altra parte anche durante il Medioevo la disputa teologica e disciplinare era stata spesso irruente e frequente era stata la contestazione circa l’atteggiamento del clero compresa la più alta gerarchia ecclesiastica, ma tutto ciò non aveva causato divisioni insanabili, quindi il clima di rottura che si stava creando non fu percepito, per lungo tempo, in modo traumatico dalla gente comune. Anzi i ceti urbani più umili e la popolazione rurale provavano grandi speranze nei loro confronti proprio in un rinnovamento della Chiesa e della società. Anche la borghesia era favorevole alle novità che l’opera di Lutero avrebbe potuto portare sia dal punto di vista spirituale sia nella libertà da vincoli, soprattutto fiscali, nei confronti della Chiesa. I principi tedeschi intravidero nella contestazione teologica del teologo tedesco la possibilità di affermare la loro esigenza di autonomia politica da Roma e dall’Imperatore, inoltre coloro che aderirono alla Riforma incamerarono i beni ecclesiastici posti nei territori da loro governati, approfittando del disconoscimento delle autorità stabilite dalla Chiesa di Roma (episcopati e monasteri), trasformando in tal modo la disputa religiosa sollevata da Lutero in una rivoluzione politica ed economica, che sollevò una lunga polemica sull’obbedienza dei principi a Roma e all’Imperatore e sul legittimo possesso dei beni appartenenti alla Chiesa di cui si erano impadroniti.
Il movimento riformatore si estese anche fuori dai confini della Germania, per opera di altre personalità, le cui posizioni dottrinali non sempre coincidevano con quelle di Lutero: le idee riformistiche penetrarono nella Svizzera tedesca per mezzo di centinaia di opuscoli e di numerosi fautori ardenti e convinti che le diffusero ovunque, anche se l’impatto che ebbero sull’ambiente fu diverso a seconda che si trattasse di zone rurali o delle città.
A Zurigo il messaggio di Lutero venne recepito dallo svizzero Ulrich Zwingli (1484-1531), che dopo avere compiuto gli studi a Vienna e a Basilea, era stato ordinato sacerdote nel 1506, successivamente cappellano delle truppe svizzere che, vinta la battaglia di Melegnano, si impossessarono dei territori della Valtellina e del Canton Ticino ed imposero la Signoria di Massimiliano Sforza a Milano. Dopo l’esperienza militare Zwingli iniziò a Zurigo nel 1519 la sua attività di predicatore e di politico, dall’anno precedente era arciprete della Cattedrale di questa città e presa la guida della Chiesa la portò subito a posizioni riformate, allontanandosi dal Vescovado e collegandosi al Consiglio Comunale della città. Inizialmente si schierò con Lutero nella critica alla Chiesa romana e alla pretesa di essere l’unica mediatrice della parola di Dio, ma presto il suo pensiero divenne più radicale rispetto a quello del riformatore di Eisleben, soprattutto sui sacramenti e sulla liturgia: considerò inaccettabile ogni dottrina che ritenesse possibile un cambiamento di sostanza, quindi negò il valore sacramentale dell’Eucarestia e di tutti i sacramenti, attribuendo loro un valore puramente simbolico. Ridusse la liturgia a una semplice lettura commentata della Bibbia e a una rievocazione dell’Ultima Cena di Cristo. Nel 1522 si dimise dal suo ruolo, restando a Zurigo come predicatore alle dipendenze del Consiglio cittadino, che, successivamente, adeguandosi alle idee zwingliane istituì una nuova riforma ecclesiastica radicale, in cui venne soppresso il Diritto canonico, furono requisiti i beni ecclesiastici a favore della pubblica beneficenza, nelle chiese vennero eliminate le immagini sacre e furono annullate le processioni e la musica sacra, fu imposto l’obbligo di partecipazione alla liturgia e il divieto di assistere a messe cattoliche. Questo modello si estese anche ad altre città come Basilea, Berna e Sciaffusa, invece in altri Cantoni ci fu una forte resistenza, che dette origine ad una serie di scontri armati, che sfociarono, più tardi, in una vera e propria guerra contro i Cantoni cattolici e Zwingli venne sconfitto e cadde nel 1531 nella battaglia di Kappel.[4]
La morte di Zwingli non arrestò lo sviluppo della Riforma, fuorusciti, predicatori itineranti e mercanti portavano di città in città le idee riformistiche basate su linee diverse da quelle di Lutero, soprattutto i <<…mercanti, che, recandosi in zone di fede luterana e soprattutto calvinista, vi trovavano delle idee rispondenti al loro mestiere e ai loro bisogni: infatti secondo Calvino ogni attività lavorativa è benedetta da Dio, la riuscita negli affari è una prova della salvezza, il denaro deve essere considerato un dono di Dio e messo a frutto non solo come aiuto ai poveri e alla Chiesa ma anche come investimento finanziario per servire la Comunità, e l’uomo d’affari deve essere prima di tutto un uomo di fede>>.[5] I protestanti rimasero liberi nei domini francesi, ma cominciarono le persecuzioni in altri territori, tra i perseguitati vi fu Agostino Mainardi (1482-1563), il quale si rifugiò nel territorio dei Grigioni nel 1539 e fu il primo predicatore della Comunità Evangelica di Chiavenna.[6]
Nel 1536 arrivò a Ginevra il francese Jean Cauvin (Noyon 1509.1564), nome italianizzato in Giovanni Calvino, dove svolse la funzione di predicatore e pastore. Dopo varie peregrinazioni, protetto da Renata di Navarra, moglie del duca d’Este, Calvino si rifugiò a Basilea, città molto tollerante, dove ebbe termine la prima stesura della sua opera più importante: la “Institutio Christianae Religionis (1536), in cui spiegava i concetti essenziali della dottrina cristiana e i punti principali della verità evangelica riscoperta da Lutero. D’accordo con il riformatore tedesco sugli elementi fondamentali della Riforma come la salvezza tramite la sola fede, totale debolezza della libertà umana, affermazione del sacerdozio universale, sul modello di Zwingli, diverge da Lutero su diversi punti fondamentali: sul tema della predestinazione, Lutero afferma che Dio, con sovrana libertà, sceglie, indipendentemente dai loro meriti, alcuni uomini per la salvezza; Calvino estremizza il pensiero luterano proponendo la “doppia predestinazione”, secondo cui Dio destina alcuni uomini alla salvezza e altri alla dannazione etrna. Per entrambi i riformatori i Sacramenti sono due: battesimo ed eucarestia, ma Calvino li considera semplici atti simbolici senza significato salvifico, negando la presenza di Cristo nell’eucarestia; per l’organizzazione interna della comunità cristiana, Calvino non si limita a negare il primato del clero sul laicato, ma propone una Chiesa in cui i laici abbiano assoluta prevalenza nel governo, egli non prevede una Chiesa nazionale, come Lutero, ma un’organizzazione della comunità locale, dove ogni centro ha la sua autonoma organizzazione vicina alle esigenze della borghesia cittadina.
Come già accennato, sempre nel 1536 Calvino si trasferì a Ginevra, dove proclamò il suo pensiero politico totalmente radicalmente opposto a quello di Zwingli, che affermava la netta prevalenza della gerarchia religiosa su quella politica e nel 1537 obbligò i cittadini di Ginevra a rispettare gli “Articoli sull’organizzazione della Chiesa”, con gravi sanzioni per gli inadempienti. Nel 1538 Calvino fu costretto a lasciare questa città a causa di un rovesciamento del governo cittadino, ma tre anni dopo fece ritorno a Ginevra, dove fece approvare le “Ordinanze ecclesiatiche “, in cui veniva stabilito la netta subordinazione dello Stato alla Chiesa e il potere deliberante (anche quello civile) venne affidato ad un Concistoro, organo di governo composto da sei pastori ecclesiatici e da dodici anziani eletti dai consigli municipali. In tal modo Ginevra fu trasformata in una vera teocrazia, una città santa, una nuova Roma, opposta alla Roma nepotista e immorale contro cui tutti si avventavano e le divergenze dottrinali stroncate duramente: un caso emblematico fu quello di Michele Serveto, medico spagnolo, fuggito dalla Spagna dove fu considerato eretico, arrivato a Ginevra per poter professare liberamente la propria fede, fu condannato e messo al rogo, incrinando così il mito di libertà proprio del mondo riformato, contrapposto alla tirannia di Roma, nonostante ciò il calvinismo consolidò le proprie posizioni e Ginevra divenne un luogo di perfezione, dove era stato realizzato un nuovo modello di umanità.[7]
Le speranze in una profonda riforma della Chiesa di Roma, che si erano diffuse fin dall’XI secolo, erano state deluse, ma il bisogno di un mutamento era profondamente sentito, poiché la mondanizzazione di essa si era estesa assai anche attraverso l’istituzione dei vescovi-principi e dei vescovi-conti, dotati di ampi poteri politici, oppure con le ricche prebende, che permettevano a cadetti di illustri famiglie, ma senza spirito ecclesiastico, di ritrovare il fasto e la ricchezza che non potevano più avere nella propria famiglia. La mondanizzazione dei papi rinascimentali da Sisto IV a Leone X avevano fatto scadere l’idea spirituale : troppa politica, troppo lusso, troppo fiscalismo minavano il prestigio della Chiesa. D’altra parte il nazionalismo sempre più ascendente, che trovava la sua ragione d’essere nello scadimento del feudalesimo e nella forte ascesa del commercio e del capitalismo, portava a frantumare l’unità dei cristiani.[8]
La Riforma protestante incalzò il pontefice Paolo III a convocare un concilio, richiesto da tempo nel mondo cristiano, ma già prima dell’inizio del Concilio di Trento (1545-1563) le speranze di rappacificamento erano perdute, poiché i protestanti decisero di non parteciparvi. Sul piano dottrinale il Concilio operò una netta chiusura nei confronti del Protestantesimo: la Chiesa di Roma si propose come unica interprete delle Sacre Scritture: fu affermato il principio della salvezza per mezzo non solo della fede ma anche delle opere, condannando la tesi luterana della “sola fide”, venne ribadito il libero arbitrio dell’uomo, fu stabilito il numero dei sacramenti (sette) e la loro efficacia non solo simbolica, venne decretato l’obbligo di residenza per i preti e i vescovi, affidando a quest’ultimi la totale responsabilità sulla propria diocesi, con l’obbligo di visitarla, venne riformata la predicazione, fu proibito il cumulo dei benefici, vennero creati i seminari per la formazione del clero: sull’esempio di grandi vescovi come Carlo Borromeo a Milano e Francesco di Sales a Ginevra, fu rinnovato l’impegno pastorale delle guide della Chiesa. Vennero anche prese delle misure contro il nepotismo, la simonia, il concubinaggio: complessivamente la Chiesa di Roma uscì rafforzata dal Concilio ed ebbe nel catechismo uno strumento molto importante per la diffusione dell’ortodossia tridentina.
A tutto questo si accompagnò un’azione repressiva, che trovò il suo principale strumento nel potenziamento dell’Inquisizione Romana o Congregazione del Sant’Uffizio, tra le vittime più celebri si ricordano: Giordano Bruno, Tommaso Campanella, Galileo Galilei. L’intento di riforma del Cattolicesimo si espresse anche attraverso i nuovi ordini religiosi e in questo la Chiesa ebbe come principale strumento la Compagnia di Gesù, fondata da Ignazio di Loyola, su una struttura rigorosamente gerarchica, su una rigida obbedienza e sulla notevole preparazione culturale dei suoi membri, i quali riservarono grande attenzione all’istruzione, di cui presto detennero il monopolio. La divisione in seno alle Chiese cattolica, luterana e calvinista fu profonda e tale da sentire la necessità di sottolineare i loro elementi distintivi, nacque così il “confessionalismo”, ossia quella tendenza a subordinare le scelte e le decisioni politiche, morali e civili ad una determinata confessione religiosa, che trovò la sua realizzazione nel disciplinamento sociale, cioè nel controllo delle Chiese su tutte le manifestazioni della vita di relazione, con lo scopo di uniformare i comportamenti e concepire nei singoli un atteggiamento di obbedienza. L’intolleranza divenne comune a tutte le Chiese non solo nei confronti delle altre confessioni, ma contro chiunque fosse considerato un “diverso”; dilagò così il fenomeno della caccia alle streghe: decine di migliaia di persone furono mandate a morte in tutta Europa, accusate di stregoneria, con confessioni ottenute sotto tortura, la psicosi della stregoneria si diffuse al punto che finì per coinvolgere molti “diversi”, emarginati dalla società che trovavano nella stregoneria un modo di evasione da quella società che li aveva respinti. Oggetto di crudeli persecuzioni furono anche gli Ebrei, i quali vennero confinati in ghetti nei quali erano costretti a risiedere e a portare un segno di riconoscimento; in Spagna, già nel secolo precedente, la riconquista cattolica e l’Inquisizione avevano imposto agli ebrei sefarditi conversioni forzate, dando luogo al fenomeno dei marrani, molti dei quali mantennero le loro tradizioni ancestrali, professandosi pubblicamente cattolici, ma restando fedeli all’ebraismo in privato.
Nel 1565, infine, venne stilata la confessione “Professio fidei tridentina”, in contrapposizione a quella luterana di Augusta. Controllo e repressione delle eresie e rinnovamento della vita ecclesiale furono, dunque, le linee guida della Chiesa Cattolica dopo il Concilio di Trento.[9] Concludiamo questa breve e incompleta panoramica del secolo XVI con le parole di Attilio Agnoletto: << Si può dire che quella che si ama definire la “Riforma cattolica” trovi il suo approdo nel Concilio di Trento, che forse è nella storia della Chiesa Cattolica il più importante tra quelli ecumenici sia per le definizioni dogmatiche sia per i decreti di riforma interna. Occorre infatti arrivare al 1869 perché la Chiesa riconvochi un altro concilio. E anche il Concilio Vaticano II, che si è svolto a circa quattro secoli di distanza, non ha certo intaccato la sostanza di decisioni che appaiono irreformabili […]. Se si vuole comprendere il cattolicesimo del mondo moderno bisogna risalire alle decisioni del Concilio Tridentino, che chiusero la porta alla Riforma protestante, ma realizzarono e diedero l’avvio a una riforma cattolica […]. Esaminando, alla luce attuale, gli effetti delle decisioni tridentine, si deve riconoscere che il Tridentino è la chiave di volta di tutto il cattolicesimo fino ai nostri giorni. La sua importanza non consiste solo nel ripudio dogmatico delle istanze della Riforma, ma anche nell’eliminazione di infiniti abusi e nella costituzione di ordinamenti tuttora vigenti. Si potrebbe dire che il Concilio di Trento ha ridato vigore al cattolicesimo, facendone una rinnovata confessione religiosa che si colloca accanto alle altre rampollate dalla Riforma. Ne è nata una Chiesa poderosa, giuridicamente strutturata, dogmaticamente fissata >>.[10]
L’ultima fase del Concilio di Trento ebbe luogo tra il 1560 e il 1563, da cui cominciò la Riforma cattolica, nello stesso tempo in Italia cominciò a diminuire il protestantesimo per subire un vero e proprio crollo nel 1568 ad eccezione della Valtellina dove le dottrine eretiche proliferavano. “Riforma cattolica” intesa come movimento di riforma interno alla Chiesa di Roma, e “Controriforma”, cioè una reazione alla Riforma protestante che utilizzò l’azione missionaria per riportare al Cattolicesimo le aree geografiche passate alle nuove confessioni religiose e che fecero uso anche di strumenti repressivi come il Tribunale dell’Inquisizione.
Nello Stato di Milano la Chiesa cattolica stava attraversando un periodo di profonda crisi, a causa anche della mancanza di residenza dei Vescovi da oltre un secolo: in passato la città di Milano aveva avuto una lunga tradizione di eminenti prelati e profondo era stato il rapporto tra Chiesa e popolo, ma in questo periodo i rappresentanti dei Vescovi si limitavano a riscuotere i tributi, l’Ordine degli Umiliati era in piena decadenza[11] mentre lo Stato era sempre più forte, i Vescovi e gli alti dignitari ecclesiastici vivevano a Roma, lasciando la Chiesa milanese nelle mani di preti ignoranti che “cianciugliavano”la Messa in un latino stentato o sconosciuto, in città si diffondevano sempre di più i libri di Lutero portati anche dai mercanti: Milano era prossima alla Valtellina e a Ginevra e i collegamenti erano facilitati da questa vicinanza.[12]
Subito dopo la conclusione del Concilio di Trento, Carlo Borromeo (1538-1584) abbandonò la Curia romana e il potente ruolo di Cardinal Nepote di Pio IV per andare a svolgere le funzioni di Vescovo nell’Arcidiocesi di Milano.
Personaggio scomodo e molto discusso, Carlo fu uomo del suo tempo con le sue convinzioni e superstizioni, ricordato sia per la sua attività d’inquisitore sia per quella proficua in Milano, secondo per fama solo a Sant’Ambrogio, il futuro grande Vescovo di Milano era nato il 2 ottobre 1538 nel castello di Arona sul lago Maggiore, terzogenito del conte Gilberto e di Margherita de’Medici, sorella del Marchese di Marignano, Gian Giacomo de’ Medici e del Cardinale Giovan Angelo de’ Medici, la nobiltà e l’antichità della famiglia furono sempre care a Borromeo. La successione del padre, morto prematuramente lasciando i figli in difficili condizioni familiari, nella carica comitale spettava al fratello Federico, Carlo invece scelse la carriera ecclesiastica in quanto cadetto e la fulminante carriera e le dignità ecclesiastiche, dopo gli studi giuridici compiuti a Pavia, le dovette alla famiglia e soprattutto allo zio materno Giovan Angelo che fu eletto papa il 25 dicembre 1559 col nome di Pio IV, solo un mese dopo il Pontefice elevò al titolo cardinalizio il nipote ventiduenne, affidandogli la Segreteria di Stato, l’amministrazione perpetua dell’Arcidiocesi di Milano, la legazione di Bologna, l’Abbazia di Nonantola e la responsabilità degli affari pontifici con il titolo di Cardinal Nepote, ed altre altissime cariche con prebende numerose e ricchissime. A Fedrico assegnò il comando dell’esercito pontificio e poi il principato di Oria. [13] Già il 17 gennaio 1560, infatti, Monsignor Giulio Grandi, ambasciatore della Casa d’Este, così scrive in un suo carteggio: <<Si dice che nel concistoro di venerdì prossimo Sua Santità promuoverà al cardinalato l’abate Borromeo suo nipote, donandogli il suo cappello. Questo giovane è molto amato dal papa e veramente dimostra nelle sue azioni di essere assai meritevole>>.[14]
A Roma Carlo ed il fratello furono coinvolti nella sfarzosa e mondana vita della città, pur segnalandosi, il primo, per la sua riservatezza e la perseveranza con cui svolgeva i suoi compiti, fondò un’Accademia, che prese il nome di “Notti Vaticane”, inizialmente a carattere umanistico e che divenne poi un luogo di vivaci dibattiti teologici, che servì molto a Carlo per esercitarsi contro la balbuzie e la timidezza che gli impedivano di diventare un ottimo oratore. Sempre a Roma, il Cardinal Nepote ebbe modo di sperimentare le sue spiccate doti diplomatiche, evitando una dannosa interruzione dei lavori durante l’ultima fase del Concilio di Trento, grazie al suo delicato lavoro di rendere agevoli e prudenti i rapporti tra il papa ed i legati, con lettere, istruzioni, ordinanze, redatte dal suo segretario personale Tolomeo Gallio, futuro cardinale di Como, nonostante prevalessero i consigli del Cardinale Hosius e soprattutto del Cardinale Morone, il quale svolse la parte decisiva nella conclusione del Concilio (1562-1565), dopo la morte dei Cardinali Gonzaga e Seripando.[15]
Unito ad un profondo senso del dovere c’era per il Cardinale una grande fedeltà verso i vincoli familiari, nel 1558, alla morte del padre, iniziò ad interessarsi agli affari familiari, che fino all’elezione di Pio IV non erano floridi, impiegando molte energie per sposare le tre sorelle a dei principi, per dotare la nipote e per dare una sistemazione al cugino Federico, rimasto orfano del padre a soli tre anni e futuro Arcivescovo di Milano:[16] la rete delle alleanze familiari costituiva un’unità di potere, una sorta di milizia continuamente mobilitata e l’ascesa della famiglia Borromeo coincise con le numerose cariche e i beni che si accumulavano e la sua fortuna divenne considerevole, le cui rendite erano soprattutto di origine fondiaria, Carlo era un grande proprietario, molto abile nella distribuzione di terre a ottimi fittavoli, a visitarle, controllarle e ad affidarle ad economi scrupolosi. Questa gestione dei beni fondiari restò il modello dell’amministrazione ecclesiastica. [17]
La morte improvvisa del fratello maggiore Federico, il 25 novembre 1562, sconvolse il Cardinale, che dopo poco subì anche la perdita del suo amico Giovanni de’ Medici: <<La tradizione avrebbe voluto che in assenza di un altro esponente maschile della famiglia, Carlo rinunciasse alla porpora cardinalizia per subentrare al fratello nei suoi titoli nobiliari e forse anche per sposarne la giovanissima vedova. L’avere già pronunciato i voti, in qualità di suddiacono non era un ostacolo insormontabile, perché bastava una dispensa papale che Carlo avrebbe potuto ricevere con grande facilità. Sappiamo invece che l’impressione avuta da queste due sconvolgenti morti, lo indussero a legarsi di più alla scelta religiosa, fino a pensare ad un rutiro in un ordine monastico, da cui forse lo distolse il primate di Portogallo De Martyribus arcivescovo di Braga>>.[18]
Carlo aveva una concezione molto rigorosa della vita cristiana e dopo questi eventi tragici si parla di “conversione”, che lo indusse a farsi ordinare sacerdote il 17 luglio 1563 e vescovo il 7 dicembre dello stesso anno, cioè il giorno di Sant’Ambrogio, come scrisse a Corona, la sorella suora, e le parole di Domenico Maselli sono molto significative per capire lo spirito del Cardinale: <<Credo però che il termine conversione sia qui ben adoperato. Si passa infatti da una religiosità formale, personalizzata, ma concepita come uno tra i doveri della vita, ad una contemplazione di Cristo sofferente, che, impostasi ai suoi occhi mediante l’atroce sofferenza della morte del fratello, diventa l’elemento centrale della sua esistenza. La centralità della passione di Cristo è da questo momento una costante della spiritualità del Borromeo e costituisce, a mio parere, un elemento distintivo della Riforma Cattolica>>.[19] Possiamo comprendere anche alcune caratteristiche del Cardinale: nella vita ascetica e nelle privazioni verso se stesso, nella riduzione drastica del personale di servizio, nell’ordinazione a sacerdote e nella consacrazione episcopale possiamo vedere la trasformazione da Amministratore della Diocesi di Milano in Arcivescovo di questa città. Dopo la morte del fratello, Carlo cambiò atteggiamento e in una lettera del 30 aprile 1564 si dice che il Papa fosse molto contrariato dal nuovo tenore di vita severo, intrasigente di Borromeo, dando alcuni segni di disprezzo del mondo: <<…dicevasi trattare di teatine rie ed eccessi melanconici e fece comunicare ai gisuiti ed altri religiosi che li avrebbe puniti se mettessero più piede nelle case del Cardinale>>.[20]
Per tutta la vita del futuro Santo i “Canones reformationis generalis” di Trento ebbero la virtù di una rivelazione determinante, cioè quella del Vescovo-eroe della riforma tanto attesa dalla cristianità. Carlo si identificò con questa immagine e la rese effettuale ed è con questo spirito che cominciò il ventennio del suo governo episcopale a Milano, destinato a concludersi con la sua prematura morte nel 1584, in una lettera al Cardinale di Como del 4 dicembre 1563, ossia tre giorni prima della sua consacrazione, scrisse: <<…è tanto il desiderio mio che hormai s’attenda ad exequir poi che sarà confirmato questo santo concilio conforme al bisogno che ne ha la cristianità tutta e non più disputare…>>.[21]
Il 12 maggio 1564 Borromeo fu nominato Arcivescovo di Milano, ma inizialmente l’episcopato fu svolto per interposta persona, poiché gli impegni come Segretario di Stato del Papa non gli permisero di lasciare la città eterna, quindi nominò come suo vicario Niccolò Ormaneto,[22]Fu una scelta molto felice: egli provvide immediatamente a convocare un Sinodo Diocesano, milleduecento preti erano presenti il 29 agosto 1564, giorno dell’apertura, pronti ad ascoltare il programma che Carlo aveva mandato da Roma, in cui veniva enunciata l’applicazione dei decreti tridentini e una lunga serie di misure disciplinari come l’obbligo di residenza, la moralità, la riduzione del numero dei benefici, ottenendo, poco dopo, dal papa un breve che autorizzava il Cardinale ad ingiungere tasseai titolari dei benefici, iniziando anche una campagna per convincere coloro che detenevano più benefici ad accontentarsi solo di uno; gli studi ecclesiastici, di cui Carlo aveva già cominciato la creazione di un seminario, presso Porta Orientale,inaugurato il 10 dicembre 1564 per la formazione del clero diocesano, dove i seminaristi avrebbero frequentato i primi tre anni uguali per tutti, in cui prevalevano gli studi umanistici, dopo, i più validi avrebbero approfondito i loro studi presso il Collegio dei Gesuiti di Brera, gli altri avrebbero continuato la formazione in seminario;[23] le pratiche pastorali etc., le proteste dei partecipanti furono vane, insomma questo primo periodo di governo fu caratterizzato dall’esecuzione di tutto il programma tridentino, egregiamente condotto da Ormaneto, coadiuvato da monsignor Goldwell, fu proclamato anche un Concilio Provinciale tenutosi poi nel 1565. Sia il Sinodo Diocesano sia il Concilio Provinciale saranno i primi rispettivamente degli undici e sei convocati nei venti anni di governo della diocesi milanese.[24]
Dopo avere distribuito una parte dei suoi beni e ridotto il suo tenore di vita, Borromeo arrivò a Milano nel mese di settembre 1565, poco prima di essere privato della collaborazione di Ormaneto, il quale, l’anno successivo, fu nominato Vescovo di Padova e poi Nunzio in Spagna. Connesse a tali attività riformatrici furono le visite sistematiche della Diocesi, compiute dai suoi collaboratori ed è da notare che molte opere come la ristrutturazione delle carceri vescovili, l’assistenza alle prostitute pentite erano economicamente a carico di Borromeo, contraddicendo la fama di avaro che gli avevano imputato in quella Roma scandalizzata dalla vita senza sfarzi che conduceva. <<…si deve a lui il ridimensionamento della Corte papale, la diminuzione del lusso cardinalizio, in una parola la fine della fase mecenati zia della Corte pontificia. La condanna dei Carafa da parte di Pio IV con la fine dell’uso di concedere ai nipoti di papi principati su cui esercitare la propria signoria aveva iniziato la trasformazione; l’attività riformatrice e soprattutto l’esempio del cardinale nepote Carlo Borromeo, contribuirono a cambiare la società romana del periodo ed a porre le basi per la riforma che sarà operata sotto Pio V>>.[25]
Il 9 dicembre 1565 muore Pio IV, lo zio papa e con il nome di Pio V gli succede il Domenicano Michele Ghisleri, il quale non era stato certo amico del suo predecessore, ma molto grato a Carlo per l’azione svolta in suo favore durante il Conclave. Borromeo tornerà a Roma solo in rare occasioni: per i conclavi, per l’Anno Santo del 1575, per il conflitto con il Governatore di Milano (1579-82), per le visite pastorali, per i pellegrinaggi a Loreto e alla Sacra Sindone, che fu trasportata da Chambery a Torino nel 1578, il Presule si recò in questa città lo stesso anno ed altre tre volte nel 1581, nel 1582 e nel 1584 poco prima della sua morte.
Borromeo, nel discorso introduttivo pronunciato al primo Concilio Provinciale, delineò chiaramente il suo programma pastorale, vertente principalmente su cinque direzioni: riformare il clero secolare e regolare; creare i seminari per la formazione dei sacerdoti; restaurare la liturgia ambrosiana; coinvolgere il laicato nella vita della chiesa per mezzo di predicazioni e attività educative rituali, al fine di una riforma morale e sociale; la lotta contro le eresie.[26]
Il futuro Santo trovò l’ostilità del Senato alla pubblicazione in Milano della Bolla “In Coena Domini”,[27] emanata da Pio V sulla lotta alle eresie e contro i bestemmiatori, ostilità che venne ribadita in occasione della nuova bolla sull’inquisizione dalle autorità civili, contrarie alla messa in atto senza la loro autorizzazione. Il 20 novembre 1566 il Cardinale fece richiesta per avere degli “sbirri”autonomamente da quelli dei magistrati per eseguire esecuzioni contro il clero disubbidiente ed altri casi a lui spettanti, e, senza attendere la risposta del Senato, fece arrestare da un bargello il Prevosto di Sant’Ambrogio. Immediata la reazione del Senato, che ordinò ai bargelli e ai “birri”, pena la forca, di non attendere agli ordini dell’Arcivescovo senza espressa licenza del Capitano di giustizia, il Papa stesso intervenne in tale disputa asserendo di non essere d’accordo che il Borromeo avesse quanto richiesto, nonostante ciò il Senato deliberò delle misure particolari nel caso in cui il Vicario del Cardinale fosse andato alla processione del “Corpus Domini” con il drappello armato.[28]
Le emanazioni del prelato risultarono però inconciliabili con la legislazione laica. Le disposizioni dell’Arcivescovo, infatti furono giudicate un pericoloso attacco al primato del Re di Spagna, il quale considerava intoccabili i propri privilegi in ambito religioso, giuridico e beneficiario. Nel 1525 con il trattato di Madrid, il Ducato di Milano fu ceduto dalla Francia a Carlo V e dall’anno successivo dipese da Filippo II di Spagna, il quale designava il governatore dello Stato, tra le numerose questioni sorte tra l’Arcivescovo e il potere temporale ci fu anche quella dell’introduzione, nel 1563, dell’Inquisizione spagnola a Milano: da circa trent’anni si stavano infiltrando nella città tendenze luterane, calviniste, zwingliane etc., nel 1547 le autorità milanesi avevano bandito dalla città un cospicuo numero di ecclesiastici, che si erano rifugiati in Svizzera. Filippo II iniziò le trattative con il Papa per mettere in opera l’Inquisizione nella capitale lombarda, ma il Pontefice fece opposizione non tanto all’istituzione, ma alle sue procedure e all’invasione del potere civile in ambito religioso, questa era anche l’opinione di Borromeo, il quale come giurista ricusò i modi inquisitoriali spagnoli che accettavano accuse anonime e come uomo di Chiesa non accettò l’ingerenza dello Stato e condusse la caccia agli eretici avvalendosi di un piccolo corpo di polizia ecclesiastica o “Famiglia Armata”per eseguire le decisioni del Tribunale vescovile ed anche di un’associazione di circa quaranta nobili milanesi detti “crocesegnati”, nata per eliminare l’eresia. Così scriveva a Nicolò Ormaneto a Roma: <<Questi Signori Senatori, oltre li altri contrasti che ci fanno et disturbi che si sforzano di dare in molte maniere, cercano ancho di spogliarmi delli ministri più intimi, cio è delli Vicarij con varij officij sotto mano, et molestie dispiacendo a loro a punto il dissegno ch’io ho di tener in questo Tribunale persone che non sieno di questo Stato, perché non m’habbiano poi ad abbandonare per rispetto temporale, quando vengono così fatte turbolentie di queste contestationi coi Magistrati secolari come hanno fatto questi altri ministri inferiori>>.[29]
Contro le sette, i ribelli, i carnevali, le concussioni, Carlo preferiva la severità della predicazione o della legge ecclesiastica, era sua convinzione nella funzione pastorale del Vescovo fosse implicita anche la piena giurisdizione sul gregge, ma questa invasione in ambito giuridico sembrò pregiudicare i diritti del Senato, che ritenne inaccettabile affidare i colpevoli alla polizia dell’Arcivescovo anziché al braccio secolare, specialmente in questioni di dubbia competenza ecclesiastica. Borromeo colpì con la scomunica il Governatore dello Stato Requesens, il quale fece le sue proteste al Papa che lo sollevò privatamente dalla scomunica, il suo successore, il marchese di Ayamonte, a causa di divergenze nate dalle feste di Quaresima chiese al Papa l’allontanamento dallo Stato del Cardinale, ma Filippo II temeva per la sua immagine di difensore della Chiesa e Pio V aveva bisogno dell’aiuto della Spagna contro i Turchi, quindi si cercò da entrambe le parti di evitare lo scontro frontale che sembrava inevitabile.
Nel 1566 Niccolò Ormaneto fu chiamato a Roma dal Papa, nonostante la lontananza rimase costantemente in contatto epistolare con l’Arcivescovo milanese, tenendolo informato anche sui minimi particolari di ciò che avveniva nella Curia romana e riferendo, nelle sue lettere pressoché giornaliere, le intenzioni del Papa circa i problemi relativi ai rapporti del Borromeo con il Re, il Senato e il Governatore di Milano. Riportiamo due esempi che ci fanno capire il rapporto tra Carlo e Ormaneto e la difficile situazione creatasi tra il Prelato e il Governo spagnolo a Milano.
Carlo a Ormaneto, da Milano 23 luglio 1567: <<Qui alligata sarà copia d’una lettera scrittami dal Re credenziale nel Signor Governatore, il quale m’ha poi mandata la medesima lettera di Sua Maestà, nella quale mostra d’havere havuto informatione da Fiscali et dal Presidente ch’io m’usurpi della giurisdittione sua, onde mi esshorta a cessare da questo almeno fintanto che si veda l’appuntamento preso da Nostro Signore dopo havere udito quel tanto che si è mandato a dire dal Senator Chiesa. Da che si comprende che Sua Maestà sia per stare alla dichiarazione di Sua Beatitudine, la quale però è bene sollecitare che venga quanto prima>>.[30]
Ormaneto a Carlo, da Roma 16 agosto 1567: <<Non ho mancato di far quell’officio che la mi commette con Nostro Signore per la persona del Signor Governatore, qual ha scritto a Nostro Signore due lettere in risposta del breve et della lettera che Sua Santità scrisse a lui, stando pur su questo che Vostra Signoria Illustrissima è quella che innova tutta via cose nove contro la giuridittion Regia, facendo instantia che Sua Beatitudine le scriva che cessi da queste innovazioni dimandando l’assolutione per gli già scomunicati, cosa che Sua Santità non intende di far…>>.[31]
Nuovo motivo di crisi fu il Capitolo di Santa Maria della Scala, ente ecclesiastico di patronato regio, quindi esente dalla visita del Vescovo, che Carlo voleva riformare, e nonostante varie opposizioni, elesse dispoticamente il superiore, controllò le finanze, visitò le case e il 9 agosto 1569 si presentò alla porta della Chiesa e malgrado la presenza di armati da entrambe le parti, scomunicò tutto il Capitolo. Da una copia della lettera scritta il 29 agosto 1569 dal Cardinale al Papa, veniamo a conoscenza del fatto con le sue stesse parole: <<Il bando fatto dal Signor Governatore et Senato pertinente alla Giurisdittione Regia, se bene in apparenza ha il pretesto di detta Giurisdittione, si vede però per le cause pregnanti che contiene il scoppo suo principale essere di spogliar questo Tribunale ecclesiastico et anche quello di N. S. in queste parti delli ministri suoi et dell’essecutione della sua giurisdittione, come già se n’è visto seguir l’effetto, che tutti li miei Notari civili et criminali, avvocati et servitori publici et ogn’altra persona impaurita da questo bando non ardisce di far rogiti, né pur anche scritture, né portar commandamenti, citationi, né altra cosa, ove si tratti in qual si voglia modo di laici, ancorché per delegatione Apostolica, come ne vedrete qualche cosa per l’informationi che si mandano […] Et nel medesimo tempo è venuto il Vicepresidente a spiegarmi in nome del Duca et del Senato con belle parole a soprasedere anchora due o tre mesi, perché se allora poi non mi mostreranno il consenso, mi lascieranno visitare et mi daranno il braccio, ma ben si può vedere che questa dilatione non è ricercata a buon fine, con tutto questo gli ho risposto che ben sanno essi in iure, che io non devo essere impedito da visitare come ordinario, finché attualmente esshibiscano il consenso espresso, il qual però son certo che non vi è, havendo io tanti atti anche vicini al tempo che fu concesso il privileggio, che arguiscono il contrario et quando l’esshibissero poi in quel caso si trattarebbe della facultà che ho per il concilio di Trento et che gli atti et termini insolenti et indegni usati di quei canonici non meritano dilationi, né ch’io sopporti più oltre l’inhobedientia et temerità loro, havendola per troppo sopportata con molta indignità del grado, et luoco ch’io tengo. […] questa mattina è venuto da me uno de’ Fiscali regij a dimandare quattro mesi di termine […] Onde io gli ho dato risposta, che poiché non facevano altra risoluzione io havrei continuata la mia possessione facendo la visita, et così mi son risoluto di non lasciar passar hoggi a farla, et essendovi andato questa mattina, oltre l’insolentia et inettione violenta di mano fatta prima al Moneta Sacerdote, ch’io poco prima mandai a notificarli la visita, con dirli molte parole ingiuriose, quali vedere(te) per la sua relatione et testimonij, al mio arrivo anchora vedendo io che li miei, che entravano per la porta del Cimiterio erano da varie persone et con le mani, et con altri modi ributtati, mi risolsi di smontare sulla strada, et presa la Croce in mano entrai un poco dentro dalla detta porta, ancorché con gran difficoltà per le dette persone, et entrato che fui mi furono sfondrate addosso di molte spade, nel mezzo delle quali era l’Economo, et tutti insieme mi vennero incontro con armi et con gride et altri tumulti scandalosi gridando Spagna Spagna, onde mi spinsero fuori di detta porta del Cimiterio, urtandomi con una delle ante di essa porta, dove feci poi la publicatione dell’interditto et scomunica ridetta, come vedrete per la copia autentica che si manda, et Monsignor Castello che restò dentro doppo me attaccò anche la cedula alla porta, se bene fu subito stracciata. Rinovai poi subito l’atto della scommunica in Duomo più esplicitamente leggendo de verbo ad verbum la scrittura che non havevo potuto leggere là per il tumulto>>.[32]
Il 26 ottobre dello stesso anno, Gerolamo Donato, detto il Farina, frate dell’Ordine degli Umiliati, riuscì ad introdursi armato nella cappella dove il Prelato stava pregando e a sparare la celeberrima archibugiata contro il futuro santo, il quale uscì illeso dall’attentato. L’episodio è molto conosciuto: la notizia di tale fatto fece enorme scalpore, sia per la gravità del gesto sia perché lo scampato pericolo fu creduto un vero miracolo, che insieme all’imperturbabilità di Carlo, il quale ordinò di proseguire la celebrazione della liturgia senza interruzioni, incrementò la sua fama di santità e permise al Farina di fuggire. Pio V, Filippo II e il Governatore di Milano pretesero che si facesse luce sull’attentato: il papa dette disposizioni perché l’Ordine fosse abolito e tutti i beni appartenenti agli Umiliati fossero confiscati e utilizzati a favore della Diocesi di Milano, il Re di Spagna costrinse il Capitolo di Santa Maria alla Scala a sottomettersi pubblicamente all’Arcivescovo e convinse il Governatore ad esprimere al presule la loro stima e devozione. Il Farina e i due Prevosti complici, Girolamo di Cristoforo e Lorenzo da Caravaggio, rei confessi sotto tortura, furono condannati a morte.[33]
Passato lo scompiglio suscitato dall’attentato, le controversie tra il Cardinale e il Senato continuarono in modo grave, come le definì Tommaso Zerbinati, Ambasciatore della Casa estense: <<…specialmente a causa della molta autorità che l’arcivescovo si prende sui laici>>, infatti nel 1571, lo stesso Zerbinati in una sua relazione comunica che: <<Un bargello del cardinale abbattè la porta di un gentiluomo de’ Crivelli ritenuto concubinario, il quale difendendosi cadde ucciso>>, l’immediata reazione del Podestà fu quella di procedere contro le guardie del Borromeo.[34]
Ad accrescere la popolarità e la fama di santità contribuì molto anche la carità e la dedizione straordinaria che Carlo dimostrò verso il suo popolo durante la peste del 1576, così lo descrive Giovanni Pietro Giussani riferendosi a tale periodo: <<Ritiratosi poi in se stesso, e considerando come questo era un flagello mandato da Dio per castigo de’ peccatori, pensò saviamente, che il rimedio principale fosse di placare l’ira divina; per il cui fine si diede, con maggior frequenza del solito, alla santa Orazione, pregando in stantemente Sua D. M. che si degnasse aver misericordia del suo popolo, e donasse a lui, & a gli altri, lume di conoscere la sua santissima volontà, e quanto far dovevano in aiuto della povera, & afflitta Cittàe, e grazia afficace per essequirlo; accompagnando le sue orazioni col digiuno cotidiano […] Ordinò di poi tre processioni generali di tutto il Clero, e Popolo, le quali furono celebrate con gran concorso di tutti gli ordini; e nelle Chiese, dove si andava con la processione, egli predicava al Popolo, esortando tutti alla penitenza>>.[35] Borromeo diventa una figura leggendaria, gigantesca, che non viene colto dall’archibugiata del Farina, non viene contagiato dalla peste, nonostante l’assistenza ai malati, che dorme e mangia appena, che attraversa luoghi inaccessibili in ogni stagione per visitare le parrocchie della sua Diocesi. Per il Cardinale di Santa Prassede il Vescovo era il massimo responsabile della condotta morale del popolo, che voleva conformare a criteri molto rigidi, conducendo anche un’impavida guerra contro il teatro e gli spettacoli che considerava abitudini pagane, soppresse balli e superstizioni, sostituendoli con azioni: in pubblico professò la sua devozione verso i santi, egli stesso guidò le processioni delle reliquie, si recò più volte come pellegrino a Torino per visitare la S. Sindone ed in molti santuari intitolati alla Vergine, dando esempio di una religione non astratta e spoglia.
Carlo fu inflessibile anche contro l’eresia e ogni forma di superstizione, mandando al rogo numerosi eretici e presunte streghe. <<Le pestifere eresie come loglio e zizzania hanno occupato i campi della Religione Cristiana, e quasi soffocano il frumento. Non s’adora più Dio, anzi con mille obbrobj è bestemmiato ogni giorno: i Luterani, i Calvini e mille altri simili mostri orribili, sono l’Idoli delle misere genti. E che luogo può aver la speranza se non si crede il Paradiso, e se si nega la providenza di Dio? Dove è la carità, dove l’amore e ‘l timor santo? Non s’osservano più i Comandamenti di Dio, non si crede ch’egli abbia a giudicare i vivi e i morti; son reputate favole le pene dell’Inferno. O secolo miserabile! E’ perduta ogni giustizia verso Dio, né si osserva più verso il prossimo>>.[36] Dalle parole, riprese da un discorso dell’Arcivescovo, possiamo capire chiaramente un’accusa di quasi ateismo e di sconvolgimento totale dei fondamenti della religione cristiana nei confronti dei riformatori definiti “mostri orribili”.
La posizione geografica del Ducato di Milano, che si estendeva dai passi alpini fino alla costa ligure, lo rendeva pericolosamente esposto al diffondersi del Protestantesimo, specialmente quei territori transalpini che si inoltravano nei luoghi dove la riforma dominava, inoltre era basilare (indispensabile) per il progetto di restaurazione cattolica in Europa di Filippo II, dopo la pace di Cateau-Cambrésis (1559), che sancì l’uscita della Francia dalla scena politica italiana a favore della Spagna, il cui potere regnava incontrastato.
Durante le cosiddette guerre di predominio, lo Stato di Milano aveva perso la valli del Ticino e la Valtellina, a favore rispettivamente dei Bernesi e dei Grigioni, queste perdite mettevano a repentaglio il territorio milanese a possibili aggressioni dal Nord. Ad Est il Ducato confinava con la Repubblica di Venezia, che aveva una certa fama di tolleranza religiosa e politicamente in opposizione alla supremazia spagnola in Italia. Vari furono i focolai riformistici che si diffusero in Lombardia già dal tempo di Carlo V, il più cospicuo dei quali fu quello della “Ecclesia Cremonensis”, da dove tanti fuggiaschi raggiunsero la città di Ginevra.[37]
La Visita Apostolica che Carlo Borromeo effettuò nella Valle Mesolcina tra il 9 e il 29 novembre 1583 fu l’inizio di un grande progetto per il recupero dei Grigioni e di altre terre svizzere conquistate dalle dottrine della Riforma protestante.
Un documento reperito presso la Biblioteca Ambrosiana ci informa ampiamente sulla situazione temporale e spirituale della Valle Mesolcina prima della Visita Apostolica effettuata dal Cardinale Borromeo, si tratta di una: <<Instruttione generale del Stato de Grisoni >>.[38] La prima parte comprende <<alcune cose temporali per maggior cognizione dello stato spirituale>>. All’inizio del documento troviamo una descrizione della divisione politica del Dominio dei Grisoni, diviso in tre parti chiamate Leghe, la Lega “Grisa”, quella chiamata ”Cadede” e quella detta delle “Dritture”, ma tutte insieme sono denominate “Grisoni”, dal nome della prima Lega, che accettò, nonostante fosse libera, come federate le altre due, che, a differenza della prima non godevano della libertà, <<…perché la Cadede fu già per la maggior parte Iurisditione anco temporale del Vescovato di Coira Citta e capo di detta Lega, la qual ha continuato sempre a giurare la fedeltà a tutti li Vescovi e ricever da essi come Prencipi d’Imperio, la facoltà d’essercitar la giurisdittione da che forse questa lega ha preso il nome di Cadede, come casa e dominio di Dio, sendo sottoposta nell’una e l’altra giurisdittione alla Chiesa>>.[39] La Lega Caddea venne costituita il 29 gennaio 1367 e comprendeva Coira, la regione di Domigliasca, Obervaz, Bergun, la Valle delle Sursette, l’Alta Engadina, Val Brgaglia, Val Monastero e la giurisdizione di Sottoclava in Val Venosta. Poschiavo, sottoposto a Milano, entrò a far parte della Lega nel 1408. Il sigillo era uno stambecco, il quale originariamente era lo stemma vescovile, che compare nella Cattedrale di Coira fin dal 1252, ma viene ripreso dalla Lega Caddea alla sua fondazione.[40]
La Lega delle “Dritture” (Lega delle Dieci Giurisdizioni), fondata l’8 giugno 1436 a Davos, fu prima sotto la giurisdizione dei baroni di “Vazz”, poi dei conti di “Tocamburg” (von Toggenburg), <<…indi dei Conti d’Amasia, quali finalmente la cambiorno con gli Arciduchi d’Austria, per alcune terre del Dominio loro nella Val di Venusta…>>,[41]la quale famiglia non viene menzionata nella storia della Lega delle Dieci Giurisdizioni, anzi la Lega si forma dopo la morte dell’ultimo conte di Toggemburg avvenuta il 30 aprile 1436.
La più importante delle Leghe è quella Grisa, oltre ad avere dato il nome a tutte tre le Leghe, ha tenuto sempre il ruolo principale nelle “Sessioni” e nei “Consegli” generali, chiamati Diete. Ha come insegna una croce metà bianca e metà grigia. Per importanza la seconda è quella di “Cadede”, infatti alle Diete siede dopo quella Grisa; quella <<…delle Dritture tiene l’ultimo luogo, come quella che ha più picciola giurisdizione e de luoghi alpestri e selvatichi, dove dicono vivere huomini che non hanno mai usato pane per cibo loro, vivendo solamente de frutti della terra et latte, e perciò questa lega porta per insegna un huomo selvatico>>.[42] Le Tre Leghe, continua il documento, hanno le proprie giurisdizioni: la Lega Grisa ne ha tredici, la Caddea undici, quella delle Dieci Giurisdizioni sette, quindi le trentuno giurisdizioni, in circostanze particolari, sarebbero in grado di dare venticinquemila uomini dai diciotto ai sessant’anni validi per fare la guerra, oltre agli ottomila uomini della Valtellina e Val Chiavenna, loro sudditi.
Segue una descrizione geografica del territorio: tutto il “dominio” è di circa centocinquanta miglia italiane, confinanti ad Est con il <<…paese dell’Arciduca d’Austria et il Bergamasco della Signoria di Venetia…>>,[43] a Sud con <<…il Comasco del Stato di Milano e parte de Signori Svizzeri, per le terre ch’hora tengono, ch’erano prima de Duchi di Milano…>>,[44] ad Ovest e a Nord con la Svizzera e parte della Svevia sottoposta all’Arciduca d’Austria, <<…la maggior parte è di la da monti, perche di qua in Italia vi restano solamente la Val Mesolcina e di S. Giacomo della Lega Grisa, Poschiavo in bregaglia della lega di Cadede et le Valli suddite di Chiavenna e Tellina. Sono tre passi ordinarij d’andare oltre i monti nel sudetto dominio de Grisoni, l’uno a Poaschiavo che passa i monti dell’Agnedina della lega di Cadede, l’altro della Val di S. Giacomo, per splucha della lega Grisa, qualè ordinario e frequentato, il 3° di Misocho della Val Mesolcina che passa la montagna di S.to Bernardino e questi ultimi fanno ambidue capo a Splucha di dove seguitando il Rheno sino a Coira si passa per valli e rupi tanto precipitose, che diece homini soli difenderebbero il passo, in maniera che non basterebbe a forza humana di transitare contra la voglia loro >>.[45] Questi territori, per la maggior parte montuosi, sono principalmente pascoli o coltivati a fieno, che viene prodotto in grande quantità, permettendo lo sviluppo dell’allevamento soprattutto bovino, viene descritta mediocre la produzione del grano, a causa del terreno e delle temperature, molto limitati i terreni coltivati a viti, ma il vino viene importato dalla Valtellina ed è di buona qualità.
Gli uomini, continua la descrizione, sono robusti e atti ai lavori faticosi, sono premurosi tra loro ed anche con i forestieri, ma molto sospettosi. Pochi sono i discendenti di nobili famiglie e quei pochi non hanno molta autorità, <<…perché sendo il governo de Grisoni popolare, bisogna che tengano conto d’ogn’uno et per esser quei che sono eletti dal popolo al governo, per la maggior parte poveri e bisognosi fanno le deliberazioni loro con molta passione per l’interesse ch’ogn’uno ne pretende per una via o per l’altra, si che col denaro par che s’ottenerebbero tutte le cose per difficili et importanti che fussero>>.[46]
Le Tre Leghe hanno come entrate economiche i proventi criminali della Valtellina e Chiavenna e quelle del dazio che si riscuote in questi luoghi, però sono obbligati a pagare al Vescovo di Coira mille lire l’anno, come stabilito da una convenzione: sembra che queste Valli con Poschiavo furono donate, nell’anno 1404, da Modestino, figlio di Barnaba Visconte di Milano al Vescovado di Coira, ma nel 1514 furono occupate dai Francesi e le Tre Leghe con il Vescovo pro tempore le recuperarono a spese comuni, <<…si che convennero che le leghe n’havessero le due parti delle tre e l’altra il Vescovo, però al tempo del Vescovo Ziglero, quando cominci orno a germogliare l’heresie in detti paesi, le leghe si usurporno tutto il Dominio di dette Valli. Si che il Vescovo fù forzato contentarsi del sudetto reddito di lire mille l’anno solamente>>.[47] Le Tre Leghe, inoltre, ricevevano ogni anno dall’Arciduca Ferdinado d’Austria seicento fiorini d’oro, in seguito ad un accordo con l’Arciduca Massimiliano per la “guerra” tra loro a causa della giurisdizione della Lega delle Dieci Giurisdizioni. Da oltre settanta anni, altri quindicimila scudi li ricevevano dal Re di Francia per distribuirli a persone che avevano incarichi di governo, quindi alcuni ricevevano di più, altri di meno secondo l’importanza dell’ufficio che svolgevano e questo era causa di malcontento, tanto che era necessaria la presenza di un ambasciatore francese, il quale cercava di accontentare tutti affinché nessuno si lasciasse corrompere da offerte di denaro superiori a quelle percepite. Sono popolazioni molto povere poiché non vi sono commerci e “mercimonij”.
Il documento ci informa che il paese non ha fortezze, né guardie e soldati in nessun luogo, perché protetti dalle Confederazioni svizzere confinanti e dalla difficoltà dei passi montani, dalla parte dell’Italia, che rendono sicuri questi territori come se fossero delle fortezze.
Le Tre Leghe non battono moneta, questa facoltà è data solo al Vescovo di Coira, il quale, dal 1160 circa, si fregia anche del titolo di Principe dell’Impero, conferito da Federico Barbarossa, nel 1366 Carlo IV concede al Vescovo di batter moneta, facoltà poco sfruttata a causa della povertà sia del Vescovado sia della popolazione: <<…da molti anni in qua da che cominciorno l’heresie…>>.[48]
Il manoscritto prosegue dando un’ampia spiegazione del governo dei Grigioni e del suo funzionamento: essendo un governo popolare, tutti gli abitanti, compiuti i sedici anni, partecipano ed eleggono i loro giudici sia per cause civili sia per quelle penali, i quali stanno in carica per due anni, eleggono anche le sessantatrè persone, che li rappresenteranno alle tre Diete annuali, che si tengono <<…nella festa della conversione di San Paolo, et all’hora s’attende principalmente all’elettione de gli offici alide luoghi et paesi sudditi s tutte tre le leghe, l’altra alla festa del S.mo Corpo di N.ro Sig.re e la 3° a S. Martino>>.[49] Nelle Diete vengono trattati problemi governativi ed altri concernenti i servizi delle Tre Leghe, ma quando occorrono decisioni circa le leggi, nuovi ordini e confederazioni con governanti, allora viene tutto rimesso alle deliberazioni popolari.
Per il governo della Valtellina e la Val Chiavenna, suddite di tutte tre le Leghe, viene eletto un governatore generale che si occupa della sicurezza pubblica di quei luoghi, con la facoltà di conoscere tutte le cause civili e penali<<… che occorrono in Sondria, terra principale di Valtellina, dove detto Governatore fa resistenza>>.[50] Il governatore, inoltre, conosce altre cause di altri luoghi, unitamente ai cinque Pretori, chiamati Podestà. Viene altresì eletto un Vicario generale, con residenza a Sondrio, con il compito di dare consiglio ai Pretori nei procedimenti penali, i quali avevano facoltà di diminuire o condonare la pena indicata, anche per quanto riguarda la pena capitale, eccetto i procedimenti ad istanza della parte offesa. In tali casi i Pretori non possono diminuire la pena né discostarsi dalla forma del consiglio, hanno, inoltre, il potere di vendere o donare i beni dei condannati, con cospicui ricavi. Viene eletto anche un Commissario di Chiavenna con pari autorità dei Pretori, oltre alla facoltà di procedere nelle cause penali senza il consiglio del Vicario.
Le cause civili e penali si definiscono senza bisogno di lunghi processi, in conformità degli ordini e statuti particolari di ciascuna giurisdizione e generali delle Tre Leghe e in conformità <<…ad alcuni loro riti, et usanze, quali osservano inviolabilmente, ne si tiene conto delle leggi Imperiali; per ciò non vi è in tutto il paese Giure Consulto alcuno che faccia l’officio di Giudice o Avocato, eccetto in Valtellina, dove se ne trovano pure alcuni che essercitano l’officio dell’Avocato e Procuratore>>.[51]
Le sentenze rese nei procedimenti penali non venivano appellate, ma subito eseguite, in caso di reati gravi erano definite col voto e il parere, per alzata di mano, di tutto il popolo di ciascuna particolare Giurisdizione, ma se il valore della causa civile superava una certa somma era ammesso l’appello nella Dieta susseguente, in cui si eleggevano giudici particolari per la trattazione dei procedimenti d’appello.
Quando sorgono liti tra due Giurisdizioni particolari della stessa Lega, i messi inviati alla Dieta, eslusi quelli delle Giurisdizioni interessate, eleggono dei Giudici per definire la causa e nel caso di contenzioso tra due Leghe, la terza assume il ruolo di Giudice. Se un soggetto non sottoposto alla loro Giurisdizione avanzasse pretese contro le Tre Leghe vengono eletti Arbitri da entrambe le parti, <<…da quali nel luogo de Valstat Iurisditione de Svizzeri insieme con alcuni deputati da essi Svizzeri si conosce e determina la causa, però nelle differenze tra l’Arciduchi d’Austria et esse tre leghe soleva per il passato esser Giudice il Vescovo di Costanza, all’hora città libera, ma hora che è sottoposta ad essi Arciduchi li Grisoni lo recusano>>.[52] Ciò che è stato detto nel manoscritto, sullo stato temporale, governo e dominio territoriale del paese dei Grigioni, è stato scritto per rendere meglio l’idea dello stato spirituale, che sarà l’argomento della seconda parte.
Tutto il territorio dei Grisoni, continua il documento, si trova sotto la Diocesi di Coira, ad eccezione della Valtellina e della Val Chiavenna, appartenenti alla Diocesi di Como, il Vescovo di Coira è anche il capo, come detto prima, della Lega Caddea, e risiede in un Vescovado molto antico, infatti il primo Vescovo Asimo o Asinio, viene menzionato nel Concilio di Calcedonia, convocato dall’Imperatore Marciano nel 451d’accordo con Papa Leone I, per dirimere la questione monofisita, <<…se ben circa 300 anni prima si trova ch’el paese ricevette la legge di Christo quale gli fu predicata da S.to Lucio martorizzati ivi con S.ta Emerita sua sorella, i corpi de quali sono anco sino al dì d’hoggi conservati nella Cathedrale di Coira>>.[53] La tradizione, infatti, attribuisce la cristianizzazione e la fondazione della Diocesi a San Lucio, patrono della Chiesa curiense, sotto la quale si trovano, al tempo in cui viene scritto il documento, 123 pievi. Una lunga descrizione di ogni pieve e di tutte le istituzioni ecclesiastiche ci informa anche della presenza più o meno numerosa degli eretici che vi si trovavano, sostenendo che in ogni pieve è presente almeno un predicatore, se non due mandati, per la maggior parte, da Zurigo e tutti seguaci di Zwingli, i quali si servono delle Chiese solamente per diffondere la loro dottrina. Non officiano il rito funebre, ma seppelliscono i defunti solo con due o tre suoni di campana, fanno suonare l’Ave Maria, ma non la recitano e in alcune pievi, dove è maggiore la presenza di eretici, la fanno suonare di sera.[54]
La terza parte del manoscritto è <<…pertenente alle cause della ruina spirituale di questi paesi>>.[55]
Nei luoghi dei Grisoni, l’eresia penetrò nel 1525 circa, ad opera di Zwingli e dei suoi proseliti, i quali <<…sparsero ivi questo veleno in persona. Non hebbero questi molta difficoltà a sedurre buona parte del paese in poco tempo, perché il popolo tutto, et massime i capi, all’horaerano mal sodisfatti di Paolo Ziglero, Vescovoo di Coira, quale presero in sospetto, che come familiare e dipendente dall’Arciduca Massimiliano d’Austria, che all’hora guerreggiava con essi Grisoni, per la Giurisdittione delle Dritture, non tenesse la parte dell’Arciduca contro di loro. Sì che fu accettata facilmente la predicata libertà licentiosa, e sottratt.e dall’obedienza di Santa Chiesa, per la quale niuno vi era che facesse, o che ne prendesse la protettione. Non il Vescovo per che dubitando di qualche particolare affronto si ritirò a stare nel Castello di Crostemborgo, sotto il dominio supremo dell’Arciduca sudetto, dove stette continuamente fino alla morte, lasciando le sue pecorelle in preda a lupi: non i Rettori delle Chiese particolari, per che vedendo fuggir il capo, ciascun attese a salvar se medesimo, et alcuno anco d’essi per haver libertà di carne si fece heretico: non i superiori temporali, per che essendo il governo in mano del popolo imprudente e desideroso di libertà, s’appigliò facilmente alla heresia, la quale fu prima introdotta nella Città di Coira, poi s’è andata allargando per tutto il paese, non solo di là, ma anco di qua da Monti, anco nelli sudditi come di sopra s’è discorso>>.[56]
Al Vescovo Paul Ziegler von Ziegelberg successe Licius Iter, con l’approvazione del popolo, che proprio in quei tempi aveva cominciato ad ingerirsi nell’elezione dei Vescovi: Iter non si preoccupò della situazione che si stava determinando, <<…dissimulò di veder le ingiurie e torti che tuttavia da laici si facevano a Santa Chiesa, con l’appropriarsi i beni ecclesiastici, cacciare claustrali et usurpare la giurisdittione del foro ecclestiastico>>.[57] Il successore, secondo il documento, fu Beatus di Porta, ma nella cronotassi dei vescovi di Coira risulta che dopo Iter fu eletto vescovo Thomas Planta (19 marzo 1550-4 maggio 1565), il quale prese parte al Concilio di Trento negli anni 1551-1552, fu un abile amministratore, ma si rifiutò di introdurre riforme ecclesiastiche; fu nel 1565 che venne eletto Beatus di Porta, nato in Tirolo presso Merano, il quale trasferì la sede dell’Episcopato a Castel del Principe e non volle far ritorno a Coira, nel 1580 si dimise e tornò nella parrocchia che gli era stata affidata nel 1576. Il 6 novembre 1581 fu eletto Vescovo Peter von Rascher <<…huomo d’anni 35, il quale prima era alla cura d’una Chiesa parrocchiale di quel paese, poi essendo Canonico della Cathedrale di Coira, fu fatto Vescovo, come quello che di due o tre ne’ quali il popolo consentiva, fu giudicato il più tollerabile all’hora>>.[58] Von Rascher, originario di Zuoz, “Terra eretica”, appartenente alla Lega Caddea, che in passato era suddita dei Vescovi di Coira, mentre attualmente, continua il documento, vuole essere superiore al Vescovato e non tollera che venga eletta una persona che non approva, anzi al Vescovo pro tempore hanno fatto promettere alcune cose considerate contrarie e dannose alla dignità, alla libertà e all’autorità ecclesiastica: non deve rinunziare alla sua carica senza il consenso della Lega; non deve esaminare, indagare su questioni pertinenti alla religione, ma lasciare che ognuno <<viva a suo modo, conforme a gli ordini del paese>>;[59] che non si intrometta nel recupero dei beni ecclesiastici in mano ai laici; obbligo di rendere conto, se richiesto, alla Lega Caddea delle entrate dell’Vescovado. <<Questo ha ben fatto residenza in Coira, cioè nel Vescovato, ma non si può negare che fin qui ha poco atteso a visitar la sua diocesi et fare altri offitij pastorali con le sue anime>>.[60] Di tutto ciò era già stato informato il Pontefice.
Vengono elencate quattro cause principali come responsabili delle eresie dilagate in questi territori, la prima è che molti dei Signori Grisoni sono corrotti e contrari alla religione cattolica, per cui anche i loro sudditi sono molto esposti <<ad ogni pericolo d’infettione>>, soprattutto in quei luoghi in cui hanno trovato rifugio gli eretici fuggiti dall’Italia, <<…li quali sono molto più arrabbiati contra la fede catolica, e per altro più atti istromenti del Demonio a corrompere gli altri, che non sono i naturali Grisoni et paesani pur corrotti. Onde è quasi meraviglia che queste Valli non sieno molto più corrotte di quello che sono poi che non arriva il numero de gli Eretici in esse, alla decima parte de catolici, o, in circa, con tutto che vi s’aggiunge anco l’abbandono, per dir così, del suo Vescovo, il quale vedendosi maltrattato da Signori Grisoni con l’usurpatione d’alcune raggioni temporali del Vescovato, et anco impedita molta parte dell’auttorità e giurisdittione ecclesiastica…>>.[61] Nel corso di tanti anni queste popolazioni sono state abbandonate dai loro Vescovi, i quali non si sono mai occupati delle loro anime, nonostante che in passato, cioè prima della Riforma, non avessero mai incontrato impedimenti, quindi la causa principale del dilagare delle eresie è l’incuria dei Vescovi verso i loro fedeli.
La seconda motivazione consiste nella mancanza di sacerdoti: le chiese sono vacanti, ma il popolo ha bisogno dei ministri spirituali e tale situazione ha fatto sì che siano stati accettati <<…ciascuno che loro si presenti in habito da prete ancorch’egli non habbia dimissionaria né facultà alcuna dal suo ordinario, anzi ancorch’egli sia sospeso et privato da esso ordinario di poter celebrareo amministrare sacramenti, pur l’accettano eziandio senza consenso ne auttorità dell’Ordinario di essi popoli e paesi Grisoni, overo suoi suditi, si come anco tolerano, et danno ricapito ad apostati, sfratati et fuggitivi, et a sacerdoti che continevano in publico concubinato con donne e figlioli in casa, celebrando cotidianamente, e talvolta hanno anco accettato puri laici, li quali essercitavano tutti gli officij sacerdotali in apparenza…>>.[62] Prima di stare senza ministri spirituali accettano anche gli eretici, questo avviene anche tra i riformati, infatti quando non hanno ministri, accettano anche quelli cattolici, come avviene in Mesocco, i cui abitanti sono per la maggior parte eretici, ma hanno accolto un predicatore Gesuita e sono molto numerosi coloro che vanno ad ascoltarlo, <<…tanto che bisogna che predicando egli dentro la Chiesa, presso la porta, il popolo l’ascolti di fuori per che non cape in Chiesa, et uno di questi giorni vi stavano con patienza, anco mentre nevicava loro addosso. Però essi eretici sono diligentissimi in mandar predicanti in tutti i luoghi, dove n’è bisogno et il Cantone di Zurich in particolare manda in abbondanza predicanti a tutto questo paese de Grisoni, dove si parla tedesco, et per questa via entrano ne luoghi cattolici, come s’è detto e di già hanno guadagnato da cinque o sei anni in qua molte pievi della lega di Cadede>>.[63]
La terza causa consiste nel comportamento deplorevole dei sacerdoti, che con la loro vita dissoluta danno il cattivo esempio al popolo, il quale non rispetta più l’autorità ed ha perso la deferenza dovuta verso il clero, anzi, contagiati da questi modelli <<…hanno abbandonato la vera religione per poter più liberamente caminar per la larga strada>>.[64]
La quarta causa viene definita la più importante di tutte le altre, poiché nonostante che la legge e l’accordo tra le Tre Leghe permetta al popolo di scegliere tra la religione cattolica e quella riformata, nessuno deve permettersi di denigrare le rispettive fedi, specialmente durante le prediche. Un decreto risalente al 1581 esclude tutti i preti e i frati forestieri indistintamente, ad eccezione di quelli di nazionalità svizzera e di coloro che essendo stranieri, fanno giuramento di fedeltà e di residenza ai loro Signori. Non meno grave il fatto che gli eretici parlino dai pulpiti male della Chiesa cattolica e del clero <<…et fanno molte altre insolenze et irrisioni contra la religione catolica senza alcuna punitione>>.[65] Molto grave ed incisivo è anche dare asilo a tutti i fuggiaschi ed apostati italiani e di altre nazioni, anche perché nella maggior parte dei casi sono sostenuti a spese delle Chiese locali, nonostante la popolazione sia cattolica. Quando un prete cattolico, prosegue il manoscritto, predicando al popolo, sottolinea argomenti pertinenti alla religione, ma che possono evidenziare gli errori delle eresie, viene <<…accusato e punito dai giudici secolari con ogni pretesto, et per questa vi hanno messo tanto timore et rispetti humani nel Vescovo et Canonici della Cathedrale di Coira, che se bene vi si celebra la messa non ardiscono però di predicarvi>>.[66]
La quarta parte del documento contiene i rimedi ad una situazione tanto grave, poiché l’enorme dilagare dell’eresia in questi paesi è un grande pericolo anche per l’Italia <<di qua da monti>> e soprattutto per la vicina città di Milano, dove gli eretici possono trovare rifugio, quindi urge trovare delle soluzioni per evitare un’ulteriore espansione delle eresie: la perdita di migliaia di anime di quei Paesi suscita compassione e afflizione, che deve spronare la carità del Pontefice ad aiutarli come essi desiderano e chiedono. Durante le Diete, i Cattolici si sono lamentati dei torti e delle violenze fatte loro e soprattutto di non poter vivere cattolicamente, ma anche nell’ultima Dieta, tenutasi a Tavau o Tavate, non hanno ottenuto nulla, anzi le ragioni esposte hanno dato luogo ad un tumulto che per poco non sono dovuti ricorrere alle armi, tutto ciò è dovuto al fatto che i Cattolici sono inferiori per numero e per voti, conseguentemente non hanno il coraggio di <<…mostrarsi liberamente quando bisognava per timor di non esser esclusi da gli offitij publici, alli quali, prevalendo sempre di voto gli heretici, non sono facilmente ammessi quelli che si scoprono esser assai Zelanti della Religione cattolica…>>.[67]
Sostanzialmente i rimedi consistono nel cacciare, da tutti quei paesi, gli apostati e i sacerdoti indegni, sostituendo questi ultimi con altri che svolgano i loro compiti conformi alla religione cattolica e parlanti la lingua tedesca, nei luoghi “al di là dei monti”, anche se ciò è ritenuto quasi impossibile, creare nuove scuole e Seminari, che saranno certamente frequentati dai figli dei Signori di quelle terre, come già accade a Milano e a Mesocco, molto importante sarebbe poter fondare un Collegio a Coira, senza il contributo del Vescovo di questa città, in quanto molto gravato dai debiti <<…ma converrà che si faccia sotto nome del Vescovo et la sostentazione che se li darà da Nostro Signore sia secretissima>>.[68] <<La somma dunque di tutti i remedij si riduce a perseverar anco con la visita personale incominciata, in risvegliare, consolare, allettare, animare, et confirmare opportunatamente quei popoli con varij offitij paterni verso di essi…>>.[69] Maggior numero di sacerdoti italiani invece occorrerebbe nei paesi sudditi ai Grigioni, ossia in Valtellina e Val Chiavenna, ma non sono certamente posti ambiti a causa dei bassissimi redditi dei benefici, che dovrebbero essere integrati con provvisioni annue. <<Et per animar i sacerdoti a questa impresa, come Nostro Signore già nel tempo della peste corporale di Milano diede al Signor Cardinale di Santa Prassede piena facoltà di porsi valere, etiandio doppo la peste estinta dell’opera de sacerdoti regolari d’ogni ordine et anco secolari d’altre diocesi, anco senza consenso ne licenza die superiori, molto più si potrebbe spedire un Breve di simil facoltà amplissima per aiuto di quelli paesi nella peste spirituale dell’anime…>>.[70] I consigli continuano dicendo che sarebbe opportuno concedere indulgenze e grazie spirituali per spronare i sacerdoti ad accettare il governo di queste parrocchie; inoltre, lasciare ai loro posti gli apostati e i fuggitivi italiani meritevoli e che da molti anni hanno cura di quelle anime, anche se illegalmente, poiché conoscono bene la lingua e le usanze di quei popoli e potrebbero fare del bene in futuro se fossero sciolti dalle censure.
Il terzo punto, considerato il più difficile, poiché si tratta di introdursi in questi paesi e, con determinazione, mettere fine ad una situazione non più sostenibile dai Cattolici: emblematiche sono le situazioni in cui si trovano la Val Chiavenna e la Valtellina, dove i Cattolici sono pronti a tutto pur di essere liberi nella loro professione di fede, certamente la visita del Cardinale Borromeo sarebbe un grande incoraggiamento e sia i sudditi che i Signori sono disponibili ad aiutare con ogni mezzo la venuta del Prelato, che anche in questi luoghi avrebbe lo stesso successo avuto in Mesolcina. <<Potrebbesi aiutare anco di fuori quest’offitio con lettere di tutti i Prencipi maggiori del Christianesimo procurate dalli Nuntij di Nostro Signore come dall’Imperatore, Re di Francia, Re Cattolico, et forse Venetiani, ma senza manco delli Svizzari Catt.ci alli quali già ha mandato il Sig.r Card.le e in occasione simile, cioè per le cose di Valle Mesolcina, che quanto a Venetiani non si spera molto in questa materia, per i rispetti di Stato considerabili in loro: ma potrebbe N .S. tentar ogni via […] scrivendo anco per ciò Brevi oportuni, et commettendogli di non dar tutte provisioni che levassero, in mano del medemo Sig.r Card.le per valersene oportunatamente […] non sarebbe di poco aiuto anco l’andata del med.o Sig.r Card.le in così fatta occasione a trattarne ex professo etiam co ‘l nome di N. S. con le tre leghe, et con le comunanze de popoli de Signori. Con la qual occasione d’haver a trattar con loro passarebbe per quelle due Valli de sudditi dando quel calore che bisognasse a catt.ci almeno privatamente, quando gli trovasse impedimento da SS.ri di far offitij spirituali co’ popoliin publico, di che non possiamo ancora accertarci>>.[71] A questi rimedi, continua il documento, si possono aggiungere alcuni aiuti: i sacerdoti dovrebbero avere ampia autorità di assolvere dai casi riservati, specie quelli riguardanti l’usurpazione dei beni ecclesiastici e i contratti usurari, per riavvicinare i responsabili alla Chiesa. Colmare il bisogno di libri spirituali e per il catechismo da distribuire al popolo perché leggendoli si renderebbero conto dei propri errori; il Pontefice dovrebbe dare aiuti economici per ristrutturare le chiese fatiscenti. Di grande utilità sarebbe affiancare al Vescovo di Coira, poco pratico di governo, un Vicario esperto, in tal modo il Prelato avrebbe più tempo per fare visite pastorali ogni anno e assistere ai Capitoli.
Pur essendo evidenziate le cause della rovina spirituale e i mezzi per cercare di rimediare, ma con gli ultimi avvenimenti <<…si è venuto in cognizione, che non è espediente trattar con detti Grisoni per termini amorevoli, et civili, ma che più conviene trattar con maniera grave et risentita valendosi de mezzi che fossino timore o forza di farli condiscendere al giusto conveniente et honesto in favore de Catolici, per che i capi ch’hanno in mano e con i quali bisogna trattare, essendo per la maggior parte eretici, hanno per scopo l’allargar la setta et falsa religione loro, et estinguere et annichilare la religione catolica […] Gli altri poi che non sono al governo, oltre che non s’ha occasione ne commodità di trattar con loro, non hanno communemente tanta capacità di ragione et restano impressi dalli capi del governo e da predicanti… >>.[72] Anche i ministri francesi non hanno il coraggio d’intervenire efficacemente, nonostante i loro rapporti con i Grisoni, per cui non sono di nessun aiuto, quindi restano solo due modi: il primo è quello di trattare con loro con molta autorità, <<…tale ch’habbino occasione di temere che nel paese fra di loro o con Svizzeri confederati nasca discordia e disparere, sapendo essi che tutta la grandezza e potenza loro consiste nella unione e colliganza…>>.[73] Questo modo potrà giovare sia ai cattolici sia ai riformati. <<L’altro mezzo da usare con i Grigioni è la forza, poiché sono coscienti di andare contro le loro leggi e di negare richieste ragionevoli perché hanno perversa e corrotta volontà e, volontariamente, non concederanno mai cose per la conservazione del cattolicesimo…>>.[74]
In una lunga lettera non datata, ma certamente scritta nel 1584, poiché si parla della visita nella Valle Mesolcina effettuata “l’anno passato”, del Borromeo al duca di Terranova, Governatore di Milano,[75] troviamo corrispondenza con quanto descritto nella “Instruttione “ suddetta, nel documento sono ripetute le gravi condizioni in cui versano i Cattolici, in particolar modo quelli della Valtellina e della Valchiavenna, poiché la Visita Apostolica in Mesolcina è già avvenuta e, come scrive il Prelato, con grande successo: in soli quindici giorni <<…essa Valle, con molta facilità, e suavità, si è riformata tutta, e rinovata spiritualmente…>>,[76] gli apostati restituiti alla loro religione, i sacerdoti scandalosi cacciati e sostituiti con altri ligi al loro dovere e stato ecclesiastico, istituite scuole pubbliche cattoliche e una Casa per i Gesuiti, convertiti moltissimi eretici, tra i quali persone importanti e autorevoli, <<…et nell’occasione di disturbi ricevuti per conto della conversione, et del progresso loro spirituale hanno mostrati segni grandi di voler piu tosto perder la vita, che partirsi dalla obbedienza di Santa Chiesa catolica, protestando cio pubblicamente nelle chiese, et nelle piazze sia le donne et i fanciulli piccioli>>.[77] Nessun accenno ai roghi delle donne accusate di stregoneria.
Il Cardinale auspica, poi, che la Santa Sede attui tutti i mezzi possibili per quei popoli, affinché possano fare tutte quelle cose che permettono loro di vivere cattolicamente <<…et pur da poi che l’eresia cominciò a entrare in questi paesi, vi e legge et ordine universale di tutte tre Leghe, che ciascuno possa vivere liberamente nella religione catolica, o nella falsa setta dell’eresia>>.
Tornado all’antefatto della visita, già l’anno precedente, Carlo si era fatto nominare dal successore di Pio V, Gregorio XIII, Visitatore Apostolico di tutte le diocesi svizzere:.[78] Il documento è datato 27 novembre 1582.
Con una lettera del 19 giugno 1583 il Cardinale informa Monsignor Speciano[79] della visita che farà in alcuni luoghi della Svizzera, avendone facoltà per breve del Pontefice, ma gli chiede di poter avere l’autorità pro tempore di dare l’indulgenza plenaria nelle località che saranno oggetto di tale visita.[80] Da buon diplomatico annuncia la Visita Apostolica all’Imperatore, al Re di Francia e a Filippo II, affinché i loro ambasciatori persuadessero i Grigioni a non impedire la visita o a dare fastidio, molto chiara ed esplicita è la richiesta che Borromeo fa al Nunzio di Francia in una sua lettera del 21 luglio 1583: <<Sopra poi quello che le ha scritto il Cardinale di Como della visita mia in paese di Grisoni, nel primo luogo veniva uno officio di procurare da Sua Maestà per efficaci lettere ordine al suo Ambasciatore che tiene presso quei Signori Grisoni, che facci ogni opera con loro et ai signori medesimi lettere conformi perché in quei loro paesi et di loro sudditi, dove mi occorrerà di andare o passare e specialmente nella Valtellina, o in altre valli et parti massimamente di qua dei Monti non mi si impedisca ch’io possa liberamente esercitare tutti quegli officii spirituali et pastorali, che io voglio fare in queste parti et altri luoghi dove vado per ajuto et consolazione delle anime dei fedeli et honor di Dio>>.[81] Chiede la stessa libertà e sicurezza per i suoi collaboratori. <<Di questi officii parlo in questo modo, perché dire a loro che il Papa mi manda là con autorità sua a visitarli, troverebbe incontro più duro ed inespugnabile…>>.[82] Prosegue dicendo che è aspettato con ansia dai cattolici di quei luoghi, i quali hanno fatto supplica ai loro Signori affinché l’Arcivescovo non sia impedito nei suoi offici, ma il dubbio più grave <<…è in quei fuggitivi d’Italia, che fanno là ricorso, et vi hanno ogni lor rifugio, ché sono la fece del mondo, et per la maggior parte non solo heretici, ma apostati, et altrimenti anco criminosi et facinorosi huomini, et disperati, i quali, come si parla di cosa, che tocchi ad aiutare i catolici di quei paesi, et massime come vedessero per qualche principio di buono indirizzo, o riscaldamento spirituale, al che ne va in conseguenza che fra poco tempo essi ne siano affatto scacciati, perché quei paesi sudditi di qua da’ Monti sono delli dieci i nove catolici, arrabbieranno et tumultueranno tanto, et tanto cattivi officii faranno presso quei Signori Grigioni, che gl’indurranno facilmente ad impedire a me il progresso in queste opere, ed ai catolici di là il corso di quel bene che fosse cominciato, et ogni altra occasione di poter essere aiutati spiritualmente>>.[83] Carlo continua la sua lunga lettera dicendo al Nunzio di fare quanto prima ciò che gli ha chiesto per il bene di tutti, <<…ma avverta che sarà più profittevole e fruttuoso, se Sua Maestà lo farà come da sé, senza mostrare che sia stato procurato a Sua Santità, et molto meno da me, oltra che anche non gioverebbe a questo mio governo spirituale di Milano, che si sapesse di questi ministri Regii, che io abbia procurato questo aiuto a quei paesi per questa mia (sic) via forastiera>>.[84] Continua spiegando il fine della Visita Apostolica consistente in due punti principali: lasciare libertà di religione e di culto ai cattolici e non tollerare che gli esuli dall’Italia, soprattutto gli ecclesiastici eretici e condannati, trovino rifugio presso i Grigioni, un esempio di questo lo troviamo in una lettera delle autorità della Mesolcina diretta al Prelato del 17 dicembre 1582, in cui si parla di un certo Fra Benedetto, il quale dopo avere abbandonato il suo Ordine senza licenza dei superiori e si era rifugiato a Soazza, dove aveva continuato a prendersi cura delle anime positivamente. Il Consiglio Generale chiede al Borromeo una dispensa per regolarizzare la posizione del frate e lasciarlo come curato del luogo, come se fosse un prete secolare; ma in una lettera del 9 dicembre 1583, ossia dopo che Carlo ha effettuato la Visita e si è reso conto della situazione, rispondendo che terrà tra i suoi raccomandati anche Fra Benedetto, ma al momento è meglio che esso torni nel suo convento per <<…rimettere quello che ha perso di fuori…>>, perché per aiutare il prossimo è necessario che prima aiuti se stesso.[85]
Galles de Mont, Landrichter, ossia capo della Lega Grigia, scrive al Cardinale una lettera datata 28 agosto 1583, in cui dice che avendo partecipato al “bitag” dello scorso mese tenutosi a Coira, alcuni “predicanti” presenti avevano palesato il dubbio che con l’imminente venuta di Borromeo in quelle Valli temevano dei danni verso la loro religione, quindi pregarono i “Signori” di impedirgli tale passaggio. Galles de Mont, continua dicendo che perorà caldamente la Visita Apostolica, che <<…non solamente gli cattolici, ma ancora gli adversarij non solo s’accontentorno del passaggio ma eziandio ordinarno che gli Sig.ri Ufficiali della Valle gli facessero le debite accoglienze, et cortesie>>.[86] Il mittente continua sostenendo che, avendo parlato con Monsignor Stupano, ha appreso che a quella riunione dovevano essere mandate alcune lettere del Cardinale ai “Signori” presenti e a lui per ottenere il permesso scritto per la suddetta Visita, ma <<Ne essendone presentate alcune ne a detti signori, ne a me, acciò non potessimo provedere, come haveressimo provisto di meglio, et havendo visto l’instigatione delli predicanti, ho pensato, et tengo per securo, che le lettere sue non habbino hauto fedel recapito, ma siano venute alle mani d’essi adversari predicanti, o d’altri loro seguaci>>. Galles de Mont termina dicendo che non avendo ricevuto nessuna lettera non era stato possibile fare alcuna approvazione scritta, ma che sicuramente sarebbe accolto con tutti gli onori, però se l’Arcivescovo volesse la “licenza” scritta, l’avrebbe potuta ottenere nel prossimo “bitag” di San Martino prossimo <<…et con poca spesa si farà con bona espedittione>>.[87]
Nel mese di agosto 1583 giunse a Milano una delegazione svizzera con a capo il Ministeriale della Bassa Mesolcina Giovanni Battista Sacco e il collega Giovanni aMarca, Ministeriale di Mesocco con lo scopo di invitare personalmente l’Arcivesco a compiere la Visita Apostolica, ottenere l’invio di un inquisitore e accordarsi sulla venuta dell’Arcivescovo.[88] Da persona prudente, Carlo inviò prima Francesco Borsatto,[89] Gesuita e avvocato con il compito di preparare quei popoli alla Visita e per informarsi della legislazione della Valle, non volendo operare fuori della legge.[90]Borsatto partì e il giovedì 6 ottobre arrivò nella Valle Mesolcina, dove venne ricevuto dal Ministeriale Sacco, <<…avendo ordinato benissimo le cose del governo della chiesa sua, sotto la cura di Monsignor Audoano Lodovico Inglese suo Vicario Generale, che fù poi Vescovo di Cassano, in modo che non potevano patire detrimento notabile per l’assenza sua, determinò di dar principio alla detta visita, circa il fine di quest’anno 1583>>.[91]
La Valle Mesolcina, italofana, abitata fin dall’età neolitica, deriva il toponimo dal fiume Moesa che la percorre, fa parte del Cantone dei Grigioni (Svizzera), a Nord confina con la valle del Reno, a Est con l’Italia a Ovest con la Riviera e la Val Calanca, a Sud con il Canton Ticino, con cui comunica per mezzo del Passo di San Bernardino; due alte catene montuose ostruiscono la Valle, limitata ad ovest dalla Valle Calanca e ad est dalla Valle del Lirio. La catena montuosa orientale segna il confine tra la Svizzera e l’Italia e si prolunga fino a formare i monti nel luganese, prendendo il nome do Catena Mesolcina. Alle popolazioni originarie si sovrappose la dominazione barbarica e il passo del San Bernardino (Mons Avium) divenne una delle principali vie di comunicazione tra la Pianura Padana e l’altopiano retico.[92]
La Mesolcina fu una delle prime Valli che aderì al Cristianesimo, anche se non siamo a conoscenza dell’evangelizzazione, che senza dubbio proveniva dall’Italia del Nord, prima con l’evangelizzazione romana fino al secolo V, poi con quella merovingia-carolingia, secondo il Vieli ciò fa supporre che il Cristianesimo sia stato accolto privatamente, più tardi professato pubblicamente senza persecuzioni e martiri.[93]
Da tempo remoto la Valle dipese, forse anche politicamente, dal Vescovo di Coira e che da questo viscontato sia derivata la signoria dei Sax (Sacco), proprietari fondiari nella Resia san gallese, durante il secolo IX, divenuti poi visconti in Mesolcina, ma nel XII secolo non compaiono i Sacco della linea primogenita, ma quelli del ramo dei Sax, il cui capostipite fu Alberto deTurre de Sacco, fedele al Barbarossa e fratello di Rainero, Vescovo di Coira. Il figlio di Alberto, Enrico fu l’iniziatore della potenza della casata, quando sotto Fedrico II gli viene confermato il possesso della Mesolcina, della Valle superiore del Reno, quella di Blenio e anche l’avogadria del monastero di Disentis con l’Ursera, affermando in tal modo sotto il diretto controllo imperiale i valichi di San Bernardino, Lucomagno e Gottardo. Tutto ciò indusse i Sacco a mire più vaste: Bellinzona e lo sbocco nella pianura, mettendo però i Signori della Mesolcina in contrasto con il partito guelfo: Enrico di Sacco lascia l’Imperatore e, nel 1242, occupa Bellinzona, che nel 1249 tornerà alle dipendenze di Como, come capo dei guelfi, insieme con Enrico d’Orello di Locarno. Dopo la morte di Enrico, abbiamo il declino della famiglia, a causa della divisione in vari rami.
Nel 1480 Giovanni Pietro de Sacco, oppresso dai debiti e detestato dal suo popolo, vendette la Signoria con tutti i suoi possessi e diritti al conte Gian Giacomo Trivulzio per la somma di sedicimila fiorini, il nobile milanese divenne il nuovo Signore della Mesolcina e nel 1496 strinse un’alleanza con le Tre Leghe, sancendo in tal modo l’appartenenza della Mesolcina ai Grigioni. Tre anni più tardi Trivulzio soccorse i Grigioni minacciati dall’esercito imperiale di Massimiliano d’Austria, contribuendo alla vittoria della Lega. Gian Giacomo morì nel 1518 e a lui successe il nipote Gian Francesco, giovanissimo e debole di carattere, che col tempo fu privato dell’autorità e nel 1256 le Tre Leghe fecero demolire il castello di Mesocco, obbligando il giovane a ritirare le sue milizie, la Signoria dei Trivulzio finì nel 1549 quando Gian Francesco firmò un trattato con i rappresentanti della Mesolcina e della Calanca, per il quale rinunciava a tutti i suoi diritti feudali in cambio di ventiquattromilacinquecento scudi d’oro, che dopo una prima somma, il resto venne pagato a rate da tutti i comuni del Moesano: fu la fine del regime feudale e l’inizio di una libertà ottenuta senza violenze: il governo fu assunto dalle autorità locali e il potere legislativo esercitato dalla Centena,[94] quello esecutivo dal Consiglio generale di valle e quello giudiziario dal Tribunale dei Trenta Uomini che si radunavano a Roveredo o a Mesocco.[95]
Soazza e Mesocco con “motu proprio” entrarono a far parte della Lega Grigia nel 1480, successivamente (1496) anche il resto della Mesolcina con la Val Calanca si unirono alla suddetta Lega. Già dalla Signoria dei de Sacco la Valle era divisa in due Vicariti quello di Mesocco e quello di Roveredo, mentre amministrativamente era formata da tre squadre o circoli: quella di Mesocco, la squadra di Mezzo, che comprendeva Soazza, Lostallo, Cama, Verdabbio e Leggia e la squadra di Rovereto con Grono, Roveredo e San Vittore. La Valle Mesolcina non aveva il vincolo di sudditanza politica, in quanto Comungrande, ossia una comunità delle valli, entrate a far parte come componente paritario nella Federazione delle Leghe, quindi libera nelle proprie decisioni, come la Valle di Poschiavo, che al tempo faceva parte della Diocesi di Como e quella di Bregaglia che insieme alla Mesolcina appartenevano a quella di Coira, ma, diversamente dalle altre, la Mesolcina era ed è anche oggi quasi totalmente cattolica.[96]
Nel 1555 veniva stipulata la Pace di Augusta tra cattolici e protestanti, in cui fu sanzionato il principio del “cuius regio eius religio”, riconoscendo in tal modo la libertà religiosa solo al principe, non al popolo. Se la maggior parte della Diocesi milanese era sottoposta a Filippo II, il cattolicissimo Re di Spagna, molte pievi delle valli svizzere erano terre di confine e quando oltre il San Bernardino scoppiò la Riforma queste vennero a contatto con i protestanti delle varie dottrine, che si diffusero rapidamente. Le autorità dei Cantoni protestanti e di quelli cattolici erano fermamente decisi a mantenere la loro tradizione di autonomia stabilita nelle Diete di Ilanz del 1524 e del 1526, dove era stata proclamata la libertà di culto nella Repubblica delle Tre Leghe. Anche la Mesolcina risentì delle condizioni civili, religiose e morali di questo periodo storico: <<…i delitti di sangue e i reati contro il buoin costume erano diventati tanto frequenti e tanto gravi che durante la dominazione dei Trivulzio il principe e la centena s’illusero di mettervi argine, emanado spesso capitoli criminali minaccianti pene severissime contro chi portava armi, cercava liti, assaliva e feriva il prossimo o dava scandalo fornicando persino – ciò che era più ripugnante – “in gradi bus prohibitis cum parenti bus”…>>.[97]
Il clero era ignorante, molti preti sapevano a stento leggere e scrivere, gli aspiranti al sacerdozio, rari, tutti appartenenti a famiglie facoltose, avevano una formazione molto superficiale, anche per la mancanza di seminari, la disciplina e la moralità lasciavano a desiderare e troppo scarsi erano i contatti col Vescovo diocesano di Coira, il quale non aveva l’obbligo delle Visite pastorali. Viste le condizioni generali di vita, la Riforma fu vista come un rinnovamento sociale, un’illusione in un futuro migliore e forse per questi motivi fu abbracciata da molti abitanti della Valle.[98] Vieli sostiene che nonostante tutto in Mesolcina non ci furono né polemiche né esiti pubblici sulle nuove dottrine, nessun ecclesistico si proclamò palesemente favorevole alla Riforma, ad eccezione del comune di Mesocco, più esposto geograficamente alle infiltrazioni provenienti dalla Valle del Reno, dove fu creata una comunità evangelica.[99]
Nel 1549 arrivò a Mesocco il locarnese Giovanni Beccaria, cacciato dalla sua città per apostasia, nato nel 1510 circa, dopo gli studi di teologia, aveva aderito alla fede riformata, istituì una scuola dove insegnava ai figli delle famiglie riformate, più tardi il Sinodo retico lo accettò tra i propri ministri e fu nominato parroco riformato di Mesocco.[100] Questo fu solo un episodio, ovviamente dopo Giovanni Beccaria arrivarono in questi territori altri protestanti e non mancarono i neofiti tra le famiglie del posto. Nel 1556 una numerosa comunità riformata di Locarno avrebbe voluto stabilirsi in Mesolcina, ma i cinque Cantoni cattolici d’accordo con la Lega Grigia vietarono il loro stanziamento, la comunità si diresse a Zurigo, facendo tappa a Roveredo a causa dei rigori invernali.[101]
A causa delle pressioni che la Lega dei Grigioni aveva esercitato contro i riformati in Mesolcina ci furono grandi attriti con i protestanti della Valle del Reno e poco mancò che ne scaturisse una vera lotta armata: era il 1560. Con la Dieta di Coira venne stabilito che la Lega Grigia tollerasse la Riforma nella Valle e furono assegnate due chiese di Mesocco ai riformati perché potessero celebrare il loro culto.[102]
<<Sebbene la Mesolcina non avesse abbracciata la riforma, come si ha veduto nel Capitolo precedente, i suoi parti tanti non mancavano però di mantenere con segretezza negli animi quello spirito d’innovazione, che dai pergami veniva con artificio inculcata anche da quei pochi preti vallerani, i quali bramavano di vicere nella licenza. In simili disordino di religione, la popolazione era divenuta per lo più superstiziosa e di corrotti costumi, per cui necessitò più volte che la Regenza di Valle si riunisse espressamente per cercar di provvedere a tali inconvenienti; ma tutte le misure che si adottavano, riuscivano sempre infruttuose, anzi la demoralizzazione di più in più andava crescendo.
La fama di S, Carlo Borromeo allora Arcivescovo di Milano eccitò il Consiglio di Valle a spedir a quel Cardinale una deputazione per consultarlo e supplicarlo del suo aiuto sullo stato deplorabile in cui si trovava la Mesolcina.
Nel 1583 in agosto fu tenuto un apposito consiglio che nominò alcuni principali del paese per far l’ambasciata, i quali arrivati in Milano, furono dal venerabile Prelato accolti colla massima amorevolezza, e promise loro con benignità che entro quell’istess’anno si sarebbe portato in persona nella Mesolcina per ajutarli e provvedere a quanto desideravano; tanto più ch’egli era benissimo informato della demoralizzazione e del desiderio di riforma religiosa che esisteva nella Mesolcina come in tutte le vallate contigue alla sua Diocesi, per cui impiegava l’instancabile suo zelo per impedire l’avanzamento degli scismi ed eresie nel suo dominio spirituale, col portarsi in persona ove il bisogno l’esigeva…>>[103]
Da una lettera di Giovan Battista Sacco al Cardinale, datata 29 luglio 1583, veniamo a conoscenza che il Ministrale chiede che sia inviato anche un inquisitore per procedere contro i sospettati di stregoneria: <<…fargli memoria a proteggere d’un Inquisitore di queste malefice, quale esperto et idoneo, accioche quando s’appresenterà l’occasione, sappiamo dove raccorsi à torlo…>>,[104] ossia dove rivolgersi per averlo in caso di bisogno. In una lettera del 4 ottobre 1583 che Carlo scrive a Roma al Cardinale Savelli,[105] in cui dice che manderà Francesco Borsatto a Rogoredo: <<Quanto alle cose di Rogoredo, et parte contorno hora si comincerà darle qualche buon principio, havendo io fatta risolutione di mandare là di presenteil Dottore Borsato, che già alcuni dì sono si trovava qui meco: la quale andata è stat da me incaminata in occasione della istanza fattami novamente a nome di quelle Communità da uno Ambasciatore et altri principali, tutti catolici, et di auttorità di quei paesi, che si ritrovano qui a Milano, perché io le dessi uno Inquisitore a processare molte persone per conto di streghe.La quale andata è stata risolta da me in occasione della instanza fattami nuovamente a nome di quella comunità da uno ambasciatore et altri principali tutti catholici et di autorità di quei paesi, che si ritrovano qui a Milano perché colà dessi uno inquisitore a processare per conto di Streghe. L’ho dunque deputato con soddelegatione ampla delle altre mie facoltà in quei paesi, et sono partiti insieme questa mattina. Essi mostrano buona volontà, et desiderio dell’aiuto di quelle parti, et di dare ogni possibile favore, et calore per promovere le fatiche, et diligenze, che piglierà il detto Monsignor Borsato per il servizio, et bene spirituale del publico>>.[106] Francesco Borsato fu giudicato, dal Borromeo, l’uomo giusto per svolgere l’attività d’inquisitore, poiché occorreva, come riferisce in una lettera sempre al Savelli del 18 agosto dello stesso anno, una persona prudente e moderata, perché la giustizia secolare era molto più spietata di quella ecclesiastica,specialmente in casi di “stregherie”, Borsatto era considerato dal Borromeo anche come “precursore” della sua visita nella Valle Mesolcina, ma appena libero da un impegno molto importante,[107] lo avrebbe raggiunto con un predicatore e altre persone, <<Si manda là con pretesto dell’officio della Santa Inquisizione contra quelle streghe et nel medesimo tempo comincerà a poco a poco fare qualche officij spirituali>>,[108] da quanto scrive, le sue intenzioni non sembrano quelle di sterminare le streghe e gli eretici, ma piuttosto riportare queste persone sulla giusta via con esercizi spirituali. Il Cardinale viene assicurato dagli ambasciatori che non avrà nessun impedimento nell’attuare tutto ciò che si è prefissato, anzi propongono e fanno <<…instanza, che si eriga là un Collegio, o Seminario, assignandovi N. S.re reddito sufficiente, et per questo afferiscono essi di dare una buona casa, commoda, et conveniente, io che vedo quanto fondamento, et commodità spirituale ne risultaria universalmente; mi sono grandemente consolato di questa prattica, massime che mi dano speranza, che anco dà Padri heretici di tutte le Leghe si mandaranno molti figlioli allenarsi in quel Collegio […] In tutto il paese di Grisoni, parlo di SS.ri, come questo, non de’ sudditi, come Chiavenna e Valtellina, non vi è si può dire Maestro di Lettere>>.[109]
Da questi e da altri documenti studiati, sembrerebbe non chiara la distinzione tra eresia e stregoneria, in quanto i due termini vengono usati per indicare sia gli eretici che le streghe,sembra che i confini tra magia e stregoneria non siano molto delineati, come ad esempio nel seguente passo che troviamo nell’opera del Possevino, in cui dice che Carlo <<…scoprì quasi tutto quel paese infettato di streghe e stregoni, e ne ridusse a penitenza più di cento, ma da dieci, o in circa donne, vecchie per lo più le quali havevano commessi homicidije notabilmente danneggiato il paese, et erano quelle che seco conducevano le pute quasi fanciulle, cō terrore delle altre, al braccio secolare>>.[110] Mentre in passo successivo troviamo che il Cardinale: <<…non si sdegnava di mettere molte hore in ragionare alle volte con semplicissime, mà ostinatissime, et ignorantissime donnicciole heretiche, ricevendo anco alle volte da esse risposte assai indegne…>>.[111] Ancora nella relazione, relativa al 16 novembre 1583, del Gesuita Achille Gagliardi, al seguito del Borromeo durante la Visita: <<Questa misera Provincia tutta ora in mano di Apostati sfratati che servivano da Pastori, et seminavano alcuni mala dotrina, altri col male esempio di vita, et con la larghezza della continenza sua, e con gli altri fabbricavano la perdizione loro et di tutto il paese, nel quale (ben occultamente) già cominciava a entrare in molti la heresia. Il Proposito capo della Chiesa ora capo delle Streghe che vi son qui molte et in più luoghi ogni settimana con gran gente havevano, con quelle solite abominazioni del loro ballo, comercio col diavolo con uccisioni d’animali, d’huomini, et massime fanciulli per mezzo di certa polve fatta di rospi, et ossa di morti et altri orrendi peccati>>.[112] Questa relazione che sembra riprendere molto dalle antiche pratiche contadine, ci rende l’idea della fervorosa fantasia del Gagliardi, ma anche di una mentalità che non era diffusa solo nel popolo, nelle persone semplici ma anche in persone di cultura e di ceti sociali più elevati.
L’Autorità romana fin dal secolo XII cercò di travisare la natura essenzialmente benefico, positivo della “Società di Diana”, <<…infatti la credenza nelle streghe malefiche, operatrici di atti criminali che danneggiavano uomini, animali e beni materiali, si sovrappone a quella delle seguaci di Diana, dea appunto dei parti e della fertilità. Successivamente i demonologi del XV secolo si adoperarono a dimostrare la reale presenza diabolica nell’antico rito “e la consapevole complicità delle donne che vi partecipavano, conferendo a tali credenze quell’unità e quell’organicità che avevano perduto nel corso del tempo” (M. R. Lazzati)>>.[113]
Nel 1326 circa, Giovanni XXII emanò la bolla “Super illius specula” ponendo le basi per la relazione strega uguale eretica, che si allontanava sempre di più dal “Canon Episcopi” del secolo IX, in cui la vera superstizione consisteva nella credenza del volo notturno. Con la bolla di Innocenzo VIII “Summis desiderantes affectibus” del 1484 avviene la fusione della stregoneria con la “pravitas haeretica”, dando il via alla caccia alle streghe, che per quasi tre secoli fu associata alla storia occidentale.[114] <<Forse la stregoneria serviva bene a dare un volto locale alla paventata intrusione forestiera degli eretici, la cui estensione era bruciante. Comunque il principio era codificato. In questo contesto va esaminato il Borromeo […] Non è possibile un’analisi della posizione dell’Arcivescovo Carlo riguardo alle manifestazioni di religiosità popolare o alle abusive espressioni magico.religiose senza tener conto del Decretum tridentino De invocazione, venerazione et reliquiis sanctorum, et de sacris imaginibus. E’ indiscussa la fedeltà di Carlo Borromeo alle disposizioni tridentine; del resto ciò rientrava nella struttura mentale essenzialmente giuridica del Borromeo: senza la quale non ne comprenderemmo la personalità>>.[115] Da un attento esame degli editti, delle Visite pastorali, dell’epistolario e degli “Acta Ecclesiae Mediolanensis” riusciamo ad “entrare” un poco nella mentalità del Presule, ma che si tratti di culto o di magia e di abusi, va considerato che chi studia oggi il periodo in cui opera Carlo possiede un’ottica completamente diversa da quel tempo, <<…attenta non solo ai dati storico-religiosi, ma anche a quelli folkloristici, antropologici, etnologici>>.[116] Ma forse la vera eresia non comincia dove c’è superstizione?
Borromeo, comunque, fu molto rigoroso verso gli abusi di devozione popolare e in una lettera inviata all’Arciprete di Monza del 22 aprile 1567 troviamo un esempio di tale rigore: sembra che molta gente accorresse in un luogo tra Milano e Monza perché alcuni sostenevano di avere visto la Madonna apparsa sopra gli alberi del posto, quindi il Prelato incarica l’Arciprete di fare un sopralluogo e con “diligenza” far tagliare quegli alberi e demolire eventuali costruzioni fabbricate per questa circostanza, perché non voleva che il popolo fosse ingannato con simili illusioni.[117] Durante la peste del 1576, detta peste di San Carlo, l’Arcivescovo da una parte proibisce varie cose per evitare il contagio, vieta di toccare le reliquie, esorta cautela verso le immagini e le donazioni, ma poi tollera le immagini sacre, anzi esorta che tali immagini, nel caso in cui venissero rimosse, dovrebbero essere sepolte sotto i pavimenti delle chiese o nei cimiteri: ciò fa pensare che esse abbiano acquistato un carattere sacro da ostacolarne la distruzione.[118] In conclusione si può dire che le frontiere tra la pietà popolare, la superstizione e la magia siano spesso molto precarie.
Munito di una subdelega, Borsatto partì quella stessa mattina e il 6 ottobre arrivò in Mesolcina, ricevuto dal Ministrale Sacco, l’inquisitore Gesuita fece convocare la Centena per il giorno 9 a Lostallo, per dare pubblicamente l’autorizzazione ai suoi procedimenti giudiziari, alla venuta del Cardinale ed agli eventuali provvedimenti che sarebbero stati presi. Questo fa capire quanto il Borromeo si muovesse con i “piedi di piombo” e nella più stretta legalità. Il 10 ottobre l’inquisitore spedisce una relazione al Presule, in cui lo mette al corrente delle decisioni prese dalla Centena e gli illustra la situazione religiosa della Mesolcina: <<Cominciarò hora ad attender à questi processi che riescono cumolo grande di persone et cause>>,[119] certamente i processi si riferiscono alle persone accusate di stregoneria; poi dice che la prossima domenica avrebbe cominciato a comunicare il popolo e dopo pranzo avrebbe cominciato <<…a introdurre la Dottrina cristiana, havendone in estremo tutti bisogno, non sapendo per la maggior parte quasi forse il segno della santissima Croce>>.[120] I messali erano vecchi e gli arredi sacri erano tanto sporchi da non potersi vedere, per cui dispose che fosse provveduto subito a tutto ciò che era necessario per l’altare e per officiare <<…poi che nella visita non si avrà da far riforma, ma crederò una forma nuova, tanto ogni cosa si trova in malo stato, et senza preti et chi le pasca, che poi sarà cura di V. S. Ill.ma, be si dirò che in questa valle non vi sono molti heretici scoperti, ma si ben disordine, et diffetti assai importanti, per quel ch’io scopro>>.[121]
In un documento scritto di pugno da Francesco Borsatto, troviamo una specie di promemoria comprensivo di dodici punti, sulle facoltà del Crdinale da chiedere al Pontefice ed all’Inquisizione a Roma in vista della visita nella Valle Mesolcina, tale documento non è datato e vi sono presenti alcune cancellature che noi riportiamo, ciò farebbe supporre che si tratti della la minuta della lettera che poi verrà spedita alla Santa Sede.
Le facoltà che Carlo vuole ottenere dal Papa servono per metterle in atto durante la Visita in Mesolcina: andando a visitare questi luoghi dei Grigioni può trovare eretici che negano la Trinità, la verginità di Maria, la morte per la Redenzione, i quali non potranno essere ammessi all’abiura, ma condannati alla pena di cui alla Costituzione Apostolica di Paolo IV dell’anno 1555.[122] Il Borsatto, quindi, chiede ampie facoltà per il Cardinale e per altri da lui designati e le specifica, come detto, in dodici punti: <<Andando l’Ill.mo et R.mo S.r Car.le S.ta Prassede ne paesi de svizzeri et Grigioni, tra quali vi possono esser heretici, che negano la Santiss.ma Trinità, divinità di Christo, la conceptione de Spirito Santo, e la morte per la redenzione, over la virginità di Maria, quali per Constitutione Apostolica di Paolo IIII sotto l’anno 1555 non potranno esser admessi all’abiura la prima volta, ma condannati nella pena di detta Constitutione. Et per il più se vi ricorrana sacramentarij, et oriondi d’Italia, et anco de forastieri, et che vi stanno, et che vi vanno alle volte, et forsi che hanno una et più volte abiurato, et quasi potriano venir al premio della Chiesa, essendo semplicemente admessi senza abiura publica, o privata formale, et quali ancor per il più sono quelli che sollevanoi terrieri per poter vivere. Si mette in consideratione a Nostro Signore che quei S. Ill.mi del supremo tribunal della S.ma Inquisitione in Roma, che non saria farsi male a dar per breve particolar facoltà a detto Ill.mo S. Cardinale S.ta Prassede, che potesse per se o altri da lui elletti, in….endo alle altre facoltà, et oltre quelle, per le cose infrascritte.
Prima potesse admetter a suo arbitrio al premio di S.ta Chiesa ogni heretico anco sacramentale et de sudetti di qual si voglia sorte benche meritasse la pena dell’ultimo supplicio la prima volta, et li oriondi d’Italia et apostati si de religiosi, come pretti, et secolari,
Secondo potesse admetterli, et reconciliarli alla S.ta Chiesa Romana benche havessero una et più volte abiurato, et fosse stato longissimo tempo in heresia.
Terzo se ben fossero stati predicatori, et instruttori d’altri, stampatori, et authori o compositori d’heresie, o libri heretici.
Quarto potesse reconciliarli o con abiuratione publica, o privata, et anco parendoli spediente senza abiuratione formale, mentre però si facesse rogito per il notaro della reconciliatione, absolutione, abiuratione, d’ogni heresia ch’havesse tenuto, et penitenza salutare in presenza de due testimonij, col descriver però il nome, cognome, patria, stato, et qualità dell’heretico penitente, acciò per ciascuna non s’havesse a far longo processo, scritture et abiuratione formale, che fossi in questo modo molti potriano ritornar, et dimandar misericordia et aiuto.
Quinto facoltà d’assolver liberamente in foro fori da ogni irregularità et combatta per qual si voglia causa et heresia come di S˜. senza sospenderli o tenerli sospesi a tempo ad arbitrio di S.S. Ill.me secondo li parerà spediente, o almeno authorità di assolver quei ch’hora vivono cattolicamente, mentre però tra tempo da esser limitato da S.S.Ill.me vengino all’obedienza de suoi superiori, et che ha tanto possino celebrar, et trattar i suoi negotij per ritornar in Italia et paesi catolici.
Sesto che le gratie concesse da N. S. con lettere delli Ill.mi S.ri Cardinali Savello, Maffeo et Como, fossero tutte distese nell’istesso breve prevalessene bisognando, et mostrar a quelle genti cosa ordinaria et autentica secondo il popolo ricerca: primo di poter sudelegar ad ogni persona perita sacerdote et ecclesiastica le medeme facoltà o tutte o perte secondo le parerà conveniente. Secondo che si possa trattar per S.S.Ill.ma et altri da lei haver a esser nominati, o che la compa gnargno (non capibile) liberamente ogni cosa publicamente et privatamente con ogni heretico et persona di quei paesi senza incorso di pena alcuna, cercando però di scansar più che si potrà la loro conversatione.
Settimo che ritrovandosi qualche religioso apostata, pentito de suoi errori, et ritornato con sincerità di cuore, potesse assolversi in foro fori, et foro poli, et per l’irregularità et heresie, con restituirgli anco alla religion sua et suoi monasteri, non ostando qual si voglia cosa in contrario con quel modo però penitenze o pene tempo et conditioni, che giudicarà bene S.S.Ill.mo considerata ogni circostanza et qualità del penitente.
Ottavo trovandosi alcuna persona che volesse solamente in foro poli confessare i suoi errori et heresie, possa assolversi et admettersi massime s’allegharà causa o timor del confessare le heresie et errori in foro fori, dovendo star et habitar in quei paesi, et purche sia oriundo di quelle terre. (a sinistra a piè di pagina, ossia c. 257r., : “Questa facoltà mi par che sia già concessa per Breve apportato con l’alterationi? In foro fori per giuramento)
Nono auttorità d’assolver ogni officiale S.r o Magistrato di quei paesi ch’havesse tolto o usurpato beni, denari, o frutti, o mobili della Chiesa, ovvero ingeritosi in cause ecclesiastice, et di quelle cavatene pene et utilità, rimettendo a S.S. Ill.ma il far restituire il mal tolto, o commutarlo o dargli altra pena o penitenza considerato il stato et conditione di quel tale.
Decimo possi terminar ogni sorte di lite di qual si voglia cosa o persona di Chiesa o mossa o da moversi a qual giudice ecclesiastico possa appartenere anchor che prendesse lite nanti tribunali ordinarij o altri giudici, et senza il consenso di qual si voglia persona.
Undecimo non saria male che S.S. Ill.ma havesse facoltà a consolatione delli Catho.ci che vi si trovano nelle Città, Castella e luochi principali, di conceder in qualche Chiesa, a qualche altare Indulgentia plenaria ogn’anno in un certo giorno, a quelle persone d’ogni sesso che contrite e confesse comunicassero et pregassero per l’unione de principi, essaltationi di S.ta Chiesa et estirpatione d’heresie.
Duodecimo facoltà di ordinare estra tempora et diebus continuus etiam non festivis in quelle terre però, et di quei preti che S.S. Ill.ma giudicarà ispediente convertirsi per il bisogno delle Chiese et contento delli catolici che vi sono con auttorità di dispensare super statem (a sinistra in basso: “Questo poco sarà bisogno, ma non può nocere>>.[123]
Carlo Borromeo partì per la Mesolcina il 9 novembre 1583, del suo seguito facevano parte anche il Gesuita Achille Gagliardi,[124] il Francescano Francesco Panigarola,[125] entrambi molto validi nella predicazione: Panigarola particolarmente esperto anche nella confutazione delle tesi di Calvino, il Canonico Arciprete Ottavio Albiati (Ottavio Abbiate Forerio) e il suo Segretario Bernardino Morra.[126] La visita non si presentava come un’impresa facile a causa di problemi religiosi e politici, da non sottovalutare poi il periodo invernale molto rigido, che, in quei paesi, rendeva gli spostamenti difficili ed anche pericolosi, in una lettera da Roma, del 5 novembre, del Cardinale Speciano a Carlo si legge: <<Questa sarà in risposta della lettera di Vostra Signoria delli 28 del passato, et credo che la ritroverà occupata assai nelle faccende de Grigioni, nelle quali qui si ha grande opinione che Vostra Signoria Illustrissima sia per fare, con l’aiuto del Signore, del frutto assai; sebbene alcuni di questi Illustrissimi dubitavano che non sia sicuro il fidarsi intieramente di andar così alla libera in quei paesi, et al pur Cardinali che vi sono stati hanno paura grande ch’ella non patisca notabilmente per la neve et freddi, nelli quali molti ogni anno pericolano. Ma io spero ch’Iddio benedetto le assisterà in ogni cosa, et a questo fino qui se ne faranno orationi da persone di molto spirito>>.[127]
Da una dettagliata relazione di Gagliardi del 16 novembre 1583, veniamo a conoscenza che durante la Visita a Tessarete, lui stesso resta stupito dall’affluenza del popolo accorso per le confessioni, le comunioni e per la Cresima, ma soprattutto per come le persone erano bene istruite nella dottrina e per la loro onestà di vita. Il Prelato, la sera dell’undici novembre, fu ospitato nella casa di Bernardino Ruscone <<…alle Taverne, ove oprò un miracolo…>>[128] : chiese al padrone di casa di conoscere i suoi sette figli, ma al cospetto dell’Arcivescovo ne vennero solo sei, mancava la figlia maggiore di circa tredici anni, la quale era andata a cercare un vestito adeguato per comparire davanti a un personaggio così importante, ma nel momento in cui fece l’atto di prendere il vestito da una grossa cassa, il coperchio <<…fatto d’un assone grandissimo di noce con cornice ferrea all’intorno qual era sufficiente per il sol peso spezzare una pietra, e colse sotto tutt’e due le braccia e tramortì. La servente che era andata a chiamarla corse al padrone scapigliata piangendo che la figlia era morta>>.[129] Il padre accorse nel luogo dell’incidente, prese la figlia in braccio e questa aprì gli occhi e sorridente disse: <<Pà, non mi sono fatta nessun male, quel gentiluomo vestito di rosso qual è in stufa mi ha tenuta lui et mi ha salvata>>.[130]
Borromeo proseguì la sua visita facendo tappa nel monastero degli Zoccolanti a Bellinzona, per proseguire poi nella Valle Mesolcina, fu a Rogoredo il 12 novembre, dove rimase fino al 17, ispezionando anche i luoghi circonvicini. Dalla relazione di Padre Gagliardi veniamo a conoscenza della povertà di questi luoghi soggetti ad apostati che fungevano da Pastori, predicando dottrine eretiche e dando cattivi esempi di vita, trascinando gli abitanti di Rogoredo e dintorni: <<Il Proposito capo della Chiesa ora capo delle streghe che vi sono qui molte et in più luoghi ogni settimana con gran gente havevano, con quelle solite abominazioni del loro ballo, comercio col diavolo con uccisione d’animali, d’huomini, et massime fanciulli per mezzo di certa polve fatta di rospi, et ossa di morti et altri orrendi peccati. Tutto il paese era pieno d’usure, vi sono moltissimi matrimonij illeciti per essere in gradi prohibiti, vi sono nemicitie tra principali, per le quali ne sono seguiti grandi homicidij, vi è estrema ignoranza, per non essere chi insegni né costumi, Né dottrina Christiana, né pure un poco di grammatica, si atende à crapula et buon tempo. In questo stato habbiamo ritrovato questo paese, al quale è piaciuto a Dio dare la gratia di questa visita con molta benedizione>>.[131] Il quadro dipinto dal Gagliardi non era certamente roseo, quindi per rimediare a tante miserie, Carlo iniziò a digiunare e a mangiare solo pane ed acqua e impose al suo seguito di nutrirsi solo con pesce; le giornate erano molto laboriose e poco il tempo per riposare: la mattina presto, prima il Panigarola poi anche il Cardinale cominciavano a predicare, e dopo la Messa c’erano le confessioni fino alle diciannove, dopo la cena <<…s’attende a negotij per due hore […] Alle 22 hore di casa il Sig.or Cardinale va in Chiesa et si cantano le litanie et si fa la dottrina cristiana, insegnando, et domandando ai fanciulli il Sig.or Cardinale stesso, il Panigarola, et io le cose necessarie alla salute…>>,[132] senza, tuttavia, fare riferimento alle eresie, perché era stato ritenuto opportuno agire in tal modo per ristabilire il popolo nella fede, infatti Gagliardi dice nella relazione che la Chiesa era sempre piena di persone attentissime. <<La sera sino a 3 hore e più di notte il Sig. Cardinale ci tiene in consulta, ne si può cenare d’ordinario per l’altre occupazioni sino alle 5 hore di notte>>.[133]
Il primo giorno vennero comunicate 500 persone, il secondo 500 su una popolazione di poco più di 1500 anime. Una parte degli usurai fecero promessa di restituzione, l’altra parte si impegnò di seguire gli ordini del Prelato: <<…per ricevere, et usare nell’avvenire contratto lecito de censi, o simili. Dei censi ne resterà forma autentica per uso di tutto il paese […] Quanto all’heresia si sono riconciliati non pochi alla S.ta Chiesa, tra quali i principali di tutta la Valle che molt’anni erano stati in errore sedotti in Germania l’uno dal Vergeri, l’altro da Pietro Martini. […] Quanto alle streghe il prevosto con 15 o 16 di queste male donne sono state poste in prigione et sene farà una severa giustitia di fuoco, et tutte l’altre che segretamente erano macchiate di questo vitio, senza enorme successo criminale, ch’erano molte si sono ridotte a penitenza, con segno di quella>>.[134] Nella sua relazione, Gagliardi non parla molto delle “streghe” si limita a quanto riportato. Ma in una lettera dell’8 dicembre al Cardinale, Padre Carlo, gesuita al seguito di Carlo Borromeo durante la visita in Mesolcina, dopo avere espresso il successo della visita, così scrive: <<Lunedì passato, come quella haverà inteso, furono condotte alla morte quattro di quelle donne incarcerate. La qual fu di questa maniera. Fu fatta una grande catasta di legne, fascine et paglia; et havendo il carnefice strettamente legata ciascuna di loro sopra una tavola da per sé con fune, la buttò sopra della catasta con la bocca in giù, et subito si diede il fuoco intorno intorno, onde si vidde una fiamma horribile, che tutte le loro ossa et membra ridusse in cenere.Prima io riconcilia ciascuna stando già sopra le tavole distese, et ligate, et Monsignor Stoppano et altri due Reverendi insieme le aiutammo nel Signore con li debiti conforti. Né potrei abbastanza esplicarle con quanta contrizione, et prontezza han preso questo supplicio, rassegnate in Dio con profondo riconoscimento, et pentimento dei lor peccati, essendosi confessate et comunicate con gran devotione, facendo intiera oblatione delle anime, et della vita loro al Creatore Dio. Era quella campagna piena di gran popolo, et tutti con altissima voce gradavano Gesù, et si sentivano ancor esse gridare, et invocare quel santissimo nome in mezzo delle ardenti fiamme, tenendo ciascuna al collo le lor corone con l’ave Maria benedetta. Io ho gran speranza della salute di tutte per li chiari segni, che si son visti in loro, di buona contrizione>>.[135] Il Cardinale risponde da Bellinzona, esprimendo la sua consolazione per la conversione in extremis delle condannate, vedendo nel loro comportamento una speranza per la loro salvezza eterna. Nella lettera datata 18 dicembre dello stesso anno, il Gesuita annuncia al Prelato che sono state giustiziate altre tre donne <<…nomate Caterine delle altre incarcerate, che restavano come all’altre passate […] Le abiurate non son mai comparse et io non ho potuto far quella diligenza che tuttavia desidero…>>[136]
Un processo per stregoneria poteva essere indetto solo se almeno tre persone avevano denunciato l’uomo o la donna indiziati o accusati da altra persona stimata strega o stregone, quindi venivano incarcerati e successivamente portati davanti all’Inquisitore per essere interrogati la prima volta liberamente, poi sotto tortura. Il processo, che poteva dilungarsi anche per molti giorni, veniva definito con la sentenza emanata dal braccio secolare, composto da trenta uomini del Tribunale di Valle. Il verdetto veniva letto in pubblico, senza, tuttavia, rendere noti i nomi delle altre persone implicate. La pena poteva spaziare dal bando dalla Valle al supplizio del fuoco, in alcuni casi erano considerati la grazia e il perdono, a patto che i condannati abiurassero.[137] “Ecclesia non novit sanguinem”, quindi l’esecuzione della condanna non competeva alla Chiesa, ma al braccio secolare: lo Stato riconosceva ed eseguiva le sentenze dei tribunali ecclesiastici. Quando gli accusati venivano portati davanti all’Inquisitore, non ammettevano la loro colpa, anzi la facevano ricadere su altre persone, dando luogo ad una serie di nomi, dettati anche dalla vendetta personale, allora si doveva ricorrere alla tortura per estorcere la confessione, che, al tempo, diventava strumento fondamentale perché le prove non erano sufficienti se non c’era la confessione dell’imputato. Il giudice era obbligato ad applicare la tortura per constatare se anche subendo atroci sofferenze l’accusato insisteva nel proclamare la sua innocenza; la tortura, nella Valle, consisteva nel legare la persona per le braccia o per la vita, appendere dei pesi ai piedi e tirarla in alto con una ruota. Chi non confessava veniva torturato più volte, tanto da preferire la condanna a morte alla tortura.
La superstizione e la stregoneria era talmente radicata in questi luoghi, come del resto in tutta l’Europa, che molti indiziati erano convinti di essere streghe e stregoni, per altri era un vanto ed un modo per essere al centro dell’attenzione pubblica. Molto diffusa era la propensionea riunirsi in congreghe e in ogni villaggio vi erano dei punti in cui di notte si riunivano i seguaci di queste combrincole e, credendosi realmente in rapporti con Satana, commettevano atti gravemente offensivi alla religione e offesa, violazione ai suoi simboli, oltre che a balli e atti osceni e peccaminosi.[138]
Il Prevosto citato era Domenico Quattrino, il quale fu denunciato e subito destituito, al suo posto fu designato Pietro Stoppani, Oblato milanese, il quale ebbe l’incarico di curato di Roveredo e di Santa Maria in Calanca.[139] Consegnato al Braccio secolare, sotto tortura confessò molti dei delitti commessi, tanto che correva voce della sua condanna a morte, condanna che non ebbe mai luogo: <<In ciò furono tratti in inganno parecchi autori, dagli accenni delle relazione, ove è detto che il Quattrino fu condannato, senza avvertire che questa parola significa sentenziato e giudicato reo del delitto. Ma non si parla mai della pena>>,[140] che, secondo il D’Alessandri consistette nella perdita della cura e ridotto allo stato secolare, inoltre lo studioso riporta alcune frasi di due documenti in cui compare Domenico Quattrino, relativi al 1587, cioè quattro anni dopo la visita di Borromeo.[141]
Mentre la visita in Mesolcina procedeva tra roghi e pentimenti, tra grandi accoglienze e non pochi timori, il Ministrale Giovanni aMarca, uno dei più accaniti sostenitore della necessità di tale visita, si trovava a Milano in missione diplomatica presso i delegati del Re di Spagna, nello stesso tempo un’altra delegazione delle Tre Leghe si trovava nella stessa città, di cui faceva parte anche Pietro Mazzio di Roveredo, il quale fu denunciato come eretico da un cerusico di Milano. Ludovico Audoano, Vicario Generale di Carlo, avvisò subito il Prelato di questo grave inconveniente con una sua lettera del 21 novembre 1583: <<Questi giorni passati mi fu fatta notificazione contro un messer Pietro Masso Grisione del loco di Roveredo, qual si trovava qui, che fosse heretico marcio, contro il quale, si per le capitolazioni, si anche per haverne fatta parola con quelli de’ la Congregazione del s……. di casa, mi risolsi di non far altro tanto più che essendo da poi statto da me l’Ambasciatore dei Sig.ri Grisoni, mi disse che V. S. Ill.ma era alogiata in casa di esso m.e Pietro. Il notificante vedendo che cossì presto comme forse haveria voluto, non si essequì, fece l’istessa notificazione al Padre Inquisitore, il quale relassò la cattura contra di d,o dinunciato, essendo poi statto detto Ambasciatore dal d.o Imp.re gli scoperse ch’il dinonciante se ben non heretico, fosse un gran furbo e nemicissimo del d.o m.r Pietro, per causa de homicidij erano seguiti tra tra di loro et che d,o denunciato anche andava a messa a Coira>>,[142] quindi manda al Borromeo la copia della notifica e gli chiede di informarsi, se lo ritiene opportuno, su questo fatto, in quanto a lui è venuto il sospetto che il querelante non abbia agito <<…con mala intentionedi offendere con uno stesso colpo il dinonciato, e causare con quella gente qualche disgusto…>>.[143] Cominciò la caccia al presunto eretico da parte dell’Inquisizione, tutto ciò creò una grande preoccupazione in Giovanni aMarca, la cui missione probabilmente mirava ad ottenere appoggi e vantaggi al Borromeo per la sua visita, ma questo fatto rappresentava un grande affronto verso Mazzio, la cui reazione poteva essere quella di istigare disagi al Cardinale,[144] visto le sue importanti relazioni politiche che intratteneva e forse i timori di aMarca non erano infondati perché in una lettera del 26 novembre 1583, Bernardino Morra, scrive che, in un primo tempo, a Coira, per quello che era stato fatto a Milano ad uno di loro, si pensava addirittura di arrestare il Borromeo, poi le acque si calmarono dopo che Morra presentò le scuse a Mazzio, il quale restò soddisfatto.[145]Dalla lettera successiva, del 19 novembre, che Giovanni aMarca scrive a Carlo, dopo le giustificazioni per il suo dilungarsi a Milano a causa dei suddetti motivi, apprendiamo che in sua assenza il Cardinale può valersi di suo fratello Nicolao per la riunione “Beitag” che si terrà a Coira, durante la quale il Prelato avrebbe dovuto ottenere un invito o almeno un permesso ufficiale per una sua visita a Coira e per un’azione più vasta in Valtellina.[146]
Il 22 novembre Borromeo si trovava a Mesocco e sperava di poter varcare il passo del San Bernardino, per continuare la visita nel restante Grigione cattolico e in Valtellina, quando fu comunicato il divieto della Dieta adunata a Coira, con grande soddisfazione del Vescovo della città, Peter de Raschèr, il quale non vedeva di buon occhio la visita.[147] Il Cardinale mandò subito dal Vescovo di Coira il suo segretario Bernardino Morra per rendersi conto di quale fosse stata realmente la situazione. Morra ragguaglia il Prelato sul difficoltoso viaggio attraverso la montagna coperta di neve e nella tormenta: <<…giunsi qui a Sancto Bernardino a mezza montagna con salute, però a notte perché trovai la strada piena di neve che non si poteva cavalcare in ogni luogo, ne prima d’hieri l’haverei potuta fare perché la strada era stoppa affatto nel basso, dove li venti delli giorni passati hanno condutta la neve molto alta>>.[148] Questo nella lettera del 20 di novembre, in quella relativa al 21 le condizioni atmosferiche sono ulteriormente peggiorate: <<Hieri subito che giunsemo in cima alla montagna nel calare le notti un vento che ci sono li vestiggi della stradda ci riempì in modo le basse, che dopo haver cavato i cavalli in tre o quattro luoghi con grandissima difficoltà dalla neve nella quale erano quasi sepolti, fossemo forzati lasciarli dietro con le robbe…>>;[149] il vento era fortissimo e la neve ghiacciata sugli occhi, impediva loro la vista, quindi Bernardino Morra procedeva dietro al Todeschino, ossia Ambrogio Fornerio, servitore di Borromeo andando alla cieca, poiché la neve aveva coperto ogni traccia di sentieri; ma scrive anche della generosa ospitalità ed aiuto che riceveva da popolazioni che, ormai, professavano altra fede, addirittura descrive l’interesse che in alcuni luoghi mostrano per la venuta di Carlo Borromeo: <<…dove trovassimo tanta amorevolezza con prontezza in aiutarci massime per recuperare i cavalli, che non si potrebbe dir maggiore. Così andarono quattro o sei huomini (i) qualli a notte gli condussero con grandi difficoltà, sì che Mons.r Ill.mo mio riconosco l’aiuta da singolare gratia n’ha voluto far Iddio, che invero non potrei esprimere i pericoli grandi che habbiam passati, tanto che mi par un sogno […]L’exhibitor del presente è fratello del S.r Ministralle de questi paesi de Valle di Rheno et bene principale in questa terra, qual ci ha alloggiato con tanta amorevolezza ch’io sono restato confuso, e’ m’ha detto (che) anche loro fecero consiglio sopra la venuta di V. S. Ill.ma quale aspetano con grande desiderio con bona volontà di riceverlo et alloggiarlo, et che farano accomodare la stradda della montagna sì che potrà passare facilmente…>>.[150] Il fratello del Ministrale, ossia la persona che ha dato aiuto, affiderà al Borromeo un suo figlio quindicenne per farlo studiare nel Collegio di Roveredo.[151]
Da Coira, dove era arrivato il 22 novembre, Morra scriveva che il Vescovo <<spiritualia negligit, temporalia dilapidat>>, cioè si occupava molto di più delle cose temporali che non di quelle spirituali, facendo una vita lussuosa e dissoluta,[152] ma il compito di Morra era quello di verificare gli ordinamenti del Vescovo nei confronti del Cardinale, il quale stava agendo in luoghi a lui sottoposti, inoltre doveva appurare se fosse stata gradita una sua sosta a Coira, poiché sarebbe passato da quei luoghi per andare al Castello di Hohenems ospite di suo cognato Annibale Altemps, marito sella sorellastra Ortensia. In realtà a Borromeo non interessava tanto di poter predicare nella Cattedrale di Coira, cosa che gli sarà sconsigliata dal Vescovo, ma di persuadere lo stesso Vescovo a revocare il divieto della sua visita in Valtellina: <<Hieri matina giunsi qua in Coira a bonhora, fui raccolto da Monsignor Reverendissimo lietamente, mostrò gran sodisfatione e contento dell’officio che feci seco insieme di Vostra Signoria Illustrissima in darli conto della causa della venuta sua costì, e delle cose ivi seguite. Non haveva inteso prima dell’arrivo di Vostra Signoria Illustrissima costì, perché suo fratello il Conte non è sin’hora ritornato da Milano, ma ben haveva havuto aviso che la voleva venirci per passar poi in Altemps. […] et mi disse che se havesse saputo dell’arrivo suo nella valle Mesolcina sarebbe lui venutoo almen mandato personea basciar le mani aVostra Signoria Illustrissima et invitarla a venir sin qui, come mostra haverne desiderio grande, per farle vedere le miserie di questa sua Chiesa rispetto al governo et ererethij spirituali…>>.[153] Nonostante la diplomazia che Morra usa nella sua lettera, ci sembra poco probabile che il Vescovo di Coira non fosse al corrente che Borromeo si trovava in Mesolcina già da dodici giorni circa e che lo venisse a sapere proprio dal Segretario del Cardinale, anche se in un’altra lettera di Morra al Cardinale datata 26 novembre troviamo: <<Questa mattina solamente Monsignor Vescovo ha ricevuto la lettera del Ministrale de Roveredo con la quale gli dava aviso dell’arrivo di Vostra Signoria Illustrissima in cotesta Valle, così che non era meraviglia se non mandava persona o lettere per compimento et debito suo>>.[154] Il compito del Segretario di Borromeo non si presentava certamente facile: avrebbe dovuto affrontare l’aperta avversione di molti e, soprattutto, le incognite delle soluzioni dell’imminente Dieta: <<…et in conclusione il parere commune sì di Monsignor Reverendissimo, come d’un suo fratello ch’è qua, d’un suo Castellano, del Proposito, et anco del Signor ladrito Galles,[155] col quale ho ragionato questa sera ch’è giunto qua di Borgogna, è che Vostra Signoria Illustrissima sia per ottenere poco o forse niente col passaggio suo di qui, et che più tosto fosse per aportar qualche sospetto nell’animo de popolari che si ritroverano qua alla Dieta, quelli non sono soliti regersi nelle deliberationi con la ragione, ma più tosto con passione et affetto troppo grandi che hanno all’augumento della religione nova, della quale sono le doi parti delle voci>>.[156] Si deduce che, in definitiva, la presenza del futuro Santo avrebbe sortito più guai che vantaggi, anche per quanto riguarda il proseguo della vista in Valtellina, non vi sono speranze di avere il permesso: <<…si crede che gl’officiali di collà non permetteranno che Vostra Signoria Illustrissima faccia atione alcuna spirituale…>>.[157] Nel frattempo, Bernardino Morra cerca parlare a lungo con l’Ambasciatore di Francia, il quale è arrivato da pochi giorni con molto denaro, destinato, probabilmente, a pensioni e spese militari, ma anche molto vantaggioso nell’influenzare le disposizioni.[158] Durante la sua permanenza in Coira, Morra capisce chiaramente che la minoranza cattolica è paralizzata dalla paura, quindi, secondo le decisioni che saranno prese dalla Dieta, il Segretario non sa se è opportuno continuare ad insistere sulle proposte o abbandonarle se non dovessero dare risultati positivi, tutto ciò si può fare, continua Morra, senza mettere a repentaglio la posizione del Borromeo se è lontano, mentre se si trovasse a Coira sarebbe una sconfitta clamorosa. Tra le righe possiamo capire che, diplomaticamente, il Segretario consiglia al Cardinale di abbandonare l’idea del viaggio oltre San Bernardino, come poi avvenne,[159] portando anche l’esempio del Vescovo di Como, il quale: <<…à procurato d’otenere da questi Signoridi poter andare a visitare Valtellina come sua diocesi, et intendo che ha usato diversi mezi anco di quelli che piaciono et trastullano qua, però che mai ha potuto otener cosa alcuna […] l’istesso Ambasciatore di Francia va molto ritenuto et con segretezza nel trattare cose pertinenti la nostra Religione per non dare sospetto a questi popoli quali maggiormente non s’appagano di ragioni, et fra le altre cose mi disse hieri che tre ò quattro giorni passati nel elettione del borgomastro giurarono tutti questi cittadini di non venire alla chiesa per sentir messa, d’indi nasce che sono puniti poi quei che vi vengono >>.[160] Queste due lettere di Morra sono datate 23 e 24 novembre, ma al 23 dello stesso mese risale anche la lettera latina di Pietro Rascher, Vescovo di Coira, il quale dopo avere parlato con il Segretario del Cardinale scrive chiaramente che una venuta del Borromeo in questa città dovrebbe necessariamente limitarsi ad una mera visita privata: se il Cardinale vuole passare per Coira per recarsi dal cognato, i cittadini lo accoglieranno con i più alti onori e non impediranno una visita alla Cattedrale, ma non vorranno che tenga un discorso al popolo e anche se lo volessero, verrebbe dissuaso dallo stesso Vescovo, perché, in momenti così delicati, sarebbe fuori luogo e sedizioso.[161] La lettera è datata agli idi di novembre che cadevano il 13 del mese del vecchio calendario, quindi rapportata al computo del nuovo calendario risulta scritta il 24 di novembre.[162]
In un’altra lettera del 2 dicembre, Pietro Rascher insiste sulla difficoltà suscitate da parte dei riformati sopra un’eventuale intromissione del Borromeo negli affari della Diocesi: al “bitag” delle Leghe, i Cattolici ribadivano che il Cardinale doveva essere ricevuto senza riserve, la parte opposta si opponeva con forza e il Vescovo venne a trovarsi tra l’incudine e il martello, ovviamente ebbero la meglio gli scismatici molto più numerosi degli altri: <<E contra novum Scisma Sectantes in nos fulgurabant. Sic inter malle(u)m et incudem constitutus, tandem maior pars in deliberando meliorem vincit>>.[163]
Viene decretata la concessione del libero passaggio, attraverso quei luoghi, al Borromeo e al suo seguito, con ordine di accoglierlo con il degno omaggio. Questa lettera deve essere stata scritta dal Vescovo prima di ricevere quella che il Cardinale gli scrive il 28 novembre, dove gli comunica la sua rinuncia al proseguimento del viaggio, essendosi prolungati più del previsto i tempi della visita in Mesolcina, e a Milano lo aspettano i suoi doveri di Arcivescovo, essendo vicino il Natale, oltre ad altri improrogabili impegni: il consiglio di Bernardino Morra è stato ascoltato e la dignità del futuro Santo è salva.[164]
La Valtellina e la Valchiavenna furono sempre ecclesiasticamente dipendenti dai vescovi di Como, civilmente appartenevano al Ducato di Milano dal 1335, ma quando i Francesi, nel 1499, occuparono il detto Ducato, invasero anche queste Valli, usando soprusi ed esigendo tasse non sempre legali fino al 1512, quando i Francesi furono costretti ad abbandonare Milano, sconfitti dalla Lega Santa, che improvvisamente si era alleata con Venezia, con i Savoia e la Svizzera per frenare l’esagerato potere della Francia. Come da accordi con gli alleati, i Grigioni entrarono nelle Valli il 27 giugno 1512 e con il giuramento di Teglio vennero annesse alle Tre Leghe, il cui dominio durò fino al 1797. L’importanza della Valtellina come crocrocevia europeo e la proclamazione della libertà di culto favorirono l’immigrazione di riformati italiani. La situazione non era molto diversa da quella della Mesolcina: gli stessi problemi religiosi e morali dividevano i Cattolici dai Riformati e i primi, visto l’esito positivo della visita in Mesolcina, aspettavano la venuta del Borromeo nelle loro Valli, tutto questo lo possiamo apprendere da una lunga lettera che il Prelato scrive senza specificare il destinatario, ma all’inizio troviamo “Per Franza”: <<Dall’essempio del bene seguito nella Valle Mesolcina, il S. Cardinale prese ferma speranza di far gran frutto nella Valtellina, et così determinò d’andarvi come havea anco designato prima…>>,[165] ma tutto ciò fu impedito durante la Dieta di Coira, come già detto, <<…et perché non haveano ragione alcuna , si valsero dell’occasione di certa voce quale allora si era cominciata a spargere, che si trattasse nuova lega fra i Grisoni et il Re di Spagna, con dire che il S. Cardinale non voleva andare in quei paesi loro per fine spirituale, ma per detta nuova lega et negotij di stato…>>. L’Ambasciatore di Francia, col quale Bernardino Morra trattò particolarmente l’argomento della visita in Valtellina, si mostrò favorevole all’inizio, <<…ma poi entrato anco esso in sospetto, et gelosia del sudetto trattato di nuova lega, si raffredò, et forse fece qualchi ufficij contrarij…>>. Successivamente i Grigioni mandarono in Valtellina e Valchiavenna quindici commissari <<…la maggior parte heretici dove hanno tormentato aspramente l’Arciprete di Sondrio, quale si trovava già detenuto sotto pretesto c’havesse tenuto mano a certi rumori, et risse che poco avanti occorsero in Sondrio fra catolici, et heretici..>>, nonostante sia poi stato dichiarato innocente fu condannato a pagare più di 200 scudi per delle inesistenti spese, peggio ancora fu costretto a promettere, sotto giuramento, diverse cose non specificate.[166] Furono incaricati trenta uomini della Valtellina e dei luoghi vicini per andare a Coira a recriminare per i tanti soprusi patiti dagli abitanti cattolici, ma da un documento senza data e senza destinatario troviamo: <<Quelli c’havranno la cura del maneggio della negotatione della Lega co’l Re Catolico, si risolsero ultimamente d’andarsene a Coira, con disegno di trattar la apertamente, con una buona somma di danaro, et vi andarono, ma il Capo della Lega delle Dritture, non vi comparve, et eglino quando hebbero aspettato sette giorni, forse parendogli troppa indignitàdel loro Re si risolsero di partire senza parlare di questo negotio, et così è restato estinto affatto per adesso>>. [167] Bernardino Morra, in una lettera del 10 agosto 1584 riferirà al Cardinale di avere appreso dal Todeschini, che a sua volta aveva avuto la notizia da persona sicura, che i Gigioni vivevano nella paura di perdere la Valtellina e i loro commerci con Milano, tanto che hanno avuto un incontro segreto con i Cantoni “eretici” e sembra che “habbin fatto lega particolare”, ma alla Dieta che si terrà a Bada il 26 dello stesso mese parteciperanno sia i Cantoni cattolici sia quelli riformati, per cui, suggerisce il Segretario, è necessario mandare uomini bene informati sulla situazione per dimostrare le ragioni dei Cantoni cattolici. Da notare la capillarità della rete di informazioni che il Borromeo aveva costituita non solo nei luoghi sottoposti alla sua giurisdizione, ma in tutta l’Italia.[168]
L’Arciprete di Sondrio, Giovanni Giacomo Pusterla scrive alcune lettere al Cardinale durante la sua detenzione, da cui apprendiamo che il 19 aprile1584 si trovava in prigione per le accuse suddette, in realtà perché si oppose all’istituzione di un collegio, ufficialmente pluriconfessionale, ma chiaramente di ispirazione riformata. I cattolici si ribellarono a tale iniziativa, per timore che la scuola avrebbe favorito la religione riformata ed avrebbe portato dei gravi frutti morali, presto scoppiò un tumulto che si trasformò in un caso politico quando le Tre Leghe inviarono dei commissari per fare indagini sulla sommossa, furono arrestati alcuni uomini per sospetto di avere fomentato tale sommossa, tra questi vi era l’Arciprete di Sondrio e dalla prigionia scrive al Borromeo: <<Hoggi è il quinto giorno, ch’io con mio fratello, et doi altri buoni catholici ci troviamo prigioni del S.r Gov.ori nostro per difensione di S.ta chiesa, per la quale si sollevò tutto il nostro popolo contra heretici, come credo ceh V.S. Ill.ma haverá inteso da diversi predicatori di questa Valle […] Ha puochi giorni, ch’io ricevei altre sue mandatemi da Mons.r R.mo nostro di Como, alle quali non so che altro respondere per non esser presso di me. Uscito che sarò di prigione, attendero ad esequir fedelmente quanto ella me haverà commesso, come anche farò circa le Commissioni matrimoniali mandatemi, et ogni cosa, ch’ella si degnerà di commandarmi.Di Sondrio il 19 di Aprile 1584. Devotissomo Servitore. L’Arciprete di Sondrio carcerato per S.ta fede>>.[169] Un’altra lettera, del 28 maggio dello stesso anno, ci informa che <<Qui in prigione, dove io sono ancora per la gratia di Dio, ho ricevuta la consolatoria lettera di Vostra signoria Illustrissima la quale m’ha portato abundante spirito per tollerare le gran persequtioni, che habbiamo da nemici di Santa Chiesa […]La nostra detentione si va allongando, et dubbito che la causa si porti nel prossimo Pithac del Corpus Domini, nel qual haveremo maggior contrasto che non habbiamo qui, perche allora li Predicanti Luterani si ritrovano tutti in Coyra al loro Synodo che fanno…>>.[170]
In una lettera, dell’11giugno, scritta dal nipote dell’Arciprete di Sondrio, Nicolò Pusterla al Cardinale, possiamo capire che la situazione era molto grave: <<Come servo obedientissimo di Vostra Signoria Illustrissima l’aviso di tutto quel che qui è bisogno per il servitio di Dio. Ho trovato nella mia aggionta, mio zio l’Arciprete di Sondrio anco priggione, et la cosa assai piu pericolosa di quel che io credevo havendo egli oltre la priggionia datta securtà di domila scudi per esser stato accusato di rebelle et di seduttore. Et in vero, come ho inteso qua, l’anticolleggio si sarebbe piantato, se l’armi non fossero state interposte, et ancora che dal esser state pigliate l’arme nati questi puochi travagli pur molti beni ne sono nati…>>,[171]ossia i Riformati si sono ritirati e la sommossa ha accentuato il fervore dei Cattolici. Nicolò continua dicendo che lo zio non è in grado di pagare una tale somma, quindi supplica il Borromeo d’intercedere presso la Santa Sede, affinché arrivi da Roma qualche aiuto economico. Nicolò Pusterla era Canonico di Coira e dall’inizio della lettera possiamo notare che faceva parte degli “informatori” che l’Arcivescovo aveva ovunque. Nel 1590 fu nominato dal popolo Arciprete di Sondrio, essendo lo zio stato costretto a fuggire a Roma, ma anche lui fu vittima dei Protestanti e sembra sia morto in prigione, avvelenato dal Governatore della Valle.[172]
Il 13 di giugno, Giovanni Giacomo Pusterla scrive a Carlo che finalmente lui e gli altri carcerati sono stati tutti rilasciati, ma egli ha dovuto pagare duemila scudi, gli altri mille a testa, con l’obbligo di essere a disposizione del Governatore e di non lasciare la città di Sondrio, ma i Giudici tardano a spedire la causa, forse, suppone il mittente, per poterla presentare al prossimo <<…Pithac per darci forse o maggior travaglio, o qualche castigo a lor modo tanta e’ la persequtione che habbiamo da questi indemoniati heretici>>.[173] Il Pusterla, comunque, non demorde, infatti così scrive il 22 giugno: <<Dapoi ch’io son uscito di prigione con segurtà però di representarmi, non ho mancato di far tutti quei offici gagliardi, che mi siano stati possibili, per unire questi popoli, accio facessero li suoi messi speciali per la causa di religione da mandarsi al prossimo Pithac, con persuaderli che il Signore con suoi potenti instromenti è per aiutarci adesso, quando da se stessi non si manchino. Tuttavia io veggo che questa Valle, contra ogni mia dissuasione fattagli, vuole preferire la causa de’ Signori Commissarij, che s’habbino da levare, alla causa spirituale della religione, cosa che è contra il vero ordine, et che poi secondo l’occasione che ne haveranno, attenderanno ancora alla causa spirituale secondariamente. […] Credevo, et desideravo andar io stesso al prossimo Pithac, ma per la segurtà data, non posso partirmi di Sondrio>>.[174] In un documento senza data e senza firma troviamo i <<Rapporti di alcuni particolari in materia della fede agitatai nella presente Dieta de Sig.ri Grisoni fatta in Coyra>>, dal quale apprendiamo, dal primo punto, che i Signori dei cinque Cantoni svizzeri hanno riferito, durante la Dieta, di avere ricevuto delle lettere dal Pontefice, dal Re e dai Signori veneziani, in cui affermano di avere sentito dire che i Grisoni non lasciano libertà di culto ai loro sudditi cattolici e di voler istituire un Collegio luterano in Valtellina, che, per essere ai confini degli stati dei suddetti mittenti, <<…porta pericolo certo alle anime de loro popoli…>>, quindi è desiderio che l’Istituto non venga eretto, <<accio si possa continovar nella passata buona vicinanza, che altrimenti per essere inovatione contra le conventioniloro, se sarebbono tenuti per conservazione de loro stati farli altra provvigione…>>, pertanto, considerando gli inconvenienti che potrebbero verificarsi, esortano a non <<aggravar gli loro sudditi nelle cose della fede>>.[175] Il Cardinale Savelli viene informato dell’istituzione del collegio dal Borromeo, in una sua lettera del 18 agosto 1583, quindi quasi un anno prima dei suddetti fatti: <<Ho havuto la certezza della fondazione do quel Colleggio d’heretici in Sondrio, al quale quei Signori Grigioni haveano applicata l’entrata della prevostura di Tir (Tirano) ma i Cattolici si sono in modo adroprati, che hanno attenuta la metà di quell’entrata, per poter, ancor essi, fondar una scuola Cattolica. Il che è di men male, in cosa pessima com’è quella…>>.[176]
Il secondo punto tratta dei predicanti eretici …<<che ressidono in quello paese che si trovano in Coijra al n° de 65 inc.a in al sinodo che facevano, hanno decretato che nelli loro paesi de sudditi non sia accettato ne admesso alcun prete ne frate forastiero, et di più che tutti quelli che ci soni siano espulsi…>>.[177]
Dal terzo punto veniamo a conoscenza che sono stati incaricati quindici “Sindicatori”con ampia autorità, per inquisire e processare nel territorio della Valtellina e Valchiavenna e punire tutti quelli che hanno <<…parlato contra gli hereticio fatto qualche movimento de Zelanti et buoni cat.ci nella osservazione della quadragesima et feste secondo il calindario novo, et de altre cose al tempo che furono scacciati gli R.di Padri Predicatori da Chiavenna a da Valtellina, et in altri tempi, de quali persone ne hanno in nota in quantità, et detti sindicatori hanno autorità di piantar sudetto collegio et di lasciar, ma si dubita per instigatione de predicanti et altri maligni spiriti havrà pur troppo effetto, massime per esserne tra detti 15 solo 3 inc.a de catolici. Hanno ancora autorità di reformar et aggravar il processo del R.do Arciprete di Sondrio non contentandosi del formato perché gli parerà leggiero da non poter satiar lìingorda voglia dell’avaritia>>.[178]
Il 27 giugno 1584 “Li Amb.ri della generale libera Lega Grisa, di presente in Coijra congregati”in una lettera dichiarano la loro non contrarietà all’erezione di un Istituto, anzi esprimono la loro ammirazione per questo cristiano proposito.[179]
Molto interessante è la lettera che Scipione Calandrini,[180] noto eretico lucchese trasferitosi in questi luoghi, scrive, a sua discolpa, al Governatore e al suo Vicario, circa una presunta disputa che il Borromeo avrebbe fatto in Chiavenna per far capire le differenze tra la religione cattolica e quella protestante, ma soprattutto per mettere in evidenza gli errori di quest’ultima, ma, secondo alcune persone, tra questi fra Francesco da Balerna predicatore francescano, che i riformati avrebbero impedito tale discussione. Data l’importanza del documento, riportiamo il testo integralmente: <<Ill. Signore Governatore e voi Mag. co S.r Vic. Ro Essendomi statto detto da piú persone degne di fede che Fra Francesco da Balerna franciscano al presente predicatore in S. Gervasio habbia detto et affirmato ch ‘l Cardinal Borromeo habbia voluto piantar una disputa in Chiavenna sopra le differenze della Religione per far conoscere i nostri errori, e che noi non l’habbiamo voluto consentire, e che se li nostri Illustrissimi Signori permettessero che egli venisse in Valtellina con li suoi Theologi che disputariano con noi e ci convincariano, ma che noi l’impediamo. E di più essendo certificato ch’egli va tentando hor questo hor quello de li nostri, e che non havendo dal principio ricusato di confrontarsi con meco sopra gli articoli discrepanti tra noi, anzi essendosi offerto di mettere ancora le cose in scritto, poi quando si è voluto venire all’effetto, dandogli solamente tre conclusioni, non ne ha voluto far nulla, dicendo essergli prohibito da gli suoi superiori di disputar con noi e che io doverei andare a Como o a Milano, dove sarei convinto, e che si constituerà qui prigione se medesimo, facendo ancora venire tre o quattro gentil huomini Principali di Como che staranno qui per hostaggi fino che io con quelli fussero meco ritornassimo a casa, e simili altre cose. Per tanto havendo fatto consideratione sopra le dette cose mosso dal debito dell’officio mio e della mia vocatione che è di difender la verità con ogni debito modo, e resistere alle oppugnationi di essa, e stabilire gli infermi contra le tentationi che sono lor fatte e dare occasione agli alieni di aprire gli occhi alla verità, e accostarsi alla dottrina sincera, ma non ho voluto ne potuto mancar di presentarmi dinanzi alle SS. VV. con supplicarle di far domandare il detto frate Francesco, e fargli intendere la mia risposta, e la mia protesta quale io faccio alle proposte sue, la qual risposta e protesta è la seguente. Prima che non si troverà mai esser vero, che il Cardinale Borromeo habbia procurato che si facesse una disputa in Chiavenna sopra le differentie della Religione, molto meno è vero, che da noi tal disputa sia stata impedita.
Di più che non si trovava mai esser vero, che da noi sia statto impedito, che il medesimo non si facesse in Valtellina, quando il Cardinal Borromeo havesse ricercato tal cosa da nostri Ill.mi S.ri cioè che fusse ordinata da loro Ill.me Sig.re ma publica con li suoi debiti ordini e regali, quali si usano nelle dispute publiche, nella quale si confrontassero i Theologi dell’una e dell’altra parte, per discutere con argomenti e ragioni vere e farne le differentie della Religione, come è statto fatto più volte in Germania, in Inghilterra, in Francia, e nella helvetia.
Di più che basta l’animo di fare che il detto Cardinale ricerchi tal cosa da nostri Ill.mi S.ri si come ho detto, io prometto fare ogni opera possibile con li miei compagni, e Hon.di fratelli Ministri della parola di Dio appresse de nostri Ill.mi S.ri che gli sia concessa la sua domanda, protestando dinanzi a Dio e a tutto il mondo che noi non ci ritireremo mai indietro da simile confronto, anzi che lo desideriamo sommamente si per sapere che è desiderato da molti dell’una e dell’altra Religione, come ancora per essere questa una delle vie principali da far venire molti in cognitione della verità.
Quanto poi al mio particolare ch’egli dice, ch’io vada a Como, o a Milano, per disputar là essendo prohibito a lui di disputare qui. Rispondo. Prima che questa sua fuga, perché si sto arrivando da ogni uno con quanta pena sia prohibito a qualunque persona si sia in Como, Milano, e in qualunque altro luogo la Chiesa Romana ha imperio assoluto di disputare delle cose della Religione, non meno di quello sia prohibito alli suoi seguaci di disputarne altrove.
Di poi la vocation mia e di miei compagni non è d’andar quà o là senza legittima vocatione a predicare o disputare, ma solamente dove siamo chiamati con li modi prescritti dalla parola di Dio. Ma esso e li suoi simili andando qua e là, e potendo venire a disputare con noi in questi paesi liberi senza alcuno periculo, dove sono tutte due le Religioni, e dove si dee cercar di disinganare quelli ch’essi affermano esser in errore, doveriano venire quà a simili confronti con noi, e non invitare noi là dove non habbiamo ne possiamo andare senza esser notati di poco prudenti.
Ma perché dice di dare sofficiente sicurta e 5 ostaggi per me e per quei compagni che fussero meco, per mostrargli quanto io mi confidi, non nella sofficientia mia, ma nella buona conscientia e nella buona causa nostra, se egli operera che in Como o in Milano si faccia una disputa che sia publica, e che io con due compagni siamo domandati alli nostri Ill.mi S.ri dando il salvo condotto come va dato, con le sicurta e hostaggi ch’egli dice: io prometto fin hora dinanzi a Dio e a tutto il mondo di andare, e disputare con ogni sincerita secondo la gratia, che Iddio mi dara: Con questo pero che tutti li atti e gli argomenti con le risposte loro siano messi in scritto, accioche possiamo render conto a li nostri Ill.mi S.ri e alle nostre Chiese di tutto quello sara seguito, e acciché ogni persona pia et d’intelletto possa vedere chi habbia torto o ragione.
E quando tal cosa non posso ottenere dalli suoi superiori da basso e che si contentino che senza fare altre andate ne di noi in là ne di essi in qua ( per mostrare che siamo pronti di venire in tutti modi a ogni legittimo confronto) si contentino dico che si disputi per via di scritture, le quali senza pericolo alcuno e senza spesa si possono andare inanzi e in dietro, io offerisco loro ancora questo mezzo. E così si potra cominciare dalle tre conclusioni presentate al detto frate Francesco, che trattano della autorita, sofficentia, e sola Regola della Santa Scrittura in tutte le cose appartenenti alla fede, alla vita, e al governo della Chiesa Christiana e vera Catholica e Apostolica.
Questa è la risposta e la protesta mia, la quale fo a voce dinanzi alle S.re V.te e la do in scritto, sotto scritta di mia propria mano, accioche la facciano intendere al detto frate Francesco e ne ricerchino la risposta. Di che ne supplico le SS. VV. Con ogni desiderio maggiore che per me farsi possa, pregando la Divina Maesta per ogni loro perpetua felicita.
In Sondrio alli X di marzo 1584
Scipione Calandrius Ministro della parola di Dio, in Sondrio, manu propria>>.[181]
Il Cardinale aveva capito che la situazione presente in Valtellina era legata più ad interessi temporali ed economici che non a quelli religiosi e si era reso conto che non poteva avere successo la sua visita se non fosse appoggiata dall’azione politica. Il suo desiderio non era quello che le due Valli fossero tolte ai Grigioni per darle alla Spagna, voleva che le condizioni dei Cattolici fossero meno dure. In una sua lettera il Cardinale Speciano non nasconde a Carlo che a Roma c’era preoccupazione per le conseguenze che si sarebbero riscontrate se la Spagna avesse conquistato la Valtellina; l’Arcivescovo rispondeva che non credeva che la Spagna mirasse a quella conquista, ma se mai accadesse egli sarebbe riuscito a convincere il Re ad un compromesso pacifico con i Grigioni, limitando l’azione solo a fini religiosi. Questo fa capire la consapevolezza del Borromeo di padroneggiare la situazione politica dello Stato di Milano e di poter rivolgere la politica monarchica spagnola ai fini dei suoi disegni di restaurazione spirituale e religiosa.[182]
L’Arcivescovo non perde tempo a far valere la propria autorità e in una lunga lettera al Governatore di Milano, Duca di Terranova, descrive la situazione di queste due Valli e quello che urge fare, data l’importanza del documento riteniamo opportuno trascrivere i passi più significativi: dopo avere con precedenti missive informato il Governatore della Visita in Mesolcina e spiegato i gravi disagi cui sono sottoposti i cattolici della Valtellina e Valchiavenna, tanto da chiedere aiuti, sarebbe una buona occasione fare di tutto sollevare questi popoli da tante oppressioni, con grande vantaggio della religione Cattolica. <<Hora perché dalla lettera che mi ha scritto S. M.tà per questa causa, vedo quanto essa desidera ch’io continui gli officij che incominciai l’anno passato in beneficio spirituale di quei paesi, e promette d’aiutare e favorire dal suo canto in tutto quello che si conoscerà esser spediente, et a questo effetto mi dice S. M.tà ch’io posso andar comunicando con V. Ecc.za quello che occorre, in ch e lei possa aiutar questo servitio del Sig.re tanto importante>>. Continua parlando delle cause che hanno portato alla situazione attuale e che non si discostano molto da quelle della Mesolcina; i rimedi consistono nel visitare quei popoli, provvederli di validi religiosi, esortarli con ogni mezzo per farli tornare nel culto di Dio, impedire agli eretici <<…finché non si ha braccio ne forza di levar la libertà loro diabolica, di vivere nell’eresie, almeno procurando di andar disingannando molti sedutti, istruendo gli ignoranti, come sono per lo più quelle genti […] Il che tutto si è veduto con effetto manifestamente nella Valle Mesolcina deve la visita solamente di quindici giorni, e sue conseguenze, essa Valle, con molta facilità, e suavità, si è riformata tutta, e rinovata spiritualmente>>. I provvedimenti che il Borromeo vorrebbe prendere sono gli stessi attuati in Mesolcina, <<Ne basterebbe l’impedir l’erettione di quella scuola eretica, che disegnano i Grigioni di piantare in Sondrio terra principale della Valtellina, perché sebbene questa e cosa d’imporetanza, per il danno che risulterebbe da essa scuola alla religione cat.ca in quei paesi, et altrove massimamente a questo Stato di Milano, per la vicinità sua, e Commercio, nondimeno restando tuttavia privi li cat.ci delli aiuti spirituali […] Vi sarebbe un’ altro capo da dimandarsi, cioe che nelle terre del sud.to paese loro non fossero più accettati e tollerati e fuggitivi d’Italia, S. M.tà può pretendere questo, anco per ragione di Stato, et di buona vicinanza…>>, infatti i Grigioni sostengono, continua il documento, di voler essere in buoni rapporti con il Re di Spagna, soprattutto per il commercio con l’Italia e lo Stato di Milano, ma è proprio con questi contatti che le eresie si propagano anche per mezzo di libri proibiti, quindi il Prelato suggerisce al Governatore un certo comportamento: <<Quanto al modo co’l qual s’ha procedere, per ottener da Grigioni, che diano alli catolici del paese loro queste ragionevoli sodisfationi V. Ecc.za vede che non è spediente trattar con loro, per i termini amorevoli, e civili, perché essendo eretica la maggior parte de capi, li quali hanno il governo in mano, conosciamo, ch’ogni libertà, che si dia a Cat.ci e contraria allo scopo e fine loro, che e d’allargar l’eresia et annichilar la relig.ne cat.ca. […] E’ necessario dunque trattar con loro risentitamente, dimandando che devano lasciar i paesi, e popoli loro e dei suoi sudditi, mass.e di Valtellina, e Valle di Chiavenna e contorni di qua da monti nella libertà di vicere cattolicamente, nel modo, che si e esplicato di sopra, con protestargli che altrimente S. M.tà non potrà di meno, che non porga ogni aiuto e soccorso a catt.ci, acciò possino havere la sudetta intera libertà>>. Certamente, prosegue il Cardinale, la richiesta del Re deve essere molto risoluta per ottenere lo scopo, un altro mezzo che può essere molto convincente <<…è la proibizione totale del commercio de popoli di quel paese, con questo stato di Milano, perché V. Ecc.za ha a sapere, ch’l governo loro è in mano d’alcuni capi li quali per esser la maggior parte eretici […] Et perché intendo che V. Ecc.za da pochi giorni in qua ha serrata la tratta de’ grani di questo Stato, crederei fosse espediente tenerla serrata particolarmente per essi Grigioni, et ch’ella, presentandosi occasione, si lasciasse intendere, che non la vuole concedere, per gli aggravij, et oppressioni fatte a cattolici del paese loro, mass.e della Valtellina e contorni, che sono di qua da Monti, affinche questo penetrasse alle orecchie de popoli di la da monti, li quali forse potrebbero far motivi tali, contra i sud.ti capi eretici del governo>>. Quasi alla fine della lettera, il futuro Santo mette da parte la diplomazia ed esplicitamente scrive che se il Re non dà rapidamente il suo aiuto, i Grigioni potrebbero allearsi con gli Svizzeri cattolici, alleanza che sarà discussa nella prossima Dieta, e allora tutti gli aiuti saranno vani, in quanto le loro forze saranno maggiori. Il Governatore, quindi, cominci subito con la proibizione della tratta dei grani e pubblichi la causa di tale divieto, ottenga quanto prima il permesso del Re per chiedere ai Grigioni di ristabilire la libertà per i cattolici, facendo leva sulla giustificazione di aiutare i cattolici, avvertendoli di impedire il loro commercio e di prendere sotto la sua protezione gli stessi cattolici. <<…tenendo per fermo che in occasione di tanta importanza, quanto e l’aiuto di tante anime, l’aprir la porta di far progresso fin oltre di la dà monti, alla conversione di quei popoli; et la sicurezza di questo suo Stati di Milano non mancherà di dar subito a V. Ecc.za quelli ordini e risoluzioni, che sono necessarie, et che convengono alla pietà, e zelo Christiano, col quale S. M.tà ha sempre havuta particolar protettione dalla religione catolica>>.[183]
In un documento, relativo al primo dicembre 1583, giorno della Dieta, Bernardino Morra così scrive: <<1583 il dì primo Decembre o sia pitacho de Signori Grigioni, Io Bernardino Morra comparvi doppo haver presentata la lettera (spazio vuoto) dissi alli Signori ivi congregati che potevano essere circa 70, che haveva havuto commissione da Monsignor Cardinale Santa Prassede mio padrone di venir qua a Coyra a dar conto a Monsignor Reverendissimo delle cose occorse e successe nella valle Mesolcina pertinenti al spiritual, come a pastore t ordinario, accioche potesse dare quelli ordini et far quelle provvigioni che fossero necessarie per aiuto dell’anime di quella Valle, et di qui ringratiar le signorie loro dell’amorevol offerta che haveano fatto a Sua Signoria Illustrissima di raccoglierlo et honorarlo volendo venir a transitar per il loro paese e dominio…>>,[184] quindi il Segretario dice di trovarsi li per salutare e ringraziare tutti a nome dell’Arcivescovo, il quale essendo indisposto non avrebbe potuto passare per quei luoghi e per questo porgeva le sue scuse. Fu detto al Morra di ritirarsi che subito gli avrebbero dato la risposta, poco dopo fu chiamato da Galles de Mont, Landrichter della Lega Grigia, che a nome di tutti disse che erano sempre stati favorevoli al Borromeo nel servirlo ed onerarlo quando a lui sembrerà opportuno “transitar” per il loro paesi non mancheranno di mostrare questa loro buona volontà. Morra risponde che al momento non ha disposizioni per programmare tale visita, <<…ma ben credeva che Monsignor Illustrissimo non hebbe ne pensiero di transitar per quei paesi per far visita formale ne cercar giurisdittione, ma solo per far li suoi cercoli spirituali nelli luoghi cattolici per giovar a prossimi come ogn’anno è obligato di far e così mi partei con intentione che mi dessero risposta in scritto>>.[185] Il documento riporta la firma di due testimoni. La risposta la conosciamo.
In una lettera del 3 dicembre, scritta da Roma e indirizzata a Carlo Borromeo, il Cardinale Speciano si congratula per l’esito positivo della visita in Mesolcina, ma non riesce a credere come possa fare visite formali, non perché non le debba essere permesso, ma essendo il paese tanto povero e “malavezzo”, come fanno ad eseguire poi quello che viene ordinato, specialmente se ciò comporta delle spese, come è solito avvenire in queste visite formali della Chiesa. <<Et quanto alla correttione di costumi, spero che ella sarà obedita, massime se lo si lasciarà intendere di voler tornare , o mandar Monsignor Borsato, di cui non voglio lasciar di dar conto a Nostro Signore et della sodisfattione che egli da in queste visite, et poiché Vostra Signoria Illustrissima ha paura che il Vescovo di Coira dia più fastidio che aiuto, s’ella vorrà si farà officio qui che gli sia scritto caldamente in questa materia, perché è troppo gran Travaglio et insoportabile l’haver paura che il Vescovo a cui per officio proprio tocca d’aiutare, di sfavorisca simil impresa>>.[186] Altre lettere del Cardinale Speciano ci informano di come il Papa e la Corte pontificia si rallegrino e preghino per l’esito della visita, che non deve essere abbandonata visto i frutti dati, le lettere sono datate 10, 17, 24, 31 dicembre 1583:[187] questo ci fa capire che Carlo ha tutto l’appoggio della Santa Sede e la rinuncia nel proseguire la visita non sembra essere bene accolta dal Cardinale Savello: <<Ho dato al Signor Cardinale Savello la scrittura de’ Grigioni, la quale ha letto non già con la solita consolazione, et veggo quanto saria stata più espediente se si fosse andato a dar il primo assalto al luogo più principale per ogni cosa potrò resultare a maggior servitio et honor di Dio, ma bisogna, credo io, risolversi d’andar una volta a Coira all’improviso, acciò si levi la commodità et tempo alli predicanti d’opporsi, così come hanno fatto questa volta che sono stati creduti perché quei populi simplici non sapevano il procedere di lei…>>.[188]
Carlo Borromeo tornò a Milano gli ultimi giorni di novembre, numerose furono le disposizioni ordinate per tutti gli affari ecclesiastici, che dovevano garantire i frutti della visita, che il futuro Santo scrive in una lettera inviata all’amico Cardinale Gabriele Paleotti, quando ancora si trovava a Bellinzona il 9 dicembre, in cui dice di avere trovato <<…le cose del culto divino sordide et inculte et come deserte trovato affatto: colpa et negligenza dei sacerdoti vecchi…>>,[189] i quali una parte erano di quei luoghi e non seguivano nessuna riforma, erano senza disciplina e conducevano una vita dissoluta; l’altra parte erano forestieri, vagabondi, fuggitivi ed apostati. Si può immaginare quanto gli abitanti di questi paesi siano bisognosi di aiuto spirituale visto gli esempi che hanno avuto da coloro che dovevano guidarli al bene. Il Cardinale, continua dicendo che ha lasciato nelle parrocchie solo quei sacerdoti che gli sembravano “tollerabili”, gli altri sono stati rimandati ai loro ordini religiosi oppure rimossi dalle loro cariche, assicurandosi che tutti siano aiutati, ad eccezione di <<…uno più importante et principale dei contorni sono stato sforzato dare in potere de braccio secolare, convenendo così per la gravezza et enormità de’ suoi delitti et per leggi de’ sacri canoni…>>.[190] Si tratta di Domenico Quattrino, Prevosto di San Vittore, di cui abbiamo parlato prima. Per quanto riguarda il popolo, l’Arcivescovo ha visto grande attitudine e desiderio di essere aiutato, quindi non sono mancate le pratiche religiose, seguite da gran numero di persone e con molta devozione, che hanno riportato molti alla religione cattolica in tutti i luoghi visitati, anche se qualcuno è rimasto “ostinato”. La lettera si conclude con un riferimento alle presunte streghe: <<Si è atteso anco a purgare la Valle dalle streghe la quale era quasi tutta infettata di questa peste con perditione di molte anime, tra le quali molte si sono ricevute misericordiosamentea penitenza colla abiurazione, alcuni dati alla corte secolare come impenitenti, con publica exetutione della Justitia>>.[191]
Borromeo prese anche provvedimenti per i matrimoni, poiché molte erano le unioni illegali, per l’esecuzione dei testamenti e contro l’usura. Data la situazione generale, anche l’istruzione pubblica si trovava in uno stato deplorevole, tanto che Carlo provvide immediatamente a far mandare due maestri da Milano a Roveredo; decretò la fondazione di un collegio in cui avrebbero insegnato quattro Padri Gesuiti, fu subito allestita la prima sede provvisoria in casa del Ministrale Giovan Battista Sacco, ossia Palazzo Mazzio, poi quella definitiva a Palazzo Trivulzio, che nel 1549 era stato riscattato dalla Valle che ne divenne proprietaria, nel 1552 fu venduto dalla Valle, per la somma di 1700 scudi d’oro, al Capitano Marchino aMarca, ma riscattato di nuovo dalla Valle in occasione dell’istituzione del collegio. Gli ultimi giorni di dicembre erano già arrivati due maestri Gesuiti e tutto era stato disposto per accogliere 10 o 12 alunni, infatti in una lettera datata 8 gennaio 1584 di Padre Carlo a Borromeo troviamo: <<…sappia, che già facciamo la schuola nella stanze del Palazzo, ove andremo ad abitare la settimana che verra, havendo fatto acconciare tre buone stanze, et la cucina; et mi risolvo di fare anco accomodare due altre camere, et una stanza da basso molto capace et apropriata per le scole, però che queste non sono bastevole per si copiosa moltitudine, che concorre; perciò sarà ben sollecitare la provvisione assegnata da Nostro Signore>>.[192] Il 23 gennaio Padre Carlo suggerisce, in una sua lettera, al Cardinale di sollecitare il Pontefice per l’acquisto del palazzo prima che qualcuno metta i bastoni tra le ruote, evidentemente aveva reso adatte altre stanze perché gli alunni erano più di cento.[193]
Per l’apertura dell’Istituto occorreva il permesso delle Tre Leghe, ma i Protestanti, che erano in maggioranza, scatenarono la loro offensiva a causa della presenza dei Gesuiti, che si rifugiarono nella prima sede e il Collegio dovette essere chiuso nel 1585.[194]
Nicola aMarca, fratello del Ministrale Giovanni, va a Coira il 10 gennaio 1584 e trova grandi tumulti nella città a causa della visita de Cardinale nella Valle Mesolcina, dell’istituzione del Collegio di Gesuiti e soprattutto contro il Ministrale, considerato fautore della visita, motivo di tante conversioni: <<Et questo tumulto veneva dal Imbasciatore di Francia, che si dubitava che li nostri populi volessino fare lega con il Re Catholico di Spagna, et co’ il Duca (di Savoia) per respetto di Geneva, come si dubitava>>.[195]
Le ragioni del divieto posto a Borromeo dalla Dieta e di tutti gli altri disordini, non sono solo di origine religiosa ma anche politico. Non meno preoccupante è il tenore della lettera che Galles de Mont scrive all’Arcivescovo il 13 gennaio, dove dice che non ha potuto rispondere subito ad una sua lettera per la grande confusione creata dai ministri Luterani sempre per le stesse cause, e lui è accusato di avere sostenuto la venuta del Cardinale in Mesolcina, di essere cattolico e in buoni rapporti con Borromeo. Parla brevemente delle vessazioni che i Luterani fanno ai Cattolici, ma anche se dovesse costargli la vita rimarrà sempre Cattolico, conclude dicendo che vorrebbe scrivergli più spesso, ma <<…non havendo messi fiddati non ho sapetto che fare per li grandi rumori et tumulti che erano nelle bande nostre. […] Post Scriptum la Liga nostra Grisa è in grande confussione co’ le altre du Lighe et una parte della Liga nostra quali sono Luterani aiutano favorire le altre due Lighe per questa causa>>.[196] Un’altra testimonianza della prepotenza degli scismatici e delle insurrezioni le troviamo in due lettere di Giovan Battista Sacco al Cardinale datate 9 e 21 gennaio 1584, in cui dice di essere stato detenuto per nove giorni in prigione ad Ilanz ed essere stato liberato dopo avere pagato mille Ducati di cauzione, che spera poter recuperare, tutto ciò ad opera de Protestanti e dell’Ambasciatore di Francia.[197] Tutto ciò è ribadito anche in un’altra lettera di Giovanni Marca del 30 gennaio.[198]
Tutto ciò si può riscontrare in un documento non datato, in cui viene fatta una breve relazione della Visita: il Cardinale era desiderato ed aspettato anche dagli eretici di là dei Monti, ma da Coira, dove egli sperava di poter fare opere più grandi di quelle fatte nella Valle Mesolcina, arrivò il divieto di effettuare una visita formale: <<Ma il Demonio commosse i predicanti heretici di tutto il paese alla religione catolica, et così convennero a Coira nel medesimo tempo della Dieta in gran numero facendo consiglio et prattiche non solo per impedir l’ondata del Signor Cardinale nelle sudette valli, ma per sovertir le cose fatte nella valle mesolcina con dir ch’era contra le legi, et confederationi delle tre Leghe l’haver chiamato un inquisitor d’heresie, et l’haver accettato il Signor Cardinale, et gl’aiuti suoi, e principalmente insistevano sopra l’essibitione ch’el popolo fece al Signor Cardinale d’una casa loro per habitat ione de Secolari figlioli suoi, et de’ Maestri ch’havevano da insegnar a essi figliuoli, con dir ch’era un castello, et fortezza, in modo che se bene in generale gli fosse buona disposizione et inclinazione a ricever per bene l’ondata del S. Car.le ne paesi loro nondimeno sedutti dalli predicanti cominciorno i Signori a mostrar mala sodisfattione delle opere del S.r Car.le nella valle Mesolcina, et quantoche l’Auditore mostrasse ad alcuni di loro come l’inquisitore non era stato mandato per causa d’heresie formali, ma solo per stregarie, com’era in effetto, et che la venuta, et ricevimento del Sig.r Car.le et le attioni sue non erano contra, anzi conformi alla lege loro, quali concedono ch’ogn’uno possa viver cattolicamente o nella setta Zuingliana o heretica come a ciscuno pare…>>.[199]
Il documento prosegue dicendo che la casa offerta per abitazione per i maestri dei figli non era né un castello né una fortezza, ma solo una casa che sarebbe servita a beneficio pubblico, tuttavia prevalse l’autorità dei “predicanti”, tanto più che l’Ambasciatore di Francia, il quale, in un primo tempo, si era mostrato favorevole verso il Cattolicesimo e con Bernardino Morra, fece poi marcia indietro ritirandosi da quei compiti che si era offerto di fare, anzi si schierò dalla parte dei “predicanti”, avvalorando le loro ragioni. Durante la Dieta furono eletti dei giudici particolari appartenenti a tutte tre le Leghe, <<ma in maggioranza heretici, quali havessero da ricognoscer le cose seguite per opera del S.r Car.le nella valle Mesolcina>>.[200]
Alla fine di novembre, come sappiamo, Borromeo tornò a Milano e alcuni “de’ principali” di questi luoghi furono citati a comparire davanti ai suddetti giudici delle Tre Leghe, vennero incarcerati con vari pretesti, ma furono poi rilasciati e prima di Natale rimandati alle loro case, uno di loro, “Hieronimo Borgo” di Bellinzona, fu condannato alla pena capitale per avere detto “alcune cose”, ma poi graziato, è probabile che Gerolamo Borgo,[201] sotto tortura, abbia rivelato i tentativi per procurarsi l’aiuto del Re di Spagna e del Ducato di Savoia a favore dei Cattolici: <<…forse perché dicesse ciò che s’à inteso haver deposto ch’el Padre Achille Gagliardo giesuita, qual era col S.r Car.le nella valle Mesolcina una volta ragunaste seco del trattato della nova lega con Savoia, il che afferma esso Padre non esser vero, onde si crede che gli heretici, quali hanno più in odio la congregatione d’essi Padri Giesuiti che tutte l’altre de religiosi, et claustrali habbino fatto gratia al sudetto borgo acciò dicesse questa bugia, della quale dissegnano valersene per far che tutto il paese universalmente abborrisca detta cong.ne, et a ciocché, sì come non permessero che continuasse il collegio d’essi Padri, che si cominciò nella terra de ponti della val Tellina, così non sia permesso quello che de’ medesimi Padri ha pensato il S.r Car.le di piantar nella val mesolcina si per insegnar a figlioli, come per gl’altri essercitij spirituali al qual già s’è dato principio con gran contento, et sodisfattione del popolo d’essa valle>>.[202]
L’Ambasciatore di Francia, il quale aveva cambiato opinione, come già detto, stette dalla parte degli scismatici durante il processo e rifiutò di dare al popolo e ad altri i soliti “stipendi” che era solito dare ogni anno, in tal modo si era reso odioso non solo agli uomini della Valle, ma anche ai capi della Lega Grigia, composta nella maggior parte da cattolici.[203]
Il documento prosegue spiegando le grandi vessazioni che subiscono i cattolici nei paesi dei Grigioni, soprattutto nella Valchiavenna e in Valtellina, in quanto suddite delle Tre Leghe, nonostante che per legge ognuno possa seguire la religione che vuole. (V. documento)
Da una lettera firmata Giovanni Battista Franciosi, Cancelliere di Locarno, del 12 febbraio, spedita da Varese, veniamo a conoscenza che: <<L’Ambasciator di Francia, havendo visto suscitar qualche rumori contra lui, non solo ha haiuto in Bada, ma etiandio ha richiesto alle tre Leghe littere di ben servito, dando motto di fare partenza, però le lettere gli sono state negate, anzi d’alchuni particulari è stata assalita la Casa con animo di trattarlo male, ma esso non ardì dargli orecchia ne risposta, anzi si serrò in casa. La Lega Grisa deve havere intimato guerra all’altre due leghe, non volendo cessare de suoi humori et capritij di volersi impedire di castigare li suoi per errori puossino haver fatto>>.[204] La missiva continua dicendo che stanno facendo una Dieta a Coira, dove sono aspettati i Messi del Cardinale, che tratteranno “i fatti” con molta diplomazia. Sempre dallo stesso mittente, ma in data 5 marzo 1584 e spedita da Mesocco, si può apprendere che alcuni “Jusdicenti”della Valle che avevano partecipato alla Dieta, indetta per la Lega Grigia, in Jant avevano sporto due querele verso i “Regenti” della Valle: la prima per avere accettato Borromeo in questi luoghi e <<…et seco haver fatto lega, et capitolatione segreta, seconda di haver accetatto et seguito la nuova riforma dil Calendario, con grave lamenta che ciò fuossi da essi fatto in pregiuditio della Lega lor et senza farne saputa…>>.[205] Franciosi prosegue con una lista di sanzioni date: ai “Regenti” di Rogoredo novanta scudi, come a quelli di Mesocco, a quelli di Calanca venticinque, e a tutta la Valle centoventi scudi. Hanno poi condannato a pagare venticinque scudi il Ministrale Battista Sacco e altra spesa non ancora specificata nel momento in cui è stata scritta la lettera, al medico di Soazza, Giovanni Pietro Antognini fu comminata la sanzione di venti scudi e altra somma non ancora specificata. Ancora da definire restava la causa del Podestà di Mesocco. Venne anche stabilito per tutti i religiosi abitanti nella Valle l’obbligo di presentarsi al Vescovo di Coira, senza la cui licenza non avrebbero potuto officiare, tale ordine lascia stupito il suddetto clero, che, come scrive il mittente, spera che il Borromeo scriva al Vescovo di Coira per provvedere <<destramente a questo fatto>>. Tutto questo è stato riferito dal Ministrale Giovanni Carletto di Calanca. Non manca una lettera del Dottor Antognini, il quale oltre ribadire gli stessi fatti, aggiunge che a lui <<…hanno ordinato che dobbiamo vivere all’anno vecchio fino a tanto che le lighe non accettarano il nuovo anno […] hanno poi fatto instanza assai in voler sapere si havevamo fatto qualche Capitoli (alleanze)>>.[206] Tutto ciò è confermato anche da Giovanni Battista Sacco in una sua missiva del 12 marzo 1584, da dove apprendiamo anche che <<…la scolla de nostri padri Jesuitti sia suspesa sina atanto che ditti padri se presentino da Mons.r. nostro di Cuojra hovero se meglio piacerà a sua Ill.ma Sig.ria di scrivere a nostro Mons.r Episcopo voglia venir luij in persona a vesetar la diocesi sua per debito et confirmare questi nostri padri per non descomodar quelli signori>>.[207] Seguono alcune lettere datate marzo 1584, in cui si parla delle attività pastorali e delle richieste di nuovi preti per le varie chiese della Valle.[208]
La partenza dei Gesuiti per Coira, per l’approvazione vescovile secondo le decisioni della Dieta, è del 2 aprile, padre Costanzo e padre Giovanni Battista si mettono in cammino con un cavallo avuto in prestito da padre Gentile Besozzo, mittente della lettera al Cardinale.[209] Arrivati in città <<Con più meraviglia in Coira ci guardavano et molti putti insieme cominciarono a fare romore con cridare il che mi causò un poco di paura pur mi raccomandavo al Sig.re, et sia qui eterno. Si conosse che sopra la porta della citta erano pitture de santi ma sono levate, resta solo da una banda parte della santa Judit con il capo d’Holoferne piaccia al Sig.re che per mezzo della beatissima Vergine si trochi il capo al Heresia, poi che al vedere quella citta è causa di piangere>>.[210] Svolte le loro incombenze, dubitando che la loro presenza in città fosse gradita, si rimisero subito sulla via di ritorno e durante una sosta in un’osteria videro un quadro raffigurante i Santi Pietro e Paolo, gli uomini presenti chiesero chi fossero i due alla guida, la quale disse che erano due gentiluomini milanesi, dando adito di pensare che si trovassero in questi luoghi per “il negozio di Spagna”, ma chiarita la loro identità, approfittarono dell’occasione del dipinto per parlare ai presenti <<…delli grandi travagli che hebbero li Apostoli per matenere la loro fedde massime di quello che a s. Paulo fu detto in Roma dalli Judei: De secta hac notum est nobis quia ubique et contradicitur et a questo proposito dissi loro quatro parole che vedevo le gustavano, mi pregorno stassi con loro quella sera mi scusai non potere ma quando ritornasse per quelle bande lo faria…>>.[211] Questo fatto fu di grande consolazione per i due Gesuiti, perché constatarono il bisogno di molte persone di parlare di fatti religiosi. La lettera fu spedita da Roveredo da padre Costanzo Gamma a Borromeo, il 14 aprile 1584, quindi al ritorno del viaggio a Coira.
Padre Carlo ragguaglia l’Arcivescovo con una sua lettera del 15 aprile 1584, in cui dice che dopo la visita la situazione è molto migliorata nei paesi della Bassa Mesolcina, dove gli abitanti <<…cominciano a detestare le usure, et altri peccati […] Io non potrei dire quanto tutti ci amano, et riveriscono… >>.[212] Non può dire le stesse cose Ambrogio Moresio, parroco di Mesocco, che nello stesso giorno scrive al Borromeo un resoconto sulle condizioni degli abitanti di Mesocco: i Luterani vanno ad ascoltare le prediche, ma <<…non vogliono accettar se non quel che lor quadra come fanno heretici>>, continuando con i loro riti e condannando i modi di amministrare i sacramenti della Chiesa cattolica. Nonostante ciò alcuni di loro hanno consegnato i libri luterani scritti in lingua tedesca. I Cattolici, per la maggior parte, si sono confessati e comunicati, ma sono ancora molti quelli che non hanno aderito a questi sacramenti, perché hanno promesso alla Lega di continuare a seguire il vecchio calendario che non coincide con la Pasqua di quello gregoriano,[213] ma, dice il mittente che sono tanto rozzi ed ignoranti che bisogna prenderli come sono. Ci sono ancora degli usurai pubblici molto ostinati. Sono state eliminate alcuni eccessi, come quello di suonare le campane per tutta la durata della Messa e le donne non piangono più in chiesa durante la celebrazione dell’ufficio per i defunti, tali lamentazioni impedivano di ascoltare le funzioni. Moresio continua dicendo che non viene più importunato come prima per seppellire i morti subito dopo il decesso. Sono stati celebrati alcuni matrimoni secondo la forma del Concilio tridentino. Sono stati fatti solo piccoli progressi, infatti il parroco inizia la sua lettera con queste parole:<<Di quel poco frutto che Nostro Signore si è degnato di operar in questa piccola vigna di Mesocco dopo la partita di V. S. Ill.ma…>>.[214] Il 23 maggio, padre Carlo, in una sua lettera al Cardinale, conferma le numerose difficoltà incontrate a Mesocco: <<Ma se Musoch si espugnerà con la divina et infallibil verità, gran vittoria si acquisterà; in quei giorni in cui sono stato, ho conosciuto che l’inimico lì tiene il suo castello, et si bene vi sono alcune anime timorate, nondimeno i contrapesi sono molto potenti>>.[215]
Nonostante la ferrea volontà del Borromeo di rigenerare completamente e secondo i decreti del Concilio di Trento l’istituzione della cura pastorale di questi luoghi della Valle Mesolcina, furono rieletti i sacerdoti che erano stati sospesi con il pretesto che erano originari della Valle, anche se al loro posto il Cardinale aveva mandato altri religiosi. Molte furono le dispute per l’accettazione del nuovo calendario e numerosi i documenti in cui se ne parla, il Prelato invia lettere a Galles de Mont, al Preposito di Coira, al Ministrale di Roveredo, alla Lega Grigia, ai Ministrali e al Consiglio della Valle Mesolcina, in cui dice che non si può tornare a quello vecchio, perché incorrerebbero nelle censure di cui nella Bolla pontificia, inoltre la non osservanza creerebbe grossi disguidi.[216] Alla fine ci fu un compromesso: sarebbe stato osservato il nuovo calendario solo per le feste liturgiche, ma, rispetto al resto del Cantone verrebbe seguito quello vecchio: <<Circha al calendario siamo stati travagliati pur troppo. Et fra noij dilla valle era gran confusione, hora Iddio laudatto habbiamo riduto e fatto a bono fine, che che nel scriver litere holtra li Monti scriver alla vechia, nel resto si sottoponiamo in tutto alla obedientia de nostri sacerdotti et fare le feste quando da lor ne sara comandatti>>.[217] Ma da una lettera del 25 agosto veniamo a conoscenza che il parroco di Santa Maria di Calanca ha celebrato la festa dell’Assunzione e tutte quelle precedeti secondo il vecchio calendario, andando conttro gli ordini ricevuti e suscitando “grande mormorazione” in tutta la Valle.[218]
I problemi da risolvere e le difficoltà erano ancora moltissime ed a tutto questo si aggiungeva la mancanza di possibilità economiche delle parrocchie, i morti seppellita dai civili per la scarsità del clero, specialmente quello “habile”, la confusione negli officianti e nel popolo causata dal contrastato passaggio al nuovo calendario, che essendo decretato dal Papa veniva rifiutato dai riformati e da alcuni preti cattolici per timore dei Signori delle Leghe, infine in molti luoghi della Valle stavano progredendo i casi di peste. Numerose sono le lettere del Cardinale in risposta a tante richieste e lamentele, il quale era, come sempre, molto informato dai suoi “uomini”, soprattutto da Sacco e da Giovanni Pietro Stoppani, nominato Vicario della Valle Mesolcina dal futuro Santo, di tutto ciò che accadeva in quei luoghi e dintorni.
Tra la miriade dei documenti esistenti riguardanti la Visita Apostolica del 1583, certamente il più importante è costituito dalla relazione inviata dal Cardinale Borromeo a Roma al Cardinale Paleotti, essa è divisa in tre parti: la prima è spedita da Roveredo il 15 di novembre; la seconda è la “Relatione sumaria del successo della visita della valle Mesolcina doppo l’altra relatione, del 29 novembre; la terza si tratta di un’aggiunta spedita successivamente da Bellinzona il 9 dicembre . Le tre relazioni sono state pubblicate frammentariamente da Paolo d’Alessandri nel 1909 e integralmente da Rinaldo Boldini nel 1962. Noi riporteremo i passi più significativi, rimandando per una lettura completa alle opere dei suddetti autori.
La prima relazione si apre con una spiegazione della Lega Grigia, che è divisa in otto parti, quattro delle quali cattoliche e quattro “eretiche”, la Visita Apostolica viene effettuata in una delle otto parti, divisa in due “governi principali”, Roveredo e Mesocco, i cui abitanti sono circa undicimila: <<…’l popolo minuto è comunemente catholico assai semplice, et atto alla obbedienza se non che corre senza ritegno alcuno à mangiar cibi prohibiti in ogni giorno, quando si trova in paesi eretici, ma alcuni massime de principali sono heretici ne è meraviglia, sì per il continuo commercio et collegatione c’hanno con gli altri Grigioni convicini eretici, come anco perché sono qui vissuti molti anni quei due famosi eretici il Trontano, et il Canessa, et vi morì anco gli anni passati quel Lodovico Besozzo… […] Hora essendosi fatti varij officij privati non si è trovata alcuna dispositione ad abiuratione nel foro esteriore ancorchè secreta, né pur via da far processi in questo genere fuori della cosa delle strghe sì perche queste genti sono assai sospettose di natura, et inimici ad ogni cosa che paia à loro di legame come per la convetione che hanno insieme le tre leghe, che ciascuno possa viver a suo modo, ne si incolpi alcuno per questo conto>>.[219] In questa prima relazione, quindi, Borromeo dà una valutazione abbastanza positiva della popolazione, che è ancora osservante e rispettoso, ma molto ignorante e confuso dal pessimo esempio del clero eretico e corrotto e da quello delle persone autorevoli.
Molto comuni e profondamente radicate erano le superstizioni e la credenza ai malefici, tanto che eresia e perversità sono accomunate, non dimentichiamo che Borromeo durante il suo primo Concilio Provinciale ordinava che maghi, malefici, incantatori e chiunque avesse fatto patto col Diavolo venisse severamente punito ed escluso dalla congregazione dei fedeli;[220] il Borsatto, che, come scrive il Possevino, aveva <<…prattica grandissima di queste materie di heretici e di streghe…>>,[221] accostando i termini “stregheria-eresia”, doveva essere veramente molto pratico della materia, poiché in poco tempo <<…ne sono in processo circa 40 e processate più di 100…>>,[222] un numero molto elevato se pensiamo che la popolazione globale di tutta la Valle Mesolcina ammontava a undicimila anime, addirittura come possiamo apprendere anche da una testimonianza di Monsignor Ottaviano Forerio, Arciprete di Milano, <<Il Si.r Cardinale fece abiurare in una sala circa 150 (involti in stregamenti)>>.[223]
Le streghe erano “governate” da apostati, fuggitivi, scomunicati e irregolari. In questo primo ragguaglio si parla anche della creazione di un collegio di padri Gesuiti a Roveredo, degli usurai e dei matrimoni irregolari, cioè con parentela proibita o per divorzio.
“La Relatione sumaria del successo…”, ossia la seconda, inizia parlando dell’altra parte della Mesolcina, il cui centro è Mesocco. Questa parte <<…si è trovata nelle cose della fede molto più infetta che l’altra>>, perché adiacente alla Valle del Reno, quindi più soggetta all’eresia calvinista, dilagata maggiormente nell’alta Valle confinante col nord: <<…è per la maggior parte heretica; è vero che pochi huomini sono a casa stando fuori per mercantia, le cui donne pure sono heretiche, et i figliuoli allevati nella medesima perditione>>. L’Arcivescovo parla dell’abbandono in cui versano le chiese, del culto che non viene officiato, a causa della condotta e del concubinato dei preti; della pratica dell’usura, ancora dei matrimoni irregolari e dei libri eretici da eliminare. Una causa molto importante per la diffusione delle eresie, continua il Borromeo, <<…è l’habitatione qui che n’hanno havuto quei tre nomati nell’altra relatione, cioè il Canossa, Trontano, et poi il Besozzo, et prima di loro tutti, un frate Aurelio Apostata dell’ordine franciscano Zocolante, che fù primo seminatore di questa Zizania, oltre che ve ne habitano adesso ancora alcuni arrabbiati, et ostinati grandemente nell’heresie, et spetialmente un Franceso Socino da trent’anni in qua, et doi, o tre altri del paese qua, tra i quali è il figlio del Trontano con le famiglie loro, et alcun’altre donne diaboliche à fatto, ma sopra tutti quel Socino è il sostegno qui di questa peste…>>.[224] Anche in questa relazione troviamo, come nella prima, la stessa forma degli esrcizi spirituali proposti alla popolazione che, anche in questi luoghi, ha partecipato numerosa e con grande interesse.
Il futuro Santo torna a Roveredo, dove si occupa della spedizione delle cause delle streghe, le cui sentenze sono state emesse parte il 28 e parte il 29 novembre <<…con le abiurationi di quelle, che si ricevono à penitenza, intorno alle quali abiurationi non s’è anchora fatta intiera risolutione del luogho, et modo più o meno publico, per la varietà de li humori, et fattioni, che sono ne gli huomini di questa valle […]di non condannare mai a morte alcuno se non confessa formalmente il delitto, quantunque fusse convitto per mille testimonij…>>.
La terza relazione comprende tutti i nomi e i cognomi delle presunte streghe e degli eretici: quattro (4) streghe impenitenti, condannate per la loro confessione e consegnate al braccio secolare; altre sei (6) sempre impenitenti e “convinte” seguirono la sorte delle prime quattro. Le presunte streghe bruciate vive furono, dunque, dieci e non undici o dodici come riportano vari articoli. Il Prevosto Domenico Quattrino, di cui abbiamo parlato prima, fu condannato, oltre che per avere confessato di essere uno stregone e capo delle streghe, anche per altri delitti, quindi fu degradato dal Borromeo e dato al braccio secolare. [225]
Sedici (16) furono le persone, imputate e sospettate di “stregharie”, sottoposte a tortura furono assolte dopo l’abiura e le penitenze: <<…et alcune per altre ragioni hanno purgato gli indicij, sì che tutti questi sono stati assoluti>>.[226]
La lista dei sospettati, non sottoposti a tortura, ma dopo aver <<…fatta purgazione canonica sono stati assoluti, e liberati con penitenze salutari>> è composta da cinquantasei persone tra uomini e donne e, dai loro cognomi, sembrerebbero coinvolte intere famiglie.[227]
Quattordici (14) sono le presunte streghe confesse, ma penitenti, che hanno abiurato privatamente, ma alla presenza di molti testimoni, dopodiché sono state liberate con “penitenze salutari”, quindi non sottoposte a giudizio formale.[228]
Cinque donne e due uomini confessarono di essere streghe e stregoni, ma a causa dell’età ( non sappiamo se troppo giovani o troppo vecchie) furono liberate senza l’abiurazione, facendo solamente la penitenza.[229]
In contumacia, con il termine di sei mesi a comparire per essere ascoltati, in quanto sospettati, furono condannate cinque persone.[230]
Nel Ms. F 166 inf., a c. 524v. e 532v. troviamo un indice di eretici di vari luoghi della Valle Mesolcina e di coloro che si sono convertiti, tra questi figura anche Samuele Viscardi, detto Trontano, figlio dell’eretico Giovanni Antonio.[231] I convertiti sono diciotto più un certo Todesco che ha promesso di convertirsi; viene poi precisato che non sono descritti minuziosamente gli eretici di Mesocco, confinanti con la Valle del Reno, perché troppo numerosi, mentre la lista con i nomi delle streghe, <<…che sono venute à penitenza sono al numero de 22 in circa, ma si manderà col primo ordinario>>. Da evidenziare che molti degli eretici descritti appartengono a ceti elevati: <<gente di molto seguito, et auttorità per podestarile et officij di governo essercitati>>. Troviamo ministrali, podestà, cancellieri, notai con le loro mogli e figli.[232]
La terza relazione continua dicendo che sono cominciati i lavori per il Collegio, e prima di Natale potranno abitarci i padri Gesuiti per poi cominciare le lezioni agli allievi che sono già un centinaio circa. Per ciò che riguarda le streghe: <<Hanno a Roveredo fatto abbruggia vive le quattro streghe condennate per la confessione, l’altre che furono condennate come convinte, le hano fatto confessar tutte ecctt’una, sì che fra pocchi dì potrebero forse anco far la medesima essecutione contra esse, se bene alcuni dicano che una o doi otteranno gratia della vita dal popolo>>. Il Prevosto Quattrino ha confessato, sotto tortura, i suoi “enormi delitti”, <<…sì che dicevano di volerlo far morir anch’esso, vero è che sin’hora non hanno fatto essecutione alcuna>>. Esecuzione che, come abbiamo già detto, non fu mai fatta.
Il rapporto termina dicendo che alcuni sacerdoti e frati dal comportamento indegno e corrotto sono stati sollevati dal loro incarico e cacciati da questi luoghi.
Questa Visita Pastorale così travagliata ebbe anche grandi successi, poiché, essendo compito generale del Borromeo di ristabilire le condizioni religiose, morali e di purificare la Valle dalle streghe, in molti luoghi raggiunse i suoi scopi, ma certamente non ritenne completata la sua opera, non potendo proseguire la visita in Valtellina e Valchiavenna, dove il bisogno di risanare le condizioni religiose sarebbe stato altrettanto necessario.
Carlo Borromeo, personaggio scomodo, pieno di contraddizioni e tanto discusso, ma nonostante la sua presunta misoginia, aiutò moltissime ragazze povere, si prese cura sempre delle sorelle e combinò loro matrimoni con i partiti appartenenti alle famiglie più importanti d’Italia: i Colonna di Roma, i Medici di Firenze, i Della Rovere di Urbino, i Gonzaga di Mantova, dal folto epistolario trattenuto con esse si può capire l’attaccamento che avevano con il fratello, anche se Carlo preferiva il rapporto epistolare a quello personale. Molti lo hanno criticato per il suo modo di vivere, per quanto molto ricco improntò la sua vita all’insegna dell’estrema sobrietà: pane e acqua, vesti logore dall’usura; poche ore di sonno in un letto di tavole. Effettuava le Visite pastorali nella sua diocesi senza preoccuparsi della stagione, quando altri Vescovi aspettavano la stagione mite per non soffrire il caldo e il freddo.
Quando arrivò come Arcivescovo a Milano, in quella città retta dal Re di Spagna tramite Governatori assistiti dal Senato, che vivevano nel lusso sfrenato in palazzi fastosi, con numerosa servitù, ma dietro la pomposità delle feste, balli e spettacoli c’era l’inizio della decadenza di Milano e della Lombardia, depredate continuamente dal fisco spagnolo e la mentalità di questo Governo arretrato, rimasto agli ideali cavallereschi medievali, sfrontato, che spadroneggiava in casa d’altri, come ben ce lo descrive Manzoni all’inizio del suo romanzo “I Promessi Sposi”, dando un’idea molto chiara della Lombardia e di Milano sotto l’egemonia ispanica, gravemente decaduta sia nella sfera morale che religiosa: da più di un secolo i suoi predecessori non risiedevano nella città, questa è la Milano che trovò Borromeo, la cui severità di vita non poteva andare bene a molti abituati a tali costumi, per questo ci furono scontri tra il Prelato e il Governo, che certamente gli resero la vita tormentata e burrascosa sia dal punto di vista ecclesiastico sia da quello civile. Malgrado le controversie giurisdizionali, molte riforme caroline furono attuate, trasformando profondamente la struttura della sua Diocesi, che risultò infine composta da 6 regioni e 65 pievi, in cui vi erano 2220 chiese secolari, 46 collegiate, 753 parrocchiali, 783 benefici semplici, 631 oratori, 7 collegi per chierici, 136 conventi di vari ordini religiosi, 740 scuole di dottrina cristiana, 886 confraternite, 24 congregazioni e 40 istituti di assistenza.[233]
Tra tanti casi di esecuzioni di streghe, quello della Mesolcina è molto e bene documentato: bisogna ricordare che sia la letteratura sia la scienza guiridica del secolo XVI presentava la stregoneria come una realtà. Le leggi della maggior parte dei Paesi europei, il codice criminale “Nemesis carolina”, emanato da Carlo V nel 1532, gli statuti civili della Mesolcina stabilivano il rogo per i condannati per stregoneria e tra i centocinquanta circa accusati di tale reato solo dieci furono le persone condannate, infatti il Borromeo in una lettera al Vescovo di Bergamo, in cui parla dei successi avuti durante la visita in Mesolcina, così si esprime: <<Si è anco atteso a purgare con essatta diligenza il piu che si è potuto la Valle dalle peste delle strghe, che possedeva tante anime di quel paese>>.[234] In tale contesto storico, Carlo Borromeo, come Arcivescovo della Diocesi più importante del mondo cristiano e Delegato pontificio, soprattutto indefesso paladino della Chiesa di Roma e tenace fautore della Controriforma, doveva rispondere alle attese della società civile, che pretendeva una condotta perentoria per coloro che diramavano le eresie, le superstizioni e la stregoneria, ma tutto questo non significa che fosse un uomo senza difetti.
Non possiamo certo non considerare che Carlo era anche un uomo del suo tempo, e ricoprendo una carica così alta non possiamo biasimarlo se il suo sogno era quello di riportare la Chiesa ai valori e alla moralità primitiva, attuando i decreti emanati durante il Concilio di Trento, avviando un grande lavoro di riforma della sua Diocesi, contro l’abusivismo, la corruzione e l’arbitrio di coloro che occupavano alte cariche, non sempre ci riuscì, ma conseguì molte “vittorie” e creò numerose e valide istituzioni in gran parte con spese personali.
Durante la peste del 1576, vista come un castigo divino necessario per liberare Milano dal peccato, si prodigò sfidando il contagio e aiutando la popolazione; cercò di arginare l’espansione della Riforma con sistemi di sorveglianza sui forestieri provenienti dal Nord, sempre a tale scopo esercitò un forte controllo sulla stampa, scomunicò uomini importanti e come tutti i grandi uomini fu molto amato e molto odiato.
La sua credenza nella stregoneria è veramente sconcertante e condivisa da molti uomini anche di elevata cultura e altolocati del suo tempo, ma bisogna anche considerare che, all’epoca, non erano ben chiari i limiti tra magia ed eresia, anche se questo non scusa la morte sul rogo di varie persone, le cui condanne, tuttavia, secondo le approfondite ricerche fatte da Rinaldo Boldini risulta che in nessun resoconto delle visite pastorali effettuate dal Borromeo, al di fuori della Mesolcina, vengano indicati processi di stregoneria istruiti dal Cardinale: <<Si fa colpa da taluno al Borromeo di aver crudelmente fatto colpire gente incolpata di stregoneria, e di aver perseguitato sotto il pretesto di stregoneria e fatto mandar al rogo gente colpevole solo di persistere nel protestantesimo. Nessuno ne ha però finora addotto la prova. Io ho consultato un abbondante materiale, letti parecchi dei processi di stregoneria svoltisi a quell’epoca a Roveredo, ho fatto con viva curiosità scientifica le maggiori possibili ricerche ma non ho trovato neppure indizi sicuri carico di lui per una persecuzione religiosa di questo genere>>.[235] L’inquisitore Borsatto, che, come detto, fu in Mesolcina circa un mese prima del Prelato, processò oltre cento persone sospette di stregoneria, tra queste anche il Prevosto Domenico Quattrino, di cui quaranta furono riconosciute colpevoli di questo reato, ma molte di loro si pentirono pubblicamente e quindi furono graziate. Nel 1909, Paolo d’Alessandri scrive che tali condanne si ridussero a circa una dozzina di persone. In ogni caso, nel diritto del Grigione, spettava al braccio secolare, costituito da giudici laici vallerani, il diritto di emettere una sentenza di morte, di eseguirla oppure di graziare il condannato e tale diritto non ammetteva la condanna a morte se non c’era anche il riconoscimento del reato, senza pentimento, dell’imputato. Come nel resto dell’Europa, anche in Svizzera i processi per stregoneria aumentarono intensamente sia nei Cantoni riformati sia in quelli cattolici dopo la metà del XVI secolo per diminuire solo verso la metà del secolo successivo, anche se nei Grigioni moltissimi processi documentati risalgono alla seconda metà del secolo XVII, (dal 1580 al 1655 si contano almeno 1000 processi), l’elevato numero fu probabilmente causato anche ad una forte frammentazione dell’amministrazione dell’alta giustizia.
Tipico dei processi per stregoneria in questi luoghi fu il poco rispetto per le norme dell’ordinamento del Tribunale Criminale Imperiale, emanato da Carlo V durante la Dieta di Augusta del 1530 e entrato in vigore nel 1532: la “Constitutio criminalis Carolina” aveva la funzione di unificare il diritto nell’Impero e impedire l’arbitrio in abito di giustizia penale; infatti, da molto tempo, era sufficiente una sola testimonianza attendibile per la condanna per malificio: in Svizzera, prima di procedere alla tortura non veniva rispettata la prassi di inviare il fascicolo ad un’autorità preposta, come disposto nella “Constitutio criminalis Carolina”, secondo cui solo il maleficio era condannabile. Molti processi per stregoneria erano originati da conflitti tra vicini e parenti, i capri espiatori erano spesso persone con difetti fisici, donne vedove e sole o che si comportavano in modo non conforme, i periodi di carestie vedevano un aumento di queste accuse e questo spiega, anche se in parte, perché questi processi abbero il loro culmine negli anni che vanno tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento, periodo noto per gravi problemi di ordine sociale, economico, politico e religioso.
Lo stretto legame tra eresia e stregoneria fu anche il retaggio di un’ortodossia confessionale, che spesso cercava delle certezze nella demonizzazione di credenze non autorizzate. La diminuzione e poi la cessazione di questi processi alla fine del secolo XVII, sembra sia stata determinata anche dalla stabilizzazione delle Chiese confessionali, che rafforzarono la loro presenza tramite la disciplina ecclesiastica, il catechismo e le visite, molto importante fu il potere della filosofia razionalista sulla dogmatica del diritto, particolarmente sulla produzione delle prove giudiziarie.[236]
Alla fine del secolo XVI, la morte di dieci donne presunte streghe non fece grande scalpore presso l’opinione pubblica, anche perché non erano state uccise, ma purificate.
Questa non fu l’unica Visita pastorale che il Prelato fece in questi luoghi, poiché durante il suo episcopato andò personalmente per ben cinque volte nelle Tre Valli svizzere, raggiungendo a dorso di mulo o a piedi le zone di alta montagna e le parrocchie più isolate.
L’attività pastorale era ritenuta dall’Arcivescovo fondamentale per capire le necessità dei fedeli e i mezzi con cui attuare i suoi disegni di restaurazione religiosa, egli percepiva come un suo profondo dovere di ecclesiastico portare uno stimolo vitale nella logora impostazione della Chiesa di Roma con i decreti del Concilio di Trento, e, allo stesso tempo, attuare una barriera efficace al dilagare delle dottrine riformate, che dal nord si diffondevano nella sua Diocesi e in tutta l’Italia.
Ma non può non essere ricordato come il motivo fondamentale dell’abbandono della fede cattolica venga, dal Borromeo, fatto ricadere sui sacerdoti, sulla loro negligenza della predicazione evangelica, sulla loro vita peccaminosa e l’apostasia come conseguenza estrema del non bene operare. Per L’Arcivesco Borromeo: <<Se i sacerdoti saranno santi, similmente sarà santo il popolo>>.
Nella relazione finale della causa di canonizzazione di Carlo Borromeo, un intero capitolo viene dedicato all’impegno che il futuro santo ha impiegato nella difesa della fede e nella lotta contro le eresie: la Congregazione Romana dei Riti doveva dimostrare che il Cardinale aveva ottemperato in modo esemplare a quello che il Concilio tridentino indicava come primo dovere del vescovo, ossia la difesa della fede.
L’azione dell’Arcivescovo di Milano nella repressione dell’eresia nella sua Diocesi e dintorni aveva assunto notevole importanza, tanto che in un’ode del 1610, scritta da Agrippa d’Aubigné, calvinista francese, troviamo scritto in modo molto sarcastico: <<S’il falloit par la perfidie/ Faire la guerre à l’hérésie/ Dispenser d’un serment formé/ Et faire tomber dans un piège/ Ceux qui n’adoroient pas le Sainct-Siège/ On employait Sainct Boromé.[237] (Se occorreva, con la perfidia/ Fare la guerra all’eresia/ Dispensare da un giuramento pronunciato/ E fare cadere nella trappola/ Coloro che non adoravano la Santa Sede/ Si faceva ricorso a San Borromeo). Questi versi sferzanti, ma molto emblematici, ci fanno capire la centralità della lotta contro l’eresia nel programma di Carlo dal 1566, anno del suo trasferimento definitivo a Milano, fino alla sua morte, d’altra parte fin dagli inizi del suo episcopato aveva chiaramente palesato di fare dei decreti del Concilio di Trento la base tenace( coerente perseverante pertinace) della sua azione pastorale e se la difesa della fede rappresentava per lui il primo dovere di un vescovo, certamente si rese conto dei pericoli ai quali era esposta la Diocesi di Milano, geograficamente inserita in una regione a stretto contatto con i territori protestanti e che ne aveva subito presto le conseguenze, tanto che già nel 1563 Filippo II aveva chiesto al Pontefice (Poi IV) di introdurre l’Inquisizione spagnola nello Stato di Milano. Progetto fallito prima di entrare in vigore a causa del malcontento del Collegio cardinalizio e, soprattutto, delle proteste dei cittadini milanesi, intimoriti che fosse reso operante un tribunale con procedure molto più severe di quelle vigenti, comunque quando nel 1566 circolava la voce che il Re di Spagna tentasse di nuovo di far introdurre la suddetta Inquisizione, Borromeo espresse la sua decisa opposizione.
Prima di stabilirsi definitivamente a Milano, il Cardinale, nel settembre 1565, presiedette il primo Concilio provinciale, facendo pronunciare a tutti i presenti la professione di fede tridentina, ossia quella norma che Pio IV aveva resa obbligatoria già nel 1564, per tutti coloro che erano investiti di benefici ecclesiastici, consistente in una solenne dichiarazione di adesione alle fondamentali verità della fede cattolica, all’accettazione dei provvedimenti tridentini e delle condanne contro le eresie in essi enunciate, tutto ciò fu ribadito nel III Concilio provinciale del 1573 e in quello del 1579 (V Concilio), in cui Borromeo stabilì che la professione di fede fosse obbligatoria per il clero secolare e regolare, i cui appartenenti avevano licenza di confessare o predicare, ma anche ai laici che, per la loro professione, avessero ascendenza particolare su altri, quindi l’obbligo, che già valeva per i docenti, fu diffuso anche per i medici e nel 1582, durante il VI Concilio provinciale tale obbligo fu esteso anche ai librai e agli stampatori.
Teoricamente l’obbligo della professione di fede rappresentava una garanzia all’ortodossia, con la conseguenza di una serie di rigorosi controlli, di un sistema di sorveglianza e di una rete di informazioni molto stretto, che sconvolse coloro che erano vissuti nell’incuria e nella negligenza dei decenni precedenti. Non bastava esercitare una stretta sorveglianza sulla popolazione milanese e in quella delle diocesi vicine per prevenire l’eresia, ma occorrevano anche misure di controllo sugli stranieri provenienti dai paesi protestanti, data l’intensità dei traffici commerciali con la Svizzera, i Grigioni e la Germania. Nel 1573, durante il III Concilio provinciale, Borromeo aveva emanato disposizioni per cui chi doveva andare in paesi protestanti, doveva chiedere prima una permesso al parroco o al delegato diocesano se si fosse trattenuto per piú di un anno, gli interessati dovevano essere muniti di un attestato, firmato dal proprio vescovo o da chi ne faceva le veci, in cui era dichiarato che l’intestatario era e viveva da buon cattolico e fin dalla partenza veniva strettamente sorvegliato, in tal modo il Borromeo aveva precorso le norme emanate poi nel 1580 da Gregorio XIII. Tutte queste misure cautelative erano però insufficienti, in quanto non potevano controllare coloro che arrivavano a Milano provenienti da paesi che avevano aderito alle nuove dottrine, poichè i trattati commerciali conclusi tra lo Stato di Milano, la Svizzera e le Leghe Grigie permettevano anche ai mercanti non cattolici di praticare i loro scambi nel Ducato milanese e il fatto che tali accordi fossero garantiti da istituzioni laiche, limitavano il potere ecclesiastico, che non poteva impedire ai mercanti di passare al di qua delle Alpi. La sorveglianza dei forestieri era quindi demandata ai parroci, i quali imponevano ai cattolici il divieto di ogni rapporto con tali persone. Le pressioni del Cardinale sulle autorità laiche per ridurre la circolazione degli eretici, non sempre veniva accolta, anche perché i vari governatori, oltre non avere sempre buoni rapporti con il Borromeo, erano combattuti tra la politica controriformistica di Filippo II e la tutela degli interessi commerciali e dei rapporti di vicinato con la Svizzera ed i Grigioni. Carlo, con l’aiuto della Santa Sede, riuscì ad ottenere che tutti quelli che a causa di una condanna per eresia erano fuggiti dallo Stato, fossero impediti (interdetti) della libertà di commercio.
La frequenza degli interventi legislativi evidenziano la priorità che il Cardinale assegnava alla lotta contro l’eresia nel suo programma episcopale: l’azione preventiva doveva essere finalizzata ad una azione repressiva che si sarebbe concretizzata in un’eventuale condanna di coloro che fossero risultati rei dell’accusa di eresia, quindi l’attività dei vescovi non poteva limitarsi all’emanazione di norme preventive contro l’infiltrazione e diffusione dell’eresia. Nella Diocesi di Milano, come anche in altre diocesi italiane, i tribunali competenti per i reati in materia di fede erano il Tribunale vescovile e quello dell’inquisitore, i cui rapporti erano regolati da una Costituzione papale emanata nel 1317 ed ancora in vigore ai tempi del Borromeo, la quale stabiliva che sia il vescovo che l’inquisitore potevano istruire le cause indipendentemente l’uno dall’altro, mentre non potevano procedere nelle fasi principali del processo separatamente, soprattutto nel momento della sentenza, che doveva essere pronunciata da ognuno dei due giudici obbligatoriamente presenti e con il voto favorevole di ambo le parti.
Dopo la prima istituzione della Congregazione dell’Inquisizione del 1542, il papato aveva iniziato ad esercitare un’azione sempre più capillare e con ampie facoltà sull’attività svolta dal Santo Uffizio e dai tribunali episcopali, segnando in tal modo l’inizio di un processo di accentramento dei poteri nella lotta contro l’eresia.
Borromeo tiene una stretta corrispondenza con il Cardinale Scipione Rebiba[238] prima e con il Cardinale Giacomo Savelli,[239] dopo la morte del primo, entrambi Grandi Inquisitori della Congregazione della Romana e Universale inquisizione, e, da questo scambio epistolare possiamo evincere che la lotta contro l’eresia si svolgesse ormai sotto l’attenta vigilanza di Roma, infatti la Congregazione non si limitava a spedire a Carlo istruzioni e direttive per i processi, ma ne verificava anche l’esito facendosi mandare le copie delle sentenze e spesso anche l’intero fascicolo processuale. Nonostante ciò il Cardinale di Milano, nel 1582, quando fu nominato Visitatore Apostolico in Svizzera e nei Grigioni, ottenne facoltà amplissime, come assolvere e riconciliare eretici, avvalersi della collaborazione di religiosi senza chiedere permessi ai loro superiori e poter subdelegare tali facoltà. Tutto questo era dovuto all’alta considerazione che la Santa Sede aveva nei confronti di Carlo Borromeo sia sotto il pontificato di Pio V che sotto quello di Gregorio XIII, affidandogli incarichi e missioni molto importanti anche fuori dello Stato di Milano, tutto questo non implicava un’esautorazione del Tribunale dell’Inquisizione milanese, anzi, sembra, dalla scarsissima documentazione rimasta, che i due tribunali operassero osservando le proprie regolamentazioni, anche se l’Arcivescovo aveva un certo controllo sulle attività del Santo Uffizio in materia di repressione anticlericale, e, spesso ci fu reciproca collaborazione ad eccezione di alcuni occasionali conflitti.
Il Borromeo conosceva la situazione della Valle Mesolcina ed era cosciente che la lotta contro l’eresia che si era propagata in quei luoghi non poteva essere combattuta come chiara (autentica)repressione, quindi cercò di darle un’impronta missionaria che sfociò in un numero considerevole di conversioni, di cui, oltre al fervore del Cardinale e dei suoi collaboratori, non fu estranea l’attività dei predicatori Francesco Panigarola e Achille Gagliardi, riuscendo a mantenere nella maggior parte del popolo della Valle la fede cattolica. Il futuro Santo si preoccupò molto anche per ottenere il supporto economico dalla Santa Sede per il mantenimento del Collegio fondato a Roveredo, e, dopo il divieto di recarsi in Valtellina, si avvalse anche delle autorità civili milanesi per ottenere una più ampia libertà di culto per i cattolici della Valtellina e Valchiavenna.
Abbiamo visto che la richiesta di procedere contro le streghe e stregoni della Valle era stata fatta dalle autorità civili della Mesolcina, richiesta che il Cardinale accolse mandando l’inquisitore Borsatto a Roveredo prima ancora della propria partenza verso questi luoghi e in una lettera, già menzionata, al Cardinale Savello del 18 agosto 1583 troviamo: <<Intanto mando a V. S. Ill.ma la copia d’una lettera scrittami dal Ministrale di Roveredo, principal persona della Lega Grigia, dove ella vedrà la richiesta che quelle genti mi fanno d’un inquisitore. La persona che si dimande, è necessario che sia molto circospetta e moderata, perché quelle genti procedono terribilmente alla cieca contro ogni persona, di cui sospettino un poco, in questo particolare, per l’estremo odio ch’eglino hanno alle stregherie>>.[240] Sembra, quindi, che il Borromeo abbia agito di conseguenza, convinto che la giustizia ecclesiastica sarebbe stata più moderata di quella secolare.
La prevenzione e la repressione delle eresie rapprentarono per Borromeo un obiettivo molto importante nella sua attività episcopale, e, se, in molti casi, riuscì nel suo intento di difensore della fede cattolica, fu dovuto anche ad una più approfondita preparazione e responsabilizzazione del clero, attraverso varie iniziative mirate a favorire la rinascita della vita religiosa.[241]
[1] Cfr. A. Prosperi-P.Viola, Corso di Storia. Dal secolo XIV al secolo XVII, Einaudi Scuola, Milano 2004, p. 266 e segg.
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Cfr. D. Maselli, Alla ricerca delle radici della Riforma Protestante e della Riforma Cattolica, Firenze 1994, p. 18 e segg.
[5] D. Maselli, Alla ricerca delle radici… cit., p. 22.
[6] Ibid.
[7] Cfr. A. Agnoletto, Storia del Cristianesimo, Milano 1978, pp. 257-259; Si veda anche A. Prosperi,I tribunali della Coscienza: inquisitori, confessori, missionari, Einaudi 1996)
[8] Cfr. L. Fabbri, La Visita Apostolica di Monsignor Giovan Battista Castelli nella Diocesi di Volterra nel 1576, in “Tra Riforma e Controriforma. Note biografiche e Storiche a cura di D. Maselli, Firenze 1996, p. 143 e segg.
[9] In questo brevissimo e non esaustivo escursus della storia del secolo XVI, abbiamo evidenziato solo i fatti più rilevanti e finalizzati al presente articolo
[10]A. Agnoletto, Storia del Cristianesiomo cit…, pp. 269-272.
[11] L’Ordine degli Umiliati nacque nel XII secolo come aggregazione di laici desiderosi di vivere in comunità simile a quella apostolica e seguendo in modo rigoroso i dettami del Vangelo, in contrasto con i costumi rilassati e con la ricchezza ostentata del clero, nel 1201 furono riconosciuti ufficialmente da papa Innocenzo II i tre ordini composti da religiosi appartenenti all’”Ordo canonicus”, da laici che vivevano in comunità con “formula et regula vitae” e da laici che avevano scelto la vita coniugale. La loro diffusione in Lombardia fu capillare anche grazie alle autorità ecclesiastiche milanesi che ebbero un atteggiamento favorevole nei loro confronti e già nel 1216 erano circa 150 le comunità regolari e considerevole il numero dei laici rimasti con le proprie famiglie impegnati in attività commerciali ed artigianali, occupandosi principalmente della lavorazione della lana e creando fiorenti manifatture tessili, che permettevano ingenti disponibilità economiche che davano adito ad attività di prestito o di assistenza economica esercitata anche dalla casa di Brera, la più importante di Milano. La crisi, iniziata già alla fine del XIII secolo a causa dell’influenza politica del governo signorile prima e di quello ducale dopo, ma anche ai forti contrasti nati in seno dell’Ordine, toccò il culmine dopo il Concilio tridentino, e quando Carlo Borromeo, nominato protettore dell’Ordine nel 1560 da Pio IV, cercò con polso di riportare gli Umiliati all’osservanza delle norme tridentine, sospettati di posizioni eretiche, soprattutto di calvinismo, nacque una grande opposizione all’interno dello stesso Ordine, che portò al celeberrimo attentato alla vita di Borromeo da parte di Gerolamo Donato detto il Farina. Gli Umiliati vennero soppressi nel 1571 con una bolla di Pio V, il Farina e i due Prevosti complici Girolamo di Cristoforo e Lorenzo da Caravaggio, rei confessi sotto tortura, condannati a morte.. Cfr. M.P.Alberzoni, Gli Umiliati e San Bernardo, in “Storia Illustrata di Milano”, a cura di F. Della Peruta, vol. II, Milano 1992, p521 e segg.; M. Lunari, Appunti per una storiografia sugli Umiliati tra Quattro e Cinquecento, in “Sulle tracce degli Umiliati in Lombardia”, a cura di M.P. Alberoni, A. Lucioni, Milano 1997, p. 45 e segg.
[12] Cfr. D. Maselli, Alla ricerca delle radici… cit., p. 26 e segg.
[13] Le notizie, non certamente esaustive, sulla vita di San Carlo Borromeo, sono state tratte da: C. Bescapè, De vita et rebus gestis Caroli S. Rom. Ecclesiae Cardinalis tit. S. Praxsedis et archiepiscopi Mediolani, Ingolstadt 1592, ed. italiana con testo latino a fronte, a cura di Angelo Majo, traduzione di Giuseppe Fassi, note di Enrico Cattaneo, Nuove Edizioni Duomo, Veneranda Fabbrica del Duomo, Milano 1983; G. P. Giussani, Vita di san Carlo Borromeo, Roma 1610, ristampa Firenze 1858; G. B. Possevino, Discorsi della vita et attioni di Carlo Borromeo, Roma MDLXXXXI; C. Orsenigo, Vita di san Carlo Borromeo, vol. I e II, Milano 1929. Si veda anche D. Maselli, Alla ricerca delle radici… cit.
[14] E. Rotelli, La figura e l’opera di S. Carlo Borromeo nel carteggio degli ambasciatori estensi, in “Studia Borromaica, n. 4, Accademia San Carlo, Milano 1990, pp. 133-145.
[15] D. Maselli, Alle ricerca delle radici… cit., pp. 30-32.
[16] Carlo organizzò I matrimoni delle sue sorelle: Camilla con Cesare Gonzaga, Geronima con Fabrizio Gesualdo principe di Venosa, Anna con Fabrizio Colonna, la sorellastra Ortensia con Annibale Von Hohenems. La sorella Isabella divenne suora con il nome di Corona.
[17]Cfr. Ibid.; Maselli, Alle ricerca delle radici… cit., p. 30-31; http://www.treccani.it/enciclopedia/santo-carlo-borromeo_%28Dizionario-Biografico%29/
[18] Ibid.
[19] Ibid., p. 32.
[20] L. Pastor, Storia dei Papi della fine del Medio Evo, Roma 1950, Vol. VII, pp.91-92. Nel 1524 il Cardinale Gian Pietro Carafa, Vescovo di Chieti, creò, con Gaetano da Thiene, una comunità religiosa di chierici regolari chiamati teatini dal nome latino di Chieti: Theate; si trattava di preti che vivevano in comunità e in povertà, preparandosi rigorosamente alla cura delle anime, essi volevano essere d’esempio al clero ignorante e detentore di benefici ecclesiastici che non dimoravano nelle proprie sedi. Cfr. A. Prosperi-P.Viola, Corso di Storia. Dal secolo XIV al secolo XVII, Einaudi Scuola, Milano 2004, p. 291. L’Ordine religioso dei Teatini era noto anche per le sue tendenze religiose e mistiche.
[21] H. Jedin, Carlo Borromeo, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 1971, p. 14. Jedin vede il Borromeo come il modello del Vescovo post-tridentino, altri studiosi come l’incarnazione dello “Stimulus pastorum” ed in tal modo assunto come modello di vita pastorale.
[22] Niccolò Ormaneto nacque a Verona nel 1515, fin da giovanissimo frequentò il circolo del Vescovo di Verona Gian Matteo Giberti, nel 1538 si addottorò in “utroque iure” presso lo Studio di Padova. Il Vescovo Giberti lo mandò a Roma nel 1541 per presentare al papa Paolo III le “Costitutiones” della diocesi e nella città eterna fece parte del circolo del cardinale Reginald Pole, nello stesso anno fu nominato dal Giberti Arciprete di Bovolone. Nel 1549 partecipò al conclave del Cardinale Ercole Gonzaga e nel 1553 fu tra gli assistenti del Cardinale Pole e designato legato in Inghilterra da Giulio III, dove svolse importanti missioni. Dopo la morte del Cardinale Pole tornò nella sua parrocchia di Bovolone, ma nel 1563 fu assistente del Cardinale Bernardo Navagero al Concilio di Trento, l’anno successivo Borromeo lo nominò suo vicario nell’Arcivescovado di Milano. Nel 1566 papa Pio V lo chiamò a Roma e nel 1570 lo nominò Vescovo di Padova. Dal 1572 al 1577 fu Nunzio in Spagna, morì a Madrid (1577). Cfr. C. Marcora, Niccolò Ormaneto, vicario di San Carlo (giugno 1564-1566), in “Memorie storiche della diocesi di Milano, VIII (1961), pp. 209-590.
[23] Cfr. F. Buzzi, Religione, cultura e scienza a Milano. Secoli XVI-XVIII, Milano 2016, 317 e segg.
[24]Oltre alle biografie precedentemente citate Cfr. D. Maselli, Alle ricerca delle radici… cit., p. 34.; http://www.treccani.it/enciclopedia/santo-carlo-borromeo%28Dizionario-Biografico%29/
[25] D. Maselli, Alle ricerca delle radici… cit., pp.34-35.
[26]“San Carlo nel primo suo concilio provinciale ordinava che maghi, malefici, incantatori, e chiunque fa patto tacito o espresso col diavolo sia punito severamente dal vescovo, ed escluso dalla congregazione dei fedeli. Nel suo rituale stabilisce le penitenze che devono applicarsi a maghi, per 5 anni, a chi getta tempeste, anni 7 in pane e acqua, a chi canta fascinazioni, tre quaresime; a chi fa le legature e malie, due anni. Egli aveva vietato che nessuno in predica dicesse il giorno della fine del mondo” C. Cantù, Gli eretici d’Italia. Discorsi storici di Cesare Cantù, Torino 1866, vol. III, p. 387.
[27] Con la pubblicazione della bolla “In Coena Domini” del 1568 i rapporti tra gli Stati italiani ed europei ed il Papato divennero molto tesi: in essa si vietava ai principi di accogliere persone di religione non cattolica nei loro Stati e di avere con esse rapporti e corrispondenze. I sovrani non potevano imporre gabelle, pedaggi, prestiti, decime sui beni dei chierici senza l’autorizzazione della Curia romana; si vietava di punire per colpe civili i cardinali, i prelati e i giudici ecclesiastici, i loro agenti, procuratori e congiunti; si vietava, inoltre, di ricorrere al Concilio ecumenico contro le sentenze papali ritenute ingiuste. Le rendite delle chiese, monasteri e i benefici ecclesiastici non potevano essere confiscati dalle autorità laiche; tutte le cause concernenti questioni del genere dovevano essere di competenza del foro ecclesiastico e non di quello temporale. Viene proibito al principe l’esercizio dell’”exequatur” sulle concessioni e i decreti pontifici. Il principe che occupasse le terre di proprietà della Chiesa o le muovesse guerra era scomunicato. La reazione degli Stati europei e di quelli italiani fu, naturalmente, molto vivace di fronte a questa forma di teocrazia di carattere medievale.
[28] Cfr. E. Rotelli, La figura e l’opera… cit., p. 135.
[29] Biblioteca Ambrosiana, Ms. F 42 inf., c. 392r. D’ora in poi B. A.
[30] B.A. F 39 inf., c. 42.
[31] B.A., F. 39 inf., cc. 101-102.
[32] B.A., F 42 inf., cc. 226-234.
[33] Cfr. Ibid., pp.38-39. Tra le tele dipinte da Giovan Battista Crespi, detto il Cerano, presenti nel Duomo di Milano, ce n’è una rappresentante la scena dell’attentato a Carlo Borromeo, dove si può vedere il Farina in piedi con in testa un cappello ornato da una grande piuma, che imbraccia l’archibugio, da cui esce un lampo vermiglio diretto verso la schiena dell’Arcivescovo raffigurato inginocchiato in preghiera.
[34] Cfr. E. Rotelli, La figura e l’opera… cit., p. 137.
[35] G. P. Giussani, Vita di San Carlo Borromeo Prete Cardinale del titolo di Santa Prassede, Arcivescovo di Milano, Brescia MDCXIII, Libro IV, p. 185.
[36] B. Ulianich, Carlo Borromeo e i Protestanti, in “San Carlo e il suo tempo”, Atti del Convegno Internazionale…..Milano 1984, vol I, p. 137.
[37] Cfr. D. Maselli, Alla ricerca delle radici… cit., p. 39 e segg.
[38] B. A., Ms. F 166 inf., cc. 496r-508v. Nel descrivere il documento riportiamo le informazioni nella stessa successione in cui sono esposte, e spesso trascrivendo le stesse parole, poiché cambiandole in termini attuali non avrebbero una resa linguistica come le originali.
[39] Ibid., c. 496r. La Repubblica delle Tre Leghe venne siglata, come già detto, nel 1471 a Vazerol tra le tre Leghe Grigioni: Lega Caddea, Lega Grigia e Lega delle Dieci Giurisdizioni. La Lega Caddea o Lega della Ca’ di Dio, deriva io suo nome, come ci spiega il documento, dalla sua sottomissione alla totale giurisdizione della Chiesa, in tedesco Gotteshausbund, in romacio Lia da la Chadé; il Cantone dei Grigioni, il cui capoluogo è Coira, è l’unico in cui le lingue ufficiali sono tre: italiano, romancio e tedesco.
[40] Cfr. Dizionario storico della Svizzera (DSS), Locarno 2002. Nel documento troviamo: “porta per insegna un Camorso forse per che sotto la sua giurisd.ne sono monti altissimi dell’Engadina superiore et inferiore”. B. A., Ms. F 166 inf., c. 496v.
[41] Antica famiglia originaria di Valvenosta nel Trentino, di cui un discendente fu Vescovo di Coira nel 1213, ma dal Dizionario (DSS) risulta che dal 1209 al 1221 fu Vescovo Arnold von Mätsch.
[42] B. A., Ms. F 166 inf., c. 496v.
[43] Ibid.
[44] Ibid.
[45] Ibid., 496v e497r.
[46] Ibid., c. 497r.
[47] Ibid. Forse si tratta di Paul Ziegler von Ziegelberg, il quale fu Vescovo di Coira nella prima metà del Cinquecento.
[48] Ibid., c. 498r.
[49] Ibid.
[50] Ibid., 498v.
[51] Ibid.
[52] Ibid., 499r.
[53] Ibid.
[54] Ibid., cc. 499r-500r.
[55] Ibid., c. 500v.
[56] Ibid., c. 5001r.
[57] Ibid.
[58] Ibid.
[59] Ibid., c. 501v.
[60] Ibid.
[61] Ibid.
[62] Ibid., c. 502r.
[63] Ibid., cc. 502r-502v.
[64] Ibid., c. 502v.
[65] Ibid.
[66] Ibid., c. 503r.
[67] Ibid., c. 503v.
[68] Ibid., c. 504v.
[69] Ibid., c. 504r.
[70] Ibid., c. 504v.
[71] Ibid., c. 505v.
[72] Ibid., c. 507r. E’ probabile che questo documento sia stato scritto dopo I divieti posti dalla Dieta di Coira al Cardinale di proseguire nella sua visita in Valtellina e Chiavenna , come era di suo proposito.
[73] Ibid.
[74] Ibid., c. 507v.
[75] Carlo d’Aragona Tagliavia, principe di Castelvetrano nacque a Palermo il 25 dicembre 1521, primogenito di Giovanni, marchese di Terranova e Antonia Concessa d’Aragona Alliata dei baroni di Avola, da cui ereditò le baronie di Avola e Terranova, elevate poi a marchesati nel 1543; dal padre ricevette il possesso del Marchesato di Terranova, della Contea di Castelvetrano e delle Baronie di Pietra Belice e Burgio Milluso. Fin da bambino seguì il padre al servizio dell’esercito imperiale spagnolo, nel 1539 e nel 1543 fu Governatore della Compagnia della carità di Palermo, dove, nel 1545 circa, iniziò la sua carriera politica come Capitano di giustizia, designato “Magnus Siculus” fu per 40 giorni reggente del trono di Spagna in attesa della maggiore età di Filippo, dopo il 1557, anno dell’abdicazione di Carlo V. Tra i numerosi titoli poteva fregiarsi anche di quello di Capitano generale e Presidente del Regno di Sicilia, Filippo II lo investì dei titoli di Duca di Terranova e di Principe di Castelvetrano. Ammiraglio e gra Conestabile del Regno, nel 1571 prese parte alla battaglia di Lepanto, in seguito ricoprì nuovamente l’incarico di Presidente del Regno di Sicilia dal 1571 al 1577, dove fu molto coscienzioso nel governare i suoi feudi, in particolare quello di Castelvetrano, dove fondò un convento, istituì un Monte di Pietà e la Compagnia dei Bianchei dediti alla cura dei malati e all’assistenza dei condannati a morte, ingrandì e fece decorare la chiesa di San Domenico, costruita dai suoi avi e avviò la riqualificazione urbanistica di Palermo. Dalla monarchia spagnola ebbe importanti incarichi anche fuori dalla Sicilia e il 18 ottobre 1582 fu nominato Governatore di Milano e come tale fu inviato, nel 1588, per stipulare la pace con i Cantoni svizzeri, ricoprì il governatorato fino al 1592, dopo la morte di Filippo II, il suo successore, Filippo III, lo nominò Presedente del Supremo Consiglio d’Italia. Morì a Madrid il 23 settembre 1599 e fu seppellito nella chiesa di San Domenico di Castelvetrano come da sua disposizione testamentaria. Fu citato dal Manzoni nel suo romanzo “I Promessi Sposi” come autore di due gride che riguardavano i bravi: “ Questa specie, ora del tutto perduta, era allora floridissima in Lombardia, e già molto antica. Chi non ne avesse idea, ecco alcuni squarci autentici, che potranno darne una bastante de’ suoi caratteri principali, degli sforzi fatti per spegnerla, e della sua dura e rigogliosa vitalità. Fin dall’otto aprile dell’anno 1583, l’Illustruissimo signor don Carlo d’Aragon, Principe di Castelvetrano, Duca di Terranuova, Marchese d’Avola, Conte di Burgeto, grande Ammiraglio, e gran Contestabile di Sicilia, Governatore di Milano e Capitano Generale di Sua Maestà Cattolica in Italia, pienamente informato della intollerabile miseria in che è vivuta e vive questa città di Milano, per cagione dei bravi e vagabondi, pubblica un bando contro essi”. A. Manzoni, I promessi Sposi, Cap. I. Stabilì che i governatori venissero appellati col titolo di Magnifici o Spectabiles, e il Senato Potentissime rex, a quest’ultimo tolse il potere di avocare a sé le cause di spettanza dei giudici inferiori. Per una più ampia e dettagliata storia di questo personaggio si vedano le due opere di R. Canosa, Storia di Milano nell’età di Filippo II, Roma 1996; La vita quotidiana a Milano in età spagnola, Milano 1996.
[76] B. A., Ms. F 166 inf., c. 536r.-540v.
[77] Ibid.
[78] P. D’Alessandri, Atti di S. Carlo riguardanti la Svizzera e i suoi territori, Tipografia Artistica, Locarno 1909, p.321. Riportiamo parte del documento: “Cupentes pro nostro pastorali officio ut Helvetiorum et Rethorum popolorumque eis subiectorum provinciae, quae superioribus saeculis sincerae fidei christianaeque religionis culto eminere solebant nunc vero aliqua in parte, istigante humani generis hoste, deformatae existunt, quas paterna et singulari quadam protectione prosequimur, Visitationum apostolica rum remedio, adjuvante Domino, restituantur, atque divino culti et animarum saluti quantum cun Deo possumus consolamus, circumspectionem tuam quam alias de eximia integritate, prudentia ac religionis catholicae zelo plurimum in Domino confissi nostrum et apostolicae Sedis generalem et specialem Visitatorem, Reformatorem et Delegatum in Cremonensi, Bergomensi ac Brixiensi et aliis tunc espressi civitatibus et diocesibus “Motu-proprio” deputavimus, facultatesquae ad id opportunas etiam quasqumque ecclesia set sacristias quarumcumque persona rum regularium tam vivo rum, quam mulierum quorum vis ordinum et Congregationum, visitandi et reformandi tibi tribuimus prout in nostris diversis litteris tibi directis plenius continetur: in Costantiensi, Lausanensi, Sedunensi, Curiensi, Basiliensi, Consensi aliiaque Helvetiorum et Rethorum praedicatorum dominio quomodocumque subjectis Civitatibus, diaecesibus et locis universis Visitatorem Reformatorem ac nostrum et apostolicae sedis generalem et specialem Delegatum in omnibus et singulis authoritatibus et facultatibus in predictis literis espressi, aucthoritate apostolica tenore praesentium “Motu-simili”ad nostrum et Sedis Apostolicae beneplacitum constituimus et constitutionibus…”
[79] Cesare Speciano nacque a Cremona nel 1539 da Giovanni Battista, capitano di giustizia, consigliere e senatore nella Milano di Francesco II Sforza. Fu ordinato presbitero per l’Arcidiocesi di Milano nel 1567 e come appartenente ad una nobile famiglia ebbe una rendita fissa con l’Abbazia commendataria di San Pietro all’Olmo, Borromeo lo nominò Canonico ordinario del Duomo di Milano e Prefetto della Casa vescovile. Fu a Roma come Referendario e Segretario della Congregazione dei Vescovi e Regolari nel 1577 e nel 1584 fu nominato Vescovo di Novara. Fu Nunzio apostolico alla corte di Filippo II in Spagna dal 1586 al 1588. Impegnato nella promozione delle riforme del Concilio tridentino, cercò di attuarle anche nella sua diocesi, interessandosi principalmente della disciplina, della moralità e dell’istruzione del clero affinché fosse meglio preparato nella cura delle anime; lottò per sradicarle superstizioni e nel 1590 emanò l’editto “De superstitionis evitandis”, in cui descrisse molte credenze e miti diffusi a quel tempo. Nel 1590 tenne un Sinodo per rafforzare la riforma nel clero e l’anno successivo fece ampliare il palazzo vescovile e il coro della cattedrale di Novara. Dal 1591 fu Vescovo di Cremona e dal 1592 al 1598 fu Nunzio apostolico a Praga alla corte di Rodolfo II. Nel 1600 fondò a Cremona il Collegio dei Gesuiti a cui lasciò in eredità tutti i suoi beni. Nel 1602 fu impegnato in un difficile caso diplomatico di mediazione per conto dell’Imperatore Rodolfo II. Morì a Cremona nel 1607. Cfr. http:77it.cathopedia.org/wiki/Cesare_Speciano
[80] Cfr. B.A., F 69 inf., c. 176r.; P. D’Alessandri, Atti di S. Carlo… cit., p. 324.
[81] B.A., F 69 inf., c. 219r.; P. D’Alessandri, Atti di S. Carlo… cit., p. 325-327.
[82] Ibid.
[83] Ibid.
[84] Ibid.
[85] Cfr. B. A., F. 69 inf., c. 346r.; P. D’Alessandri, Atti di S. Carlo… cit., p. 359; R. Boldini, Documenti intorno alla visita di San Carlo Borromeo in Mesolcina, Poschiavo 1962, p. 5.
[86] B. A., Ms. 164, c. 441r.
[87] Ibid
[88] Cfr. G. A. aMarca, Compendio storico della Valle Mesolcina, Lugano 1838, p.131 e segg.
[89] Monsignor Francesco Borsatto, mantovano, Protonotaro Apostolico,”Dottore nell’una e l’altra legge degno di essere annoverato trà più famosi che da molti centinara d’anni infin’ora siano stati […] havevaquesto Prelato in particolare prattica grandissima di queste materie di heretici e di streghe per haverci posto studio grande, et essere stato molti anni Advocato della Santa Inquisizione in Mantova>>. Cfr. G. B. Possevino, Discorsi…cit., p. 177; A. Agnoletto, Religione popolare, Folklore e magia nei documenti borromaici, in “San Carlo e il suo tempo”, Atti del Convegno Internazionale nel IV centenario della morte, (Milano, 21-26 maggio 1984), Roma 1986, p. 885.
[90] Cfr. F. D. Vieli, Storia della Mesolcina scritta sulla scorta dei documenti, Ed. Grassi & Co., Bellinzona 1930, p. 150.
[91] Cfr. G. P. Giussano, Vita di San Carlo… cit., p. 382.
[92] Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/valle-mesolcina_%28Enciclopedia-Italiana%29/; Molte notizie che seguono sono state riprese anche da G. A. aMarca, Compendio Storico della Valle Mesolcina, Lugano 1838, pp.131-132.
[93] Cfr.F.D. Vieli, Storia… cit., pp. 22-26.
[94]La Centena è una divisione amministrativa usata storicamente nei paesi nordici e germanici per dividere una regione più grande in unità geografiche più piccole. Il nome è derivato dal numero cento. Era un sistema usato tradizionalmente dai popoli germanici, descritto fin dal 98 da Tacito
[95] Cfr. F. D. Vieli, Storia… cit, p. 105 e segg.
[96] Cfr. C. Donati a cura di, Alle frontiere della Lombardia: politica, Guerra e religione nell’età moderna, Milano 2006, p. 44 e segg.; http://mobile.hls-dhs-dss.ch/m.php?article=18033.php
[97] F. D. Vieli, Storia… cit, pp. 135-137.
[98] Ibid.
[99] Ibid., p. 140.
[100] Giovanni Beccaria, nato a Locarno nel 1510 circa, dopo gli studi di teologia abbracciò la fede riformata ed esercitò con successo l’insegnamento. Cacciato dalla sua città, si rifugiò a Mesocco, dove aprì una scuola frequentata dai figli delle famiglie riformate di Locarno. In seguito venne nominato parroco riformato di Mesocco. Nelle sue lettere a Heinrich Bullinger, teologo, riformatore e Antistes (Vescovo) della Chiesa riformata di Zurigo, Beccaria scriveva che a Mesocco nessuno andava più alla messa , che molti erano pronti ad abbandonare la religione cattolica per essere liberi da vincoli finanziari ecclesiastici e da doveri spirituali, ma rifiutavano di provvedere al mantenimento della nuova chiesa, non erano interessati alle funzioni religiose ed erano immorali. Nel 1556 Beccaria partì al seguito di una comunità protestante per Zurigo, nel 1559 riprese il suo posto di parroco riformato a Mesocco, ma non essendo tollerato dai Cantoni cattolici, il comune della città lo allontanò ed egli si rifugiò a Chiavenna, per fare tornare l’anno successivo a Mesocco, dopo il ricorso fatto dai riformati grigioni contro l’espulsione del Beccaria, in quanto non colpevole di delitti comuni, ma la situazione era cambiata e molte persone autorevoli avevano voltato le spalle alla Riforma: osteggiato, deluso e stanco Beccaria si riparò a Bondo, dove morì nel 1580. Cfr. F. D. Vieli, Storia… cit, p.140 e segg.
[101] Ibid. p. 144.
[102] Ibid.
[103] G. A. aMarca, Compendio Storico… cit., pp.131-132.
[104] B. A., Ms. P 23 inf., c. 228r.; R. Boldini, Documenti… cit., pp. 7-8.
[105] Giacomo Savelli, discendente dall’antica e nobile famiglia romana che contava tra i suoi discendenti tre papi e alcuni cardinali, nacque a Roma il 28 ottobre 1523, da Giambattista e Costanza Bentivoglio, la nonna paterna, Camilla Farnese, era cugina di Paolo III, il quale lo inviò a Padova, dove si laureò in “utroque iure”, intraprese la carriera ecclesiastica quando aveva solo sedici anni e l’anno successivo fu creato cardinale diacono. Ebbe numerosi e importanti incarichi e fu molto legato alla Marca, dove dal 1551 al 1555 si adoperò per difendere le coste dai Turchi. Nel 1557 fu chiamato da Paolo IV a far parte della Congregazione dell’Inquisizione e nel 1560 fu nominato Vicario di Roma sempre dallo stesso papa, il quale aveva stabilito, nella riforma dei tribunali romani, che la carica fosse affidata ad un cardinale. Savelli prese, fin dall’inizio, una serie di provvedimenti conformi ai principi del Concilio di Trento per moralizzare il clero, disciplinare il culto delle reliquie e soprattutto per ciò che concerneva le funzioni pastorali dei parroci, si adoperò per il controllo e il governo dell’ordine e della morale nella città di Roma. Nel 1560 gli fu assegnata la Diocesi di Benevento, che visitò solo nel 1567 a causa dei numerosi impegni con il Pontefice. Nel 1562 Pio V lo chiamò di nuovo a far parte della Congregazione dell’Inquisizione, dove si occupò principalmente di tenere la corrispondenza con i vicari e inquisitori: un esempio sono le numerosissime missive tra il Savelli e Carlo Borromeo. Dal 1577 al 1583 fu creato Cardinale Vescovo di Sabina, di Tuscolo e di Porto. Alla morte di Scipione Rebiba, nel 1577, divenne Inquisitore Maggiore, occupandosi attivamente nel controllo e repressione delle eresie, superstizioni e stregoneria. Durante il conclave del 1585 fu proposto tra i papabili, ma su di lui gravava una fama negativa diffusa dai suoi opoositori che gli attribuivano diversi figli naturali, in realtà incise la sua politica a favore di Alessandro Farnese e della Spagna, che condizionò negativamente, in seguito, l’atteggiamento di Sisto V nei suoi confronti. Savelli morì a Roma il 5 dicembre 1587 e il Papa, non dimenticando il suo rancore, non tenne conto del suo testamento.
Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/giacomo-savelli_(Dizionario-Biografico)/
[106] B. A., F 69 inf., c. 256 r. e v.; P. D’Alessandri, Atti di S. Carlo…cit., p. 328.
[107] Per la lettera al Savelli Cfr. B. A., Ms. P 23 inf., c. 228r.; A. Borromeo, L’opposizione all’eresia. Apostolo e “genio” pratico della riforma, in “Il grande Borromeo tra storia e fede”, Milano 1984, pp. 223-255. Il “negotio” che il Borromeo stava terminando riguardava il matrimonio della principessa Margherita Farnese, proposto dal Cardinale Alessandro Farnese per un’alleanza antifiorentina dei Farnese con i Gonzaga, la cui rivalità risaliva ai tempi di papa Paolo III (Farnese). Margherita, figlia del principe Alessandro Farnese e Vincenzo Gonzaga, unico figlio di Guglielmo duca di Mantova e futuro duca di Mantova, si erano uniti in matrimonio con una solenne cerimonia officiata nella Cattedrale di Piacenza il 2 marzo 1581, ma dopo poco tempo la principessa, che portava una dote di trecentomila scudi, si rivelò inabile al matrimonio a causa di un impedimento congenito di Margherita, che avrebbe potuto risolvere con un delicato intervento chirurgico, caldamente sconsigliato dalla nonna, Margherita d’Austria, e anche dallo stesso Borromeo. La causa fu demandata da Gregorio XIII al Borromeo, come Delegato Pontificio, il quale, accertata dai medici l’inabilità fisica della donna, dichiarò nulla la loro unione e autorizzò il duca Vincenzo a poter contrarre nuove nozze. La principessa Margherita, il primo ottobre dello stesso anno, entrò nel monastero di San Paolo di Parma, dove fece professione religiosa, prendendo il nome di Maura Lucenia. Cfr. C, Poggiali, Memorie storiche della città di Piacenza. Compilate dal Proposto Cristoforo Poggiali Bibliotecario di S.A.R., Tomo X, Piacenza MDCCLVI, pp. 194-197; E. Costa, Spigolature storiche e letterarie, Parma 1887, p.17 e segg.; http://www.it/enciclopedia/margherita-farnese_(Dizionario-Biografico/)
[108] B. A., F 166 inf. cc. 254r.- 259r-260r.
[109] Ibid.
[110] G. B. Possevino, Discorsi… cit., pp. 177-178.
[111] Ibid. p. 180.
[112] B. A., F 166 inf. C. 492r. e segg.; P. D’Alessandri, Atti di S.Carlo…, cit., p. 335-336.
[113] A. Agnoletto, Religione popolare, Folklore e Magia nei documenti borromaici, in “San Carlo e il suo tempo”, Roma 1986, p. 870 e segg.
[114] Cfr. A. Agnoletto, Religione popolare… cit., p. 871.
[115] Ibid.
[116] Ibid.
[117] Cfr. F. Molinari, San Carlo Borromeo tra mito e storia, in “Quaderni camuni”, 8, 1979, p. 336.
[118] Cfr, A. Agnoletto, Religione popolare… cit., p. 876.
[119] R. Boldini, Documenti… cit., pp. 9-10.
[120] Ibid.
[121] Ibid.
[122] Il 23 maggio 1555, all’età di settantanove anni, il Cardinale Pietro Carafa fu eletto Papa con il nome di Paolo IV, nei suoi quattro anni di pontificato, egli ebbe come obiettivo principale la lotta alle eresie e una seria riforma della Chiesa e tra le molteplici occupazioni sia di carattere spirituale che politico, quella cui si dedicò maggiormente fu il Sant’Uffizio, attuando cambiamenti e, spesso, prendendo personalmente le decisioni più importanti; ampliò le facoltà d’intervento dell’Inquisizione assegnandogli la competenza sulla bestemmia e sulla simonia, intensificò le pene e comminò la pena capitale nel corso del primo processo per chi confutasse la Trinità, la divinità di Cristo e la verginità della Madonna, più tardi anche per chi celebrasse messa, ascoltasse confessioni, approfittasse dell’eucaristia senza avere ricevuto l’ordine sacro. Nel complesso, durante il papato di Paolo IV il Santo Uffizio ampliò notevolmente la sua sfera d’azione e le sue competenze a reati come la bestemmia, l’omosessualità e la simonia, quest’ultima era uno dei cardini su cui si basava la sua lotta per la riforma della Chiesa. Cfr. A. Del Col, L’Inquisizione in Italia. Dal XII al XXI secolo, Mondadori 2006, p. 398; L. Fabbri, Per fede e per dignità: il caso di Abramo e Agnoluccio ebrei, in “I Tesori alla Fine dell’arcobaleno”, https://itesoriallafinedellarcobaleno.com/2017/07/05/per-fede-e-per-dignita-il-caso-di-abramo-e-agnoluccio-ebrei/?
[123] B. A., Ms. F 69 inf. cc. 256r.-257v.
[124] Achille Gagliardi nacque a Padova nel 1537circa da Girolama Campolongo e da Ludovico, alla prematura scomparsa del padre fu affidato insieme con i fratelli ad un precettore e dopo la morte della madre si trasferì a Roma per entrare nella Compagnia di Gesù. Nel 1562 ebbe l’incarico di insegnare nel Collegio Romano prima etica, poi logica, fisica e metafisica, nel 1568 fu nominato rettore del Collegio di Torino. Svolgendo nel contempo molte altre attività, che suscitarono gelosie nelle autorità religiose torinesi che lo accusarono di troppa ambizione e inefficienza nella direzione del Collegio, ma egli riuscì ad ottenere di nuovo la fiducia. Nel 1572 ebbe la cattedra di teologia scolastica nel Collegio di Brera a Milano, ma non assunse tale incarico a causa dell’insistenza del Duca di Savoia, presso il quale ebbe attività diplomatiche e di mediatore con la Santa Sede, tali stretti rapporti finirono quando Gagliardi fu chiamato a Roma, nel 1575, per occupare la cattedra di teologia scolastica, dove trovò un clima molto burrascoso con polemiche dottrinarie ed altre riguardanti la Compagnia di Gesù; le sue prese di posizione furono la causa per cui dovette lasciare Roma nel 1579. Il Borromeo, il quale lo stimava molto, lo chiamò a Milano in occasione della sua visita in Mesolcina, che lo impegnò molto anche come predicatore. Tornato a Milano divenne direttore spirituale di Isabella Cristina Berinzaga, la cui assidua frequenza con la “mistica” destò molte perplessità, inoltre nella sua opera “Breve compendio di perfezione cristiana”, vennero riscontrati gravi errori dottrinari, fu fatta esaminare a Roma e anche i teologi Gesuiti si pronunciarono contro la sua divulgazione. Non era di questa opinione il futuro Santo, il quale manda una copia al Cardinal Savello per avere la licenza di stamparla e scrive queste parole: “…ha composto un catechismo volgare che è come una instruttione piena, breve et chiara della fede per uso et servizio principalmente dei paesi dei Grisoni […] il qual libro mi è piaciuto grandemente et sarebbe utile in ogni luogo…” P. D’Alessandri, Atti di S. Carlo… cit., p. 328. Tornato a Milano nel 1593, fu riconfermato Preposito di San Fedele, ma le riprese frequentazioni con la Berinzaga, che considerava direttamente ispirata dalla parola divina, lo spinsero a rimettere l’incarico. Dopo molte vicissitudini e una vita piuttosto movimentata (che non spiegheremo in questa sede), fu nominato rettore del Collegio di Bologna nel 1604, in condizioni di salute pessime, morì a Modena il 6 luglio 1607. Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/achille-gagliardi_%28Dizionario-Biografico%29/
[125]Girolamo (Francesco) Panigarola nacque a Milano nel 1548 da nobile famiglia, studiò a Pavia, a Bologna e a Pisa, nel 1567 entrò nei frati Minori Conventuali,prendendo il nome di Francesco nel 1571 Pio V lo mandò a Parigi per frequentare le lezioni di teologia della Sorbona. Insegnò a Bologna, Firenze e a Roma, non trascurando il suo compito di predicatore e come tale, tra il 1574 e il 1587 fu in numerose città italiane: tale fu la fama come predicatore, che divenne un punto di riferimento per la predicazione del suo tempo: principi, ecclesiastici e nobili fecero a gara per ottenere la sua presenza, il Borromeo lo volle spesso come predicatore ufficiale nel Duomo di Milano, anche il Papa assisteva alle sue prediche. A Torino tenne le sue conferenze contro Calvino, confutando le tesi contenute nell’”Institutio religionis Christianae”: <<…contro i libertini e gli ateisi trattò di affermare da parte di tutti i credenti, che esiste un solo Dio; contro ebrei e musulmani, si trattò di sostenere, da parte di tutti i cristiani, che Cristo è Dio, ovvero che la rivelazione cristiana è vera; infine, contro i protestanti, si trattò di dimostrare che la vera Chiesa è quella cattolica, in quanto corrispondente alla volontà di Cristo. Rifiutando la definizione che Calvino fornisce di Chiesa, basata sulla predestinazione degli eletti, come pure quella degli anabattisti che fanno coincidere la Chiesa con la comunità dei giusti, Panigarola mette in campo la distinzione intercorrente tra “chiesa militante” e “chiesa trionfante”, distinguendo due modi diversi di essere uniti a Cristo nell’unica Chiesa>>. F. Buzzi, Religione, cultura e scienza a Milano. Secoli XVI-XVIII, Milano 2016, p. 185 e segg. Dal 1582 al 1584, salvo alcune eccezioni, fu a Milano per servire l’Arcivescovo e alla morte di Carlo Borromeo fu incaricato di fare l’aorazione funebre. Nel 1586 fu suffraganeo del Vescovo di Ferrara e nel 1587 fu eletto Vescovo di Asti e nella stessa città morì il 31 maggio 1594.
[126] Bernardino Morra nacque a Casale Monferrato nel 1549 da una famiglia patrizia di Chv asso, dopo gli studi giuridici entrò al servizio dei Gonzaga, che lasciò per seguire la carriera ecclesiastica. Nel 1575 si trovava già presso il Borromeo, il quale l’anno seguente lo nominò Auditore generale della Diocesi di Milano, con funzioni parificate a quelle di vicario. Nello stesso tempo in cui Carlo si trovava in Mesolcina, Morra andò a Coira come suo inviato per svolgere un’importante missione diplomatica con i Grigioni; alla morte del Prelato, Morra continuò a seguirne le orme e nel 1586 fu nominato Vicario generale della Diocesi di Milano, in seguito fu Protonotaro apostolico. Nel 1595 ebbe la nomina di Segretario della Congregazione dei Vescovi e poi, chiamato da Clemente VIII, che lo volle come coadiutore nella riforma disciplinare della Chiesa, Prefetto del Palazzo apostolico. Nel 1598 ottenne la nomina di Vescovo di Aversa, svolgendo il suo governo vescovile sul modello borromaico.Morì ad Aversa il 17 marzo 1605. Cfr. http://WWW.treccani.it/enciclopedia/bernardino-morra_(Dizionario-Biografico)/
[127] B. A., Ms. F 166 inf., c. 11r.
[128] P. d’Alessandri, Atti di S. Carlo…, cit., pp. 333-334.
[129] Ibid.
[130] Ibid.
[131] Ibid., pp. 335-336.
[132] Ibid.. p.336.
[133] Ibid.
[134] Ibid., pp. 336-337. Pietro Paolo Vergerio nacque a Capodistria nel 1498. Giurista, professore universitario e riformatore religioso, dopo la morte prematura della moglie Diana Contarini, si mise al servizio della Chiesa: fu Nunzio in Germania nel 1533 presso la corte di Ferdinando d’Asburgo, esperienza che lo rese grande conoscitore del mondo tedesco e protestante, tre anni dopo fu consacrato prete e vescovo da Papa Paolo III che gli assegnò prima la diocesi di Modrus in Croazia poi quella di Capodistria. Nel 1540 fu rappresentante ufficiale di Francesco I re di Francia alla dieta di Worms, dove, su ordini della Curia pontificia, si oppose ai propositi conciliativi di Carlo V. Riprese i contatti con i principali riformatori tedeschi e si allontanò dall’ortodossia cattolica tanto da essere denunciato come luterano nel 1544, l’anno successivo fu processato e assolto a Venezia. Nel 1549 fu esule in Svizzera, dopo avere rifiutato l’opportunità di discolparsi presso la Curia romana, dopo un lungo giro di divulgazione del luteranesimo in questa nazione, svolseun’intensa attività propagandistica politico-religiosa in Germania, nei Grigioni e in Valtellina, mostrandosi accanito avversario del papato. Dal 1561 al 1562 fu molte volte nella città di Coira, dove fece propaganda anticonciliare e divulgò numerosi libretti d’ispirazione luterana. La sua copiosa produzione letteraria fu essenzialmente propagandistica. Morì a Tubinga il 4 ottobre 1565. Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/vergerio-pietro-paolo-il-giovane_%28Enciclopedia…
[135] B. A., F 69, c. 349 r.; P. d’Alessandri, Atti di S. Carlo… cit., p. 358; F. D. Vieli, Storia… cit., pp. 153-154.
[136] B. A., f 166, c. 343 r.; P. d’Alessandri, Atti di S. Carlo… cit., p. 359; R. Boldini, Documenti… cit., pp. 28-29.
[137] Cfr. http:// blogs.dotnethell.it/silvanopollena//Il-cardinale-Borromeo-e-le-streghe-della-Mesolcina-e-Calanca_7331.aspx
[138] Cfr. F. D. Vieli, Storia cit…, pp. 162-164.
[139] Ibid., p. 151.
[140] P. d’Alessandri, Atti di S. Carlo… cit., p. 354.
[141] Ibid., in nota.
[142] B. A., Ms. F 166, c. 164r. Ludovico Audoeno (Lewis Owen) nacque in un piccolo villaggio del Galles nel 1532, Studiò prima nel collegio di Wincester e dal 1554 ad Oxoford, che lasciò nel 1561 per proseguire gli studi di dottorato in diritto e teologia. Fu canonico della Cattedrale di Camrai e arcidiacono a Hainault, successivamente andò a Roma, dove sotto il pontificato di Sisto V e di Gregorio XIII ricoprì le cariche di Referendario di segnatura e Segretario della Congregazione per i Vescovi e i Regolari. Fu uno dei promotori della fondazione dei Collegi inglesi di Douai e Roma e nel 1578 fu nominato Rettore del Morys Clynnong di Roma, ma aspre rivalità tra studenti gallesi e inglesi indussero questi ultimi a chiedere un rettorato guidato dai Gesuiti, poiché sostenevano che i Gallesi erano favoriti rispetto agli Inglesi. Il Papa, forse per allontanarlo da Roma, mandò Ludovico Audoeno a Milano presso il Cardinale Borromeo, dove ricoprì la carica di Vicario dal 1580 al 1584, anno della morte del Borromeo, ma due mesi dopo era di nuovo presso la Corte pontificia e nel 1588 Sisto V lo nominò Vescovo della diocesi di Cassano all’Ionio e nel 1591 fu nominato Nunzio apostolico a Lucerna per la Svizzera, pur continuando a risiedere a Roma, dove morì il 14 ottobre 1591 e fu sepolto nella cappella del Collegio inglese. Cfr. https://it.cathopedia.org/wiki/Lewis-Owen
[143] Ibid.
[144] Cfr. B.A., f 166 inf., c. 107 r. e v.; R. Boldini, Storia… cit., p. 11.
[145] “… ho procurato di parlare col Ministrale Maggio al quale ho dato convenio di sodisfattione, sì che da lui non reusciva alcun male effetto, del successo a Milano, ma già che ne aveva raguardo con alcuni di questa città sì che gli animi erano alterati molto grandemente, in tanto che poco prima che fossero gionte le lettere di V. S. Ill.ma uno ragionando col Todeschino disse che per ricompensa di quel che s’era voluto fare a Milano a uno di loro, bisognava che hora retenesser V. S. Ill.ma veramente che magnifica occasione del negotio che si tratta…”. B. A., F 166 inf., c. 197 r.; R. Boldini, Storia… cit., p. 19.
[146] Cfr. B.A., F 166 inf., c. 107 r. e 122 r.; R. Boldini, Documenti…cit., pp. 11-12.
[147] Peter de Raschèr nacque a Zouz nel 1549, fu educato nella certosa di Buxheim in Svevia e compì gli studi a Ingolstadt. Dopo essere stato eletto Canonico del Capitolo della cattedrale di Coira, fu parroco di Bergün e cantore del Capitolo cattedrale nel 1578, fu eletto Vescovo di Coira nel 1581. Di indole remissiva, delegò ai suoi vicari i primi tentativi di riforma; dopo la visita di Borromeo in Mesolcina, dette disposizioni al clero sull’amministrazione dei sacramenti e la condotta dei religiosi, fece pubblicare nuove copie del messale e del breviario, nel 1598 promulgò nuovi statuti per il Capitolo cattedrale. Morì a Coira nel 1601.Cfr. http://mobile.hls-dhs-dss.ch/m.php?lg=126318php
[148] B. A., F 166 inf., c. 134 r; R. Boldini, Documenti… cit., p. 13.
[149] Ibid., c. 149 r.; p. 14.
[150] Ibid.
[151] Ibid.
[152] Cfr. F. D. Vieli, Storia… cit., p. 154.
[153] B. A., Ms. F 166 inf. c. 179 r.e v.
[154] B. A., Ms. F 166 inf., c. 197 r.
[155] Si tratta di Galles de Mont, capo della Lega Grigia.
[156] B. A., Ms. F 166 inf. c. 179r.
[157] Ibid.
[158] Cfr. B. A., Ms. F 166 inf. c. 197 r.
[159] Cfr. R. Boldini, Documenti… cit., pp. 15-16.
[160] B. A., Ms. F 166 inf., c. 184r.; R. Boldini, Documenti…cit., pp. 18-19.
[161] “Cives nostri Curienses omnes C. V. Ill.mam maximo honore excipient accedentem, et non minori prosequentur discendentem, visitationes etiam Ecclesiae meae minime impedient, sermone vero ad populum nullum fieri volent, et si vellent, certe ipse qui statum patriae mentesque nostratum, utcumque iam perspectas habeo, dissuaderem; rem namque hanc, plerique rusticorum in hac praesertim temporum pernicie, novamet seditioni proximam (licet immerito) suspicarentur tamen, sed de hac re alias”. R. Boldini, Documenti… cit., p. 21.
[162] Papa Gregorio XIII emana il nuovo calendario il 24 febbraio 1582: quello vecchio, che era stato emanato da Giulio Cesare, aveva i giorni di circa undici minuti più lunghi del giorno astronomico, quindi nel secolo XVI risultava che l’anno civile aveva accumulto dieci giorni di ritardo rispetto a quello astronomico. Questa riforma del calendario ebbe luogo proprio nel culmine delle lotte religiose e i Protestanti non vollero riconoscerlo, in quanto promulgato dal Papa. In Svizzera, i Cantoni cattolici decisero di adottare il nuovo calendario dal 10 novembre 1583 mentre quelli Riformati lo adottarono solo dal 1701; nelle terre dei Grigioni il calendario gregoriano non fu accolto in una precisa data, ma fu applicato nel secolo seguente e divenne normativa comune solo nel 1811, a causa delle violente lotte religiose, Cfr. R. Boldini, Documenti… cit., p. 22.
[163] B. A., Ms. F 175 inf. c. 166 r.; R. Boldini, Documenti… cit., pp. 24-25.
[164] Ibid., c. 156r.
[165] B. A., Ms. 166 inf. c. 555r.-558v. “Per Franza”.
[166] Cfr. Ibid., c. 557v. Gli abitanti delle due Valli erano circa centomila, dei quali “due o tremila” eretici, il documento continua dicendo le vessazioni che vengono fatte ai Cattolici, i quali sostengono di non poter più sopportare una simile situazione. Per la storia della Valtellina e Valchiavenna si veda: G. Romegialli, Storia della Valtellina e delle già Contee di Bormio e Chiavenna, Vol. II, Sondrio 1834.
[167] B. A., Ms. P 24 inf., cc. 592v.-594v.; e c. 666r.
[168] Cfr. B. A., Ms. F 170 inf., c. 342r.
[169] B. A., Ms. F 168 inf., cc. 411r e v.
[170] B. A., Ms. F 169 inf.cc. 217 r. e v.
[171] Ibid., c. 281r.
[172] Cfr. A. Lanfranchi a cura di, Il Libro delle memorie del Canonico Fanti di Sondalo, Parte III, in “Bollettino Storico Alta Valtellina, n. 15, Anno 2012, p. 35.
[173] B. A., Ms. F 169 inf., c. 297r.
[174] Ibid., cc. 365r e v.
[175] B. A., F 166 inf., c. 112r. “…di che si promettevano grata risposta et che altrimenti facendo de non voler consentir a questi loro amichevoli avisi et essortationi et nunc gli protestavanode non darci alcuno aiuto occorrendo gli intervenga qualche fortuna, et che vogliono essere escusati d’haver fatto il debito loro, sopra quale esposizione detti SS.ri Grisoni non gli hanno dato alcuna grata ne buona risposta, ma sono restati sdegnati della protesta fatta da detti SS.ri Amb.ri Svizzeri quali si partirono malissimo sodisfati”.
[176] B. A., Ms. P 23 inf. (II), c. 228r.
[177] B. A., Ms. F 166 inf., c. 112r.
[178] Ibid., c. 512v.
[179] B. A., Mss.P 24 inf., c. 513 e 524, le minute sono datate “fine di luglio 1584” per lo Speciano e 2 agosto dello stesso anno per il Cardinale Savello; F. 166 inf., c. 511r. : “Così poiche per molti degni rispetti questa loro richiesta ci pare molto strana; et particolarmente che altre nostre vicine nationi, non comportarebbano che noi erigessimo uno Seminario o Collegio Evangelico nelli nostri paesi sudetti; pone per cio noi non havemo mai detto contra a quelli, che errette scole di Giesuiti, et altri conventi ne manco ci è mai venuto in pensiere di cercar di volerle obiurare. La onde si persuadiamo totalmente che nessuno ne habbia a contradire ne di volerlo levere con minacie queste ne altre honorate inovationi. Ma particolarmente restiamo sumamente admirativi, et ci pesa, che detti SS.ri Amb.ri in nome de loro SS.ri et supp.ri nella conclusione della loro instruttione per desviarne con minacie, di uno tanto Christiano proposito, ci hanno fatto intendere, che in caso dela loro richiesta, et essortatione, non potesse haver loco presso di noi, che si protestano, occorendo caso che percio ne resultasse qualche fastidij contrarietà, et inquieti, che essi non ci vorranno dar agiuto ne assistenza…”
[180] Scipione Calandrini, figlio illegittimo di Giuliano di Filippo, nacque probabilmente a Lucca nel 1540 circa. Fu affidato alle cure di un precettore, il quale fu poi arrestato a Lucca nel 1556, trasferito a Roma e condannato al rogo, fu spiccato un mandato di cattura anche per Scipione, che, avvertito, riuscì a fuggire, rifugiandosi nei Grigioni e poi a Ginevra, dove ottenne la cittadinanza nel 1559 e prestava servizio come ministro della Chiesa italiana. Fu uno dei primi lucchesi a convertirsi alle dottrine riformistiche, indipendentemente dai contatti con i riformati d’oltrape. Poche le notizie negli anni tra il 1562 e il 1572, nel 1566 si trovava di Nuovo a Ginevra, dove insegnava gratuitamente dialettica e retorica al “Collège”, ma due anni dopo, non avendo ottenuto la cattedra di filosofia, andò ad Heidelberg, dove oltre che studente, fu insegnante di filisofia, teologia e lettere. Fu in Valtellina nel 1570 circa, come pastore di Morbegno e nel 1575 partecipò alla Dieta di Coira, nel 1577 fu a Sondrio, dove continuò la sua attività pastorale, ma anche una massiccia opera di propaganda ed educazione: organizzò un ginnasio, in cui aveva grandissima parte l’educazione umanistica, suscitando la reazione dei cattolici.Scrisse molte opere, di notevole rilievo è il metodo di dibattito da lui proposto, ossia di interventi alternati e non disturbati da interruzioni. Fu al centro, insieme con Nicolò Rusca, delle drammatiche vicende che sfociarono nel tristemente famoso “Sacro Macello della Valtellina” del 1620. Nel 1594 riuscì a sfuggire ad un agguato il cui mandante fu Michele Chiappino, che venne poi arrestato e durante l’interrogatorio confessò di avere agito, a sua volta, per conto del Rusca, che si difese strenuamente dicendo aanche di essere stato in buoni rapporti con Scipione: entrambi furono giustiziati. Calandrini morì, probabilmente, verso gli inizi del XVII secolo. Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/scipione-calandrini_(Dizionario-Biografico)/
[181] B. A., Ms. F 168 inf. cc. 93 r.-94v.
[182] Cfr. L. Prosdocimi, Riforma borromaica e conservatorismo politico. Dalle controversie di giurisdizione alla convergenza, in “San Carlo e il suo tempo, Atti del Convegno Internazionale nel IV centenario della morte (Milano, 21-26 maggio 1984), Roma 1986, p. 705.
[183] B. A., Ms. F 166 inf. cc. 536r-540v.
[184] B. A., Ms. F 166 inf., c. 541r.
[185] Ibid.
[186] Ibid., c. 164r.
[187] Cfr. B. A., Ms. F 166 inf., cc. 324r., 325r., 392r., 467r.
[188] Una lettera è scritta dal Cardinale Savello, il quale comunica a Borromeo di avere data al Pontefice la relazione da lui scritta e il decreto emesso dai rappresentanti delle Leghe durante Dieta, la data risale al 10 dicembre 1583. Cfr. B. A., Ms. F 166 inf., c. 292r.
[189] Cfr. R. Boldini, Documenti… cit., p. 27; B. A., Ms. F 69 inf., c. 331r.
[190] Ibid.
[191] Ibid.
[192] R. Boldini, Documenti… cit., p. 32; B. A., Ms. F. 167 inf. ,c. 58r.
[193] B. A., Ms. F 167 inf., c. 126r. La lettera continua con le spiegazioni delle sue occupazioni giornaliere.
[194] Cfr. Vieli, Storia… cit., p. 152; R. Boldini, Documenti… cit., p. 28.
[195] B. A., Ms. F 167 inf., c. 72r; R. Boldini, Documenti… cit., p.35.
[196] B. A., Ms. F 167 inf., c. 85r; R. Boldini, Documenti… cit., p. 35.
[197] Cfr. B. A., Ms. F 167 inf. c. 65r. e 122r., R.Boldini, Documenti… cit., pp. 36-37.
[198] Cfr. B. A., Ms. F 167 inf., c. 182 r.; R. Boldini, Documenti… cit., p. 39.
[199] B. A., Ms. F 166 inf., c. 560r.
[200] Ibid., c. 560v.
[201] La condanna di Gerolamo Borgo viene riportata nella lettera del 30 gennaio 1584, edita da Boldini e in un’altra lettera del 12 febbraio dello stesso anno scritta da Battista Borgo, nipote di Gerolamo, il quale scrive che lo zio è stato accusato di avere avvertito il Cardinale che <<…non li dovesse alhora andare atento che gli erano grandissimi romorri nelle lige, ma che lasase prima fare li pagamenti di Franza;li quali si facevano alhora, sopra la quale querella fu datto al detto mes. Jeronimo mio cio (zio) acrissimi tormenti, atalle cheli fu bisogno confessare il tutto>>. B. A., Ms. 167 inf. c. 270r.; R. Boldini, Documenti…cit., pp.41-42.
[202] B. A., Ms. F 167 inf., c.561r. Pubblicata una parte da P. d’Alessandri, Atti di S. Carlo… cit., pp. 362-363.
[203] B. A., Ms. F 167 inf., cc. 561r e 561v.
[204] Ibid., ms. 167, c. 261r.
[205] B. A., Ms. F 168 inf., c. 37r.
[206] B. A. Ms. F. 168 inf., c. 105r.; R. Boldini, Documenti… cit., pp. 43-44.
[207] B. A., Ms. F 168 inf. c. 126r.; R. Boldini, Documenti… cit., pp. 44-45.
[208] Cfr. R. Boldini, Documenti… cit., pp. 45-46. In una delle lettere si apprende che Giovan Battista Sacco è stato riconfermato Ministrale.
[209] Ibid. , p. 46.
[210] B. A., Ms. F 168 inf., c. 374r.; R. Boldini, Documenti… cit., pp. 47-48.
[211] Ibid.
[212] B. A., Ms. F 168 inf., c. 380r. e v.; R. Boldini, Documenti intorno… cit., p. 49.
[213] Numerose sono le lettere che parlano dell’applicazione del nuovo calendario, che, come già detto, nel Cantone dei Grigioni non fu adottato unanimamente, infatti Nicolò Venusto, Prevosto di Coira, in una lettera a Pietro Righini, parroco di San Domenico di Calanca scrive che “Essendo informato dal Sig,r Ministrale di Calanca che parte servano il calendario Nuovo, et altri il vecchio, et da questa osservazione ne vengano dispareri grandi […] per tanto essendo noi tutti informati quale sia la mente delli s.ri delle tre lighe di sopra di questo et a parte confermata dalla liga Grisa, per oviare a dissordini che potriano cascare, per la presente vi facciamo intendere che voi serviate detto calendario vecchio, come noi, et questo per modo di provisione, sin’a nuovo ordine di Monsig.r R.mo nostro vescovo di Coira, il medemo farete intender alli altri et di questa risolutione se ne informerà se sara bisogno Mons.r Ill.ma cardinal Borromeo”. In un’altra lettera del29 giugno, Giovan Battista Sacco, Ministrale di Roveredo, scrive al Borromeo che “La Valle Calanca và ostinata sola nell’osservatione di detto Calendario, per timore di detta Ligha nostra…” B. A., Ms. F 169 inf. cc. 220, 221, 279, 382; R. Boldini, Documenti intorno… cit., pp. 55-57.
[214] B. A., Ms. F. 168 inf., c. 385 r. e segg.; R. Boldini, Documenti intorno… cit, pp. 50-52.
[215] B. A., Ms. F. 169, c, 159r.; R. Boldini, Documenti intorno… cit., p. 53.
[216] Cfr. B. A., Ms. P 24 inf. (II), cc. 405r., 406r. e v., 407 r.e v., 409 r. e v.
[217] La lettera è scritta da Giovanni Battista Sacco, il 29 luglio 1584. R. Boldini, Documenti intorno… cit., pp. 57-58.
[218] Cfr. Ibid., pp. 62-63.
[219] B. A. , Ms. F 166 inf., cc. 517 . Un’altra copia la possiamo trovare nel Ms. D 216 inf., c. 70 r e segg., che non si discosta dalla prima se non in qualche termine che non cambia il contenuto; R. Boldini, Documenti… cit., pp. 65-75. Giovanni Antonio Viscardi, detto Trontano dal luogo d’origine in Val Vigezzo, fu predicatore delle nuove dottrine a Mesocco nel 1554 circa, quando raggiunse il Beccaria (Canessa), il quale si trovava a predicare nello stesso luogo fin dal 1549, quest’ultimo parì da Mesocco nel 1560, il Trontano rimase ancora per dieci anni, lasciando,alla sua partenza, un figlio che figurerà tra gli eretici poi convertiti. Cfr. R. Boldini, Documenti intorno… cit., p. 74 in nota. Lodovico Besozzo, fu discepolo del Trontano, ma all’epoca della Visita era già morto. I tre erano molto noti come eretici.
Fra i rifugiati in Svizzera c’era il prete Giovanni Beccaria, nobile milanese, il quale possedeva dei beni a Locarno, dove aveva la cittadinanza. A Roma aveva frequentato Occhino, Carnesecchi, Vermigli e tornato a Locarno vi diffuse i loro insegnamenti “…sotto il manto di una scuola di letteratura, anzi l’arciprete che nol sospettava l’invitò a fare alcuni sermoni, che piacquero assai”. Il 19 agosto 1549, dopo una lunghissima disputa circa il testo evangelico Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam, sulla confessione auricolare, sul merito delle opere buone, il commissario che presiedeva l’evento fu talmente esasperato dalle risposte equivoche del Beccaria che dette ordine di metterlo in carcere, ma trenta giovani suoi seguaci riuscirono a liberarlo ed egli si rifugiò nella Mesolcina, dove si sposò e fece l’educatore dei figli degli italiani aderenti alla Riforma. “I Zuricani permisero erigesser una chiesa italiana nel tempio di San Pietro, con proprio pastore, che fu Giovanni Beccaria, il quale si conformasse ai riti e ai dogmi del Cantone, giurasse obbedienza al magistrato e al sinodo: provedendolo di cinquanta zecchini, centoquindici brente di vino, diciotto moggia di grano e due di avena”. Ebbe contatti con Heinrich Bullinger, famoso teologo e riformatore svizzero, ma presto i rapporti divennero burrascosi e il Beccaria fu rimosso dall’incarico e sostituito dal senese Ochino, che poco dopo fu anche lui cacciato, Beccaria tornò a Mesocco, dove gli fu permesso di restare e di istruire i giovani, cambiò il suo nome e si fece chiamare Kanesgen. In seguito fu di nuovo cacciato e trovò rifugio in Chiavenna, così scriveva ad un amico:”Dopo una lunga e grave disputa con questi nemici di Cristo, vinse la parte di mandarmi via, a patto però che i fratelli possano avere un altro predicante”. Spesso Beccaria o Kanesgen tornava a Mesocco, fiché fu cacciato con forza in seguito ad un’istanza di Borromeo nel 1571. Poche le notizie su Lodovico Besozzo e Giovanni Antonio Viscardi, detto Trontano. Cfr. C. Cantù, Gli eretici d’Italia… cit., Vol. III, pp. 85-90.
[220] Cfr. la nota n. 26 del presente lavoro.
[221] Ibid.
[222] Ibid.
[223] P. d’Alessandri, Atti di S. Carlo… cit., p. 361.
[224] Per alcune notizie su questi personaggi si rimanda alla nota n. 219 del presente lavoro.
[225]B. A. Ms. F 166 inf. c. 520 e segg.; P. d’Alessandri, Atti di S. Carlo… cit., p.354 e segg.; R. Boldini, Documenti… cit., p. 72 e segg. Riportiamo i nomi come sono scritti nel Ms. : le prime quattro sono “Madallena Lorenzona, Madallena Bollasia, Gioanina Garoppa, Caterina de Pravo”. Seguono le altre sei i cui nomi sono: “Caterina Biasela, Domenica Bollasca, Caterina Nasona, Caterina Mascietta, Nisola Pedrazza, Caterina Bolla”. Per il Prevosto Quattrino si veda a p. 22-23 del presente lavoro.
[226] I loro nomi: “Antonia Morella, Madallena Belotta, Domenica Pedranda, Caterina et Ursina de Bassoti, Gioanina Nicola, Dominica Tognetta, Madallena Bocheta, Caterina Garleta, Agata Maceta, Nisola Malagigi, Margarita Melita, Ursina et Henrico Pravi, Maffia Gera, Dominica Gasoppa”.
[227] I 56 sospettati erano i seguenti: “Maffia et Nicola de Rivio, Caterina et Gioanina de Tognallo, Caterina de Togni, Gioanina Tina, Ursina Danza, Caterina Tiocha, Hinina et Antonia de Pravo, Pietro et Gioanni de Togni, Gioanni Comascio, Beltramo Travia, Tomaso Pizzona, Domenica Julina, Ursina et Gioani del Truso, Ursina Mascieta, Margarita Simoneta, Giovanni Cabiollo, Gioanina de Togni, Maddalena de Tinti, Ursina et Margarita de Togneti, Pietro et Dominica et Maffia de Togneti, Domenica Tadea, Giulio Buslono, Maffia Stefanona, Maffia Righeta, Ursina Garleta, Petroluno de Beffeno, Domenico Trusso, Gioanina Bassolla, Gioanina Masceta, Simoni de Simoneti, Dominica Margotia, Maffiera de Megno, Caterina di Gianino, Maffia Buscona, Dominia Morellina, Madallena Toppa, Caterina Nottona, Meneghina de Tartaini, Vanina de Pravo, Madallena Barbera, Dominica et Dominico Moreli, Giacomo Trusso, Georgio Trusso, Gioanni Gero, Himina et Agostino de Simoneti, Dominica stolta”.
[228] Riportiamo i loro nomi: “Dominica Guglielmazza, Margarita Villana, Caterina de Scerro, Margarita de Gianello, Stefana Bollasca, Antonio de Pravo, Gioanina Callasia, Margarita Masceta, Gioanina et Ursina de Andrioli, Gioanina et Antonio de Pravo, Maria de Tinti, Caterina Trussa”.
[229] I liberati per l’età erano: “Angela Morina, Caterina Labertalla, Caterina Berlenga, Giacomo Giappino, Domenico Friollo, Madalena et Gioanona de Albertalli”.
[230] “Domenico Pravo, Tadeo et Dominica de Rorré (di Roveredo), Tullio Togneta, Margarita Rigazza”.
[231] In una minuta di lettera del Borromeo datata 4 luglio 1584 e diretta allo Speciano troviamo che: “…mi viene scritto ultimamente dalla Valle Mesolcina che in Musocho…” tra i comvertiti si trova Samuele eretico e figlio del Trontano. B. A., Ms. P 24 inf. (II), c. 449r.
[232] Cfr. B. A., Ms. F 166, c. 524v. e 532v. R. Boldini, Documenti intorno… cit., pp. 73-75.
[233] Cfr. http://www.lombardiabeniculturali.it/istituzioni/storia/?unita =03.05)>
[234] B. A., Ms. F 69 inf., c. 329r.; P. d’Alessandri, Atti di S. Carlo…cit., p. 357.
[235] F. D. Vieli, Storia… cit., p. 153.
[236] Cfr. http://mobile.hls-dhs-dss.ch/m.php?article=l11450.php ; si veda anche F. D. Vieli, Storia… cit., p. 162.
[237] A. Borromeo, L’opposizione all’eresia… cit., (Sur l’apothéose du cardinal Boromé in A. D’Aubigné, Oeuvres a cura di H. Weber, Paris 1970, ( Collection la Pléiade), p. 343) << Se occorreva, con la perfidia/ Fare la guerra all’eresia/ Dispensare da un giuramento pronunciato/ E fare cadere nella trappola/ Coloro che non adoravano la Santa Sede/ Si faceva ricorso a San Borromeo>>.
[238] Scipione Rebiba nacque a San Marco d’Alunzio (Messina) nel 1504, da Francesco e dalla nobildonna Antonia Filingeri dei conti di San Marco. A Palermo compì studi giuridici e si laureò in “utroque iure”; tra il 1536 e il 1537 si recò a Roma, dopo avere preso gli ordini maggiori; la sua carriera ecclesiastica si svolse sotto la protezione di Gian Pietro Carafa, fondatore dei teatini e Cardinale dal 1536. Dopo essere nominato vescovo in più sedi, Rebiba fece ritorno alla Curia, dove fu creato Protonotario apostolico, ad altre prestigiose nomine si affiancò anche quella di Ministro delegato del Santo Uffizio romano a Napoli. In questi anni il Cardinale Carafa era diventato molto potente come cardinale della Congregazione dell’Inquisizione, fondata nel 1542 e nelle sue mani il Santo Uffizio divenne uno straordinario strumento per la repressione dell’eresia e delle posizioni di dissenso interne alla Chiesa. A Napoli Rebiba fece una spietata campagna antiereticale contro i seguaci di Juan de Valdés, che, dopo la sua morte, ci fu una vasta diffusione delle dottrine valdesiane, già condannate dal Santo Uffizio, tra personaggi dell’aristocrazia e dell’alto clero. Nel 1555 il Cardinale Carafa fu eletto papa con il nome di Paolo IV, facendo della politica dell’Inquisizione quella del papato, Rebiba fu subito chiamato a Roma, dove, nello stesso anno, fu nominato Governatore della città; qualche anno prima era stato definito da un agente di Ferrante Gonzaga una “persona temerarie senza alcun rispetto”, che “procede inconsideratamente contra ognuno”. Rebiba diresse il processo contro Giovanfrancesco Lottini, segretario del Cardinale Guido Ascanio Sforza, con lo scopo di dimostrare l’esistenza di una congiura contro il Pontefice, ordita da cardinali, aristocratici italiani, agenti asburgici agevolati da Carlo V e dal figlio Filippo. Sempre nello stesso anno Rebiba fi creato Cardinale e gli fu concesso di abitare nel palazzo apostolico; con la sua formazione giuridica fu collaboratore prezioso nella complessa politica condotta dal Carafa, coinvolgendolo nella politica antiasburgica del Pontefice. Oltre che nella sfera politico-diplomatica, Rebiba ebbe incarichi molto importanti anche dal punto di vista ecclesiastico. Il 13 aprile 1556 fu nominato Arcivescovo di Pisa, anche se Cosimo de’ Medici aspirava a tale carica per il figlio Giovanni, ad eccezione di un breve periodo di residenza il nuovo Arcivescovo governò la Chiesa pisana per mezzo di vicari, lasciò tale governo nel 1560. Nel 1556 ebbe la nomina a Cardinale del Santo Uffizio rafforzando il suo impegno nella lotta contro le eresie, Paolo IV morì nel 1559, suo successore fu Pio IV . Rebiba fu accusato di coinvolgimento nell’assassionio della moglie di Giovanni Carafa, di avere contraffatto dei brevi concernenti l’Arcivescovato di Pisa e di altri crimini che portarono, la notte del 7 febbraio 1561 al suo arresto e al carcere in Castel Sant’Angelo per quasi un anno: di fronte al Tribunale ebbe un contegno reticente e sprezzante senza mai tradire i Carafa, il 31 gennaio 1562 fu scarcerato per non luogo a procedere. Fu reintegrato ed ebbe varie cariche. Con l’elezione a papa dell’inquisitore Ghisleri nel 1566, il quale prese il nome di Poi V, fu ripresa la politica del predecessore e Rebiba tornò ad abitare nel palazzo apostolico e fu riammesso nel Santo Uffizio, dove diresse importanti processi, in cui la repressione anticlericale era accompagnata da torture, roghi e abiure. Anche con il successore di Pio V, Gregorio XIII, Rebiba godette di ampie facoltà nell’ambito del Santo Uffizio e il suo contributo lo possiamo cogliere nelle lettere con le quali guidò l’azione repressiva dei vescovi e dei nunzi. Scipione Rebiba morì a Roma il 23 luglio soffocato da un boccone di cibo durante il pasto, fu sepolto nella chiesa teatina di San Silvestro al Quirinale. Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/scipione-rebiba_%28Dizionario-Biografico%29
[239] Per Giacomo Savelli si rimanda alla nota n. 104 del presente lavoro.
[240] B. A., Ms. 23 inf., c. 228r.; A. Borromeo, L’opposizione all’eresia. Apostolo e “genio” pratico della riforma, in “Il grande Borromeo tra storia e fede”, Milano 1984, pp. 223-255.
[241] Cfr. A. Borromeo, L’opposizione all’eresia. Apostolo e “genio” pratico della riforma, in “Il grande Borromeo tra storia e fede”, Milano 1984, pp. 223-255.