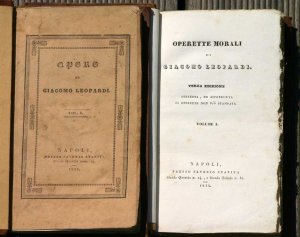Giacomo Leopardi nacque a Recanati nel 1798 in una famiglia della nobiltà clericale di provincia: il padre, conte Monaldo, era un erudito bibliofilo di idee reazionarie; la madre, Adelaide dei marchesi Antici, una donna dispotica, religiosa fino al fanatismo. Primogenito di dieci figli (ne sopravvissero cinque), Giacomo nutrì un affetto profondo per il fratello Carlo e per la sorella Paolina. Ebbe come istitutori il gesuita Giuseppe Torres e l’abate Sebastiano Sanchini; ma fu soprattutto un autodidatta, esploratore febbrile della ricca biblioteca paterna. Nel 1809 scrisse la prima poesia, il sonetto La morte di Ettore, cui seguirono altri componimenti in italiano e in latino, traduzioni da Orazio, dissertazioni filosofiche e due tragedie.

La biblioteca di Casa Leopardi
Nel luglio del 1812 Giacomo iniziò “sette anni di studio matto e disperatissimo” che contribuirono al peggioramento delle sue già precarie condizioni di salute: imparò da sé il greco e l’ebraico, intraprese lavori filologici di eccezionale impegno, stese una Storia dell’astronomia (1813) e un Saggio sopra gli errori popolari degli antichi (1815), interessante per le pagine sugli stupori infantili, sui sogni e sugli incubi notturni, sulla quiete dell’ora meridiana, sul terrore dei fulmini e delle tempeste. Dopo la sconfitta di Gioacchino Murat a Tolentino, scrisse, con spirito antifrancese, Agli’Italiani. Orazione per la liberazione del Piceno (1815). Non interrompeva intanto il suo esercizio poetico, componendo fra l’altro, nel 1816, l’Inno a Nettuno (che finse di tradurre da un originale greco), le due Odae adespotae (in greco e in latino) e l’idillio funebre Le rimembranze. Più importanti furono le traduzioni dei classici: gli Idilli di Mosco e la Batracomiomachia pseudo-omerica nel 1815, il I libro dell’Odissea e il II dell’Eneide nel 1816, la Titanomachia di Esiodo nel 1817.

Edizione delle Opere di Leopardi, Napoli 1835
La conversione letteraria
Allo studio appassionato di queste grandi opere Leopardi fece in seguito risalire la sua “conversione letteraria”, ossia la scoperta della vocazione poetica che, rivelatasi tra il 1815 e il 1816, fu in realtà il risultato di profondi turbamenti interiori che coinvolsero le esperienze letterarie. Da un lato l’angoscia per l’aggravarsi della malattia, il timore della morte, il rammarico per una giovinezza che appassiva già al suo primo fiorire: stati d’animo espressi in modi tumultuosi, ma personali, nella cantica Appressamento della morte (1816). Dall’altro un’ansia di evasione, una volontà fremente di liberarsi dalla prigionia di Recanati. Nel 1816 tentò di inserirsi nella polemica tra classicisti e romantici con una Lettera (rimasta inedita) in cui contestava l’esortazione di Madame de Staël a rinnovare la letteratura italiana attraverso la traduzione e lo studio degli scrittori stranieri. Nel 1817 iniziò la corrispondenza con Pietro Giordani, letterato classicista e liberale, che riconobbe per primo il genio del giovane poeta. Ancora nel 1817 provò l’improvvisa fiammata d’amore per la ventiseienne cugina di Monaldo, Geltrude Cassi Lazzari, che da Pesaro era venuta in visita a Recanati e che gli ispirò l’Elegia I(poi intitolata Il primo amore), l’Elegia II e il bellissimo Diario del primo amore, dove gli stadi e gli effetti dell’innamoramento sono analizzati in una prosa rapida, estremamente limpida.
Lo Zibaldone
Il 1817 fu un anno di svolta. Tra il luglio e l’agosto fissò le prime annotazioni dello Zibaldone, che crescerà a dismisura fino alla data 4 dicembre 1832, raggiungendo la mole di 4526 pagine manoscritte. Lo Zibaldone è uno sterminato laboratorio in cui si alternano pensieri filosofici e abbozzi di studi, pagine di compiuta poesia e fulminei appunti introspettivi, analisi minuziose dei congegni della memoria, dei sensi e dei sentimenti, riflessioni sui rapporti tra individuo e società, dissertazioni filologiche, considerazioni sulle lingue e sulle letterature antiche e moderne. Sono celebri le indagini minuziose sulla percezione dei suoni e sulla vista di spazi e oggetti che suggeriscono l’infinito; quelle sulla noia, sulla malinconia, sul riso, sulla giovinezza e sull’amore, un materiale che alimenterà la poesia dei Canti. L’opera fu pubblicata per la prima volta negli anni 1898-1900, con il titolo Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura; ma dal 1845 si conoscevano i 111 Pensieri, che Leopardi stesso aveva preparato per la stampa ricavandoli in gran parte dallo Zibaldone.
La conversione filosofica
La crisi personale toccò l’apice nel 1819, allorché alle altre sofferenze si aggiunse una malattia agli occhi che lo costrinse a rinunciare anche alla lettura. Nel luglio un tentativo di fuga dalla casa paterna (per un viaggio a Roma) venne subito scoperto e sventato da Monaldo. Intanto l’ansia e lo scetticismo filosofico radicalizzavano la scoperta del nulla (“Io era spaventato nel trovarmi in mezzo al nulla, un nulla io medesimo. Io mi sentiva come soffocare, considerando e sentendo che tutto è nulla, solido nulla”, Zibaldone). Che la realtà sia il nulla e che il nulla sia “solido”, sia fatto di materia, abbia un corpo, è il tragico paradosso alla base del pensiero leopardiano, in cui si generano a catena altri paradossi: l’enigma che il nulla-materia nasconde in sé provocando dolore è un gigantesco interrogativo pietrificato che la natura dissemina in mille frammenti, coinvolgendo nella sua inquietante domanda l’esistenza dei mortali. E dall’arcano “mirabile e spaventoso” racchiuso nel nulla nasce il bisogno disperato delle “illusioni”, anch’esse concepite e sentite nella sfera della corporeità, piaceri “vani” ma “solidi”. Nell’orizzonte del “nulla” Leopardi affrontò i grandi temi che erano stati al centro del pensiero settecentesco e che riemergevano, con soluzioni diverse, nel dibattito romantico: in solitaria meditazione, mise a fuoco una serie di antitesi. La prima antitesi è quella, risalente a J.-J. Rousseau, tra natura e ragione: la natura tende alla felicità, la ragione la distrugge; la natura è il regno del “bello”, delle illusioni, della poesia, mentre la ragione, portatrice del vero, inaridisce il cuore e dissolve i sogni. Il dualismo poesia-filosofia si tradurrà dunque nel contrasto fra “poesia di immaginazione” e “poesia sentimentale”. Per Leopardi la poesia autentica è soltanto la prima, perché prodotta dalla fantasia creatrice di miti; ma i moderni, immersi nell'”arido vero”, non sono capaci che di poesia sentimentale, una sorta di filosofia. Il riconoscimento dell’inevitabilità di una poesia nutrita di pensiero avvicinava Leopardi ad alcune posizioni dei romantici, ma con precisi limiti e insanabili dissensi. Nel Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica (iniziato nel 1818) egli accettava i postulati critici della scuola romantica (il rifiuto dell’imitazione degli antichi e dell’abuso della mitologia), mentre dei principi costruttivi condivideva soltanto l’interesse per il “patetico”, interpretando però questa categoria come una dolorosa necessità, una rinuncia, senza adeguato compenso, al conforto della fantasia.
I primi canti
Constatato il nulla universale, la poesia di Leopardi nasceva nel segno della precarietà, come paradosso, scommessa, tentazione: nasceva nel momento stesso in cui il poeta aveva decretato la morte della poesia. Dopo il fallimento di alcuni esperimenti romantici, la vera poesia leopardiana cominciò e si sviluppò su due registri distinti: le nove canzoni (1818-22) e i cinque idilli (1819-21), che costituiscono il primo nucleo di quello che diverrà il libro dei Canti, un “libro” che prenderà forma attraverso pubblicazioni parziali, incrementi, correzioni assidue del lessico e dello stile, passando per tre tappe fondamentali: l’edizione Piatti (Firenze, 1831), con 23 poesie; l’edizione Starita (Napoli, 1835) con 39 poesie; l’edizione postuma Le Monnier (Firenze, 1845), con 41 poesie.

Le canzoni
Delle nove canzoni, le prime cinque sono in parte ispirate dalla proposta di Giordani di una poesia come “magistero civile” su modelli classici, ma anche dall’ansia indeterminata di grandi azioni che Leopardi manifestò più volte nelle lettere e nello Zibaldone. All’Italia e Sopra il monumento di Dante, del 1818, trattano di temi esplicitamente patriottici, avendo in comune il paragone tra un passato glorioso e un presente umiliato dalla schiavitù e dalla viltà. Anche la canzone Ad Angelo Mai (1820) è inizialmente impostata come esortazione alla riscossa civile, sennonché la decadenza e l’impotenza dell’oggi si estendono qui a condizione generale dell’umanità, che ha perso le illusioni di un felice stato naturale per precipitare in un’epoca dominata dalla nefasta cognizione del “vero”, generatrice della noia e del nulla.

Lo Zibaldone nella sua prima edizione, venne pubblicato col nome Pensieri di varia filosofia e bella letteratura tra il 1898 e il 1900.
Si delinea perciò un pessimismo radicale che si confermerà nelle Nozze della sorella Paolina(1821): crollata ogni speranza di intervenire sul presente, la virtù viene esaltata stoicamente per se stessa. In A un vincitore nel pallone (1821) si esaltano, per se stessi, l’agonismo e il rischio, rimedi unici a un’esistenza svuotata di qualsiasi valore e significato; la terribile conclusione (“Nostra vita a che val? solo a spregiarla”) segna il passaggio alle due grandi allegorie dell’infelicità umana, Bruto minore (1821) e l’Ultimo canto di Saffo (1822), dove ormai la natura non è più madre benigna ma crudele matrigna. Bruto morente distrugge il mito della virtù e, con il suicidio, si erge titanicamente contro la divinità insultandola. Saffo, “dispregiata amante” perché la natura le negò la bellezza, si vota anche lei al suicidio, ma la sua protesta, a differenza di quella di Bruto, ha intonazioni elegiache, intimamente dolenti e appassionate. Funzione di duplice congedo, dalle “favole antiche” dei pagani e dalla mitologia biblica, assolvono infine le altre due canzoni del 1822, Alla primavera e l’Inno ai patriarchi.

La prima pagina della canzone All’Italia, con le correzioni di mano di Giacomo Leopardi
Gli idilli
Gli idilli veri e propri (“idilli, esprimenti, situazioni, affezioni, avventure storiche del mio animo”) sono cinque: L’infinito (1819), Alla luna (1819), La sera del dì di festa (1820), Il sogno(1820-21), La vita solitaria (1821). Rispetto alle canzoni, le “situazioni idilliche” sono tutte concentrate e risolte nel soggetto: sono brani della “storia di un’anima”, che si svolgono in un determinato spazio e in un preciso momento, messi sempre in relazione, tramite la memoria, con altri momenti e con altre “avventure” interiori già sperimentate. Il mutamento è anche nello stile: non più l’ardua sintassi, il lessico fitto di arcaismi e latinismi delle canzoni, ma un linguaggio piano, che accosta sapientemente parole rare a parole trasparenti e quotidiane. Capolavori assoluti sono i componimenti brevi, L’infinito e Alla luna, che condensano, rispettivamente, la sensazione di vertigine davanti a un infinito suggerito per contrasto da elementi “finiti” e il piacere di una “rimembranza” sollecitata da un sublime, affettuoso dialogo con la luna.

Il silenzio poetico
Tra il 1822 e il 1828 la poesia leopardiana tacque, con due sole eccezioni: la canzone Alla sua donna (1823) è un addio alla donna ideale irraggiungibile, simbolo della poesia che fugge; l’epistola Al conte Carlo Pepoli (1826) è un componimento finissimo, in tono tra oraziano e pariniano, che imprime nuovo suggello a una stagione creativa che Leopardi ritiene definitivamente conclusa (nel finale egli dichiara di abbandonare la poesia per gli studi dell’”acerbo vero”). Furono sei anni tuttavia, questi del “silenzio”, di esperienze vive che portarono il poeta lontano dal “natio borgo selvaggio”. Nel novembre del 1822 andò a Roma, presso lo zio Carlo Antici, ma la città e il suo ambiente erudito-archeologico lo delusero profondamente: soltanto la visita all’umile tomba del Tasso lo commosse fino alle lacrime. Tornato a Recanati nel 1823, ne ripartì nel 1825, accettando l’offerta di curare per l’editore milanese Antonio Fortunato Stella un’edizione delle opere di Cicerone. Poi fu a Bologna, a Firenze (dove frequentò il Gabinetto Vieusseux e il gruppo dei liberali toscani) e a Pisa, che gli offrì il soggiorno più gradito e salutare.
Le “Operette morali”
Leopardi scrisse quasi tutte le Operette morali tra il 1824 e il 1827. In esse si rintracciano alcuni temi centrali: quello dell’illusione e della felicità impossibile (per esempio, in Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo); quello della natura e del piacere (Dialogo della Natura e di un’Anima, Dialogo della Natura e di un Islandese); quello della noia peggiore del dolore (Dialogo di Torquato Tasso e del suo Genio familiare, Dialogo di Cristoforo Colombo e di Pietro Gutierrez); quello che riguarda, più in generale, la responsabilità dell’individuo verso se stesso e verso la società (Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie). Nuove tematiche introducono prose più tarde (1832), come il Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere e il Dialogo di Tristano e di un amico, nelle quali affiora una visione più pacata e insieme più eroica della vita. Le Operette sono a un tempo un libro di filosofia e di poesia: idee e ragionamenti si trasfigurano quasi sempre in immagini e allegorie, grazie a una prosa lavoratissima che rinnova modelli antichi (soprattutto i dialoghi di Luciano) con “leggerezza apparente”, con soluzioni originali e vivaci che consentono l’alternanza di meditazione e ironia, di aperture liriche e serrati scambi dialettici.
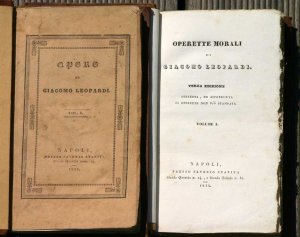
I “Grandi idilli”
Durante il soggiorno a Pisa, nel 1828, Leopardi scrisse alla sorella Paolina parole che annunciavano la sua rinascita alla poesia: “Dopo due anni, ho fatto dei versi quest’Aprile; ma versi veramente all’antica, e con quel mio cuore d’una volta”. I versi erano Il risorgimento e A Silvia. Seguirono i canti Il passero solitario, Le ricordanze, La quiete dopo la tempesta, Il sabato del villaggio, il Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, composti tra il 1829 e il 1830 a Recanati, dove il poeta era stato costretto a ritornare nel novembre del 1828, perché gli era stato sospeso l’assegno dello Stella e perché le sue condizioni di salute erano peggiorate. Si trattenne poco meno di un anno e mezzo, soffocato da una malinconia che era “oramai poco men che pazzia”; in quella disperazione nacque la maggior parte dei cosiddetti “grandi idilli”, la cui composizione era stata preceduta da un lungo approfondimento teorico della poesia come pura lirica svincolata dall’imitazione, dalle regole, da fini pratici. “Canto” è la denominazione che si afferma in questo periodo, e Canti sarà il titolo dell’edizione del 1831, sancito in quella del 1835: un titolo senza precedenti, nella tradizione letteraria italiana, che cancella ogni indicazione di “genere” e “sottogenere” per esaltare la poesia “senza nome”, la poesia in assoluto.

Una pagina con i versi “A Silvia“
Il risorgimento è una singolare celebrazione della “rinascita del cuore” composta in strofette metastasiane. Su tutt’altro registro i capolavori successivi: A Silvia, canto alla giovinezza perduta e non goduta; Le ricordanze, canto che nasce dalla memoria di un mondo e di un’età popolati di fantasie e illusioni; Il canto notturno di un pastore errante dell’Asia è rivolto al mistero della natura e dell’esistenza. Il sabato del villaggio e La quiete dopo la tempesta formano il dittico degli “apologhi del borgo” e per situazioni e stile possono essere avvicinati solo al Passero solitario, in cui rifluisce la “rimembranza”, tema dominante, nella prospettiva limpida e “mitica” del villaggio e della casa paterna: il paesaggio e la memoria diventano improvvisamente luoghi e figure da favola, in cui si condensa una struggente nostalgia di sogni e fantasie della fanciullezza. Nel Canto notturno la meditazione e la liricità si fondono entro più vasti orizzonti: lo spazio del borgo è sostituito da uno spazio desertico, ignoto e sconfinato; la voce del poeta diventa quella di un misterioso “pastore errante” che interroga la luna con una serie di incalzanti domande sul perché della propria esistenza, sul perché della vita e dell’universo.

Il risorgimento, vv. 1-20: autografo conservato nella Biblioteca Nazionale «Vittorio Emanuele III» di Napoli.
La nuova poetica e gli ultimi canti
Nel 1830, accettato un prestito dagli amici fiorentini, Leopardi lasciò per sempre Recanati. A Firenze riallacciò antichi rapporti e altri ne strinse, fra cui quello con l’esule napoletano Antonio Ranieri (che diverrà l’inseparabile “sodale” degli ultimi anni) e quello con l’affascinante Fanny Targioni Tozzetti, che gli accese una violenta e sfortunata passione. Dal 1833 visse, sempre più malato, a Napoli, dove morì il 14 giugno 1837.
Tutta l’ultima fase della vita di Leopardi è caratterizzata dal rifiuto del suo passato di sdegnosa o malinconica solitudine. Nel dissolversi dell’energia fisica, egli avvertiva un prepotente bisogno di affermare il proprio io, la propria filosofia “disperata ma vera” contro ogni facile visione ottimistica della realtà. Di qui il suo disprezzo per le filosofie spiritualistiche del tempo e la derisione dell’ingenuo entusiasmo dei liberali (nella Palinodia al marchese Gino Capponi del 1835, nella satira I nuovi credenti e nel poemetto Paralipomeni della Batracomiomachia, dello stesso periodo). Di qui, soprattutto, gli ultimi canti del cosiddetto “ciclo di Aspasia” (composti fra il 1832 e il 1835), ispirati da un amore negato (la passione per Fanny) eppure interamente vissuto e sofferto con i sensi e con l’anima; le due canzoni “sepolcrali” (Sopra un bassorilievo antico sepolcrale e Sopra il ritratto di una bella donna, 1834-35), così ricche di pietas nella dolente ma ferma meditazione sulla morte.
Il “ciclo di Aspasia” è la storia completa di un amore, dalla fase “positiva” (Il pensiero dominante, Consalvo, Amore e Morte) a quella “negativa” di rivelazione dell’inganno (A se stesso, Aspasia). È sorretto, per l’intera durata, dal binomio inscindibile di “ideologia e canto”, nel senso che alla rappresentazione della vicenda passionale si associa costantemente il ragionamento su di essa.
Il tramonto della luna celebra le esequie dell’”inganno idillico”: il paesaggio lunare viene ridescritto con le parole tenere di un tempo, ma solo come “quadro di paragone”, appunto per essere posto in simmetrico contrasto con la “vita mortal” che, a differenza delle “collinette e piagge”, una volta sopraggiunta la notte (la vecchiaia), non si colorerà “d’altra aurora”.
La chiusura del “libro” (escludendo Imitazione, Scherzo e i cinque Frammenti, che costituiscono una sorta di appendice) è invece affidata alla Ginestra, una poesia di ampia e potente orchestrazione, che non suona affatto “congedo”, al contrario riprende motivi antichi, ora rimeditati, con formulazioni e cadenze nuove, ideologiche e stilistiche. Domina il tema cosmico, il paesaggio desertico, vulcanico, con rovine, che spalanca un devastato spazio terrestre in opposizione al sovrastante spettacolo delle stelle che fiammeggiano “in un purissimo azzurro” riflettendosi nel mare. Viene inoltre ripresa la polemica contro il “secol superbo e sciocco” che crede nelle “magnifiche sorti e progressive”, ignorando la ferocia ineluttabile della natura distruttrice. Ma è una polemica che perde qualsiasi punta di animosa asprezza, perché il titanismo leopardiano si sposa ora interamente alla pietà, risolvendosi in un messaggio di fratellanza tra gli uomini, accomunati da un medesimo destino di infelicità.
Lucica Bianchi