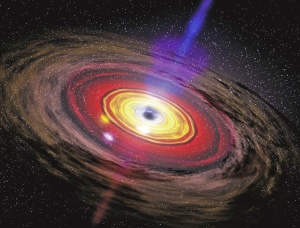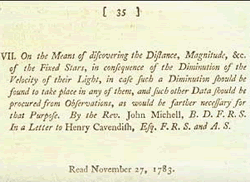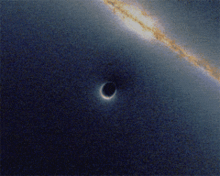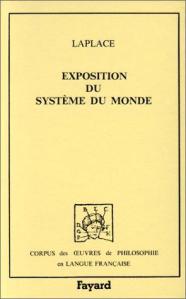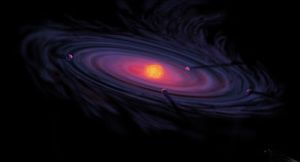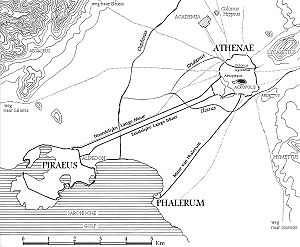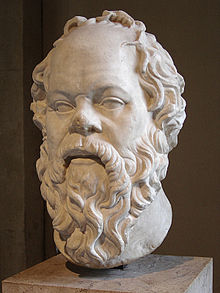TALAMONA 2 novembre 2013 presentazione di un libro alla Casa Uboldi
“VALTELLINESI SCHIAVI DI HITLER”
ATTRAVERSO IL LIBRO SCRITTO DA PIERLUIGI ZENONI RIVIVE UNA PAGINA DOLOROSA DEL NOSTRO PASSATO RECENTE
Una serata per vivere in leggero anticipo ed in modo profondo il 4 novembre che ricorda la vittoria dell’Italia sul fronte alpino contro l’Austria a Vittorio Veneto nel 1918 e che è divenuta la festa nazionale delle forze armate. Una serata, come ha sottolineato l’assessore alla cultura Simona Duca, “per abbattere o quantomeno scalfire un clima di ignoranza storica generale che nasce da una profonda diffidenza verso questa materia fin già sui banchi di scuola”. Nonostante il 4 novembre, come abbiamo detto, riguardi le battute finali della Grande Guerra, questa sera, come di già lo scorso anno, i riflettori sono stati puntati sul secondo conflitto mondiale. “Momenti storici relativamente vicini al nostro presente” ha detto ancora l’assessore “e che dunque si crede di conoscere bene. Momenti che, studiati a scuola, occupano solo qualche pagina illustrata del libro di testo, raccontando però, in questo modo, solo il 10% di tutta la storia realmente accaduta. Il restante 90% riguarda il modo in cui la grande Storia e i suoi avvenimenti si ripercuotono sulla vita quotidiana delle persone che, almeno per quanto riguarda la storia recente, molto spesso possiamo trovare ancora accanto a noi, magari proprio di fronte a casa nostra. Storie di cui molto spesso la gente non vuole parlare perché il dolore vissuto è ancora molto forte. Storie che comunque faticano a trovare orecchie che le ascoltino. Storie che devono essere conservate come un patrimonio”. Storie che il signor Pierluigi Zenoni ha raccolto nel libro VALTELLINESI SCHIAVI DI HITLER edito dalla CGL e in vendita per 10 euro. Storie che in parte questa sera il signor Zenoni ha raccontato ad un pubblico numeroso ed appassionato. Un racconto che ha voluto essere una sorta di esperimento: riuscire a trascorrere un’ora parlando di storia senza annoiare uscendo dai trattati e dai metodi accademici per far parlare direttamente i protagonisti, perché infondo la Grande Storia non è altro che la sommatoria di tante piccole storie di persone, (perlomeno di quelle che si riesce a conoscere ndr). Per capire queste storie è stato però necessario contestualizzarle con una piccola introduzione scolastica.
L’Italia è entrata in guerra il 10 giugno 1940. L’annuncio è stato dato da Mussolini dal balcone di Piazza Venezia con un discorso infuocato accolto da un mare di ovazioni. Un’entrata in guerra motivata dalla cieca fede nella strategia bellica dell’alleato tedesco Hitler, dalla convinzione che la guerra si sarebbe risolta in pochi mesi e dalla volontà di, come disse lo stesso Mussolini ai suoi generali “mettere sul tavolo delle trattative per la spartizione dell’Europa le vite di qualche migliaio di uomini”, vite in cambio di una vittoria trionfale riguardo alla quale, nel 1940, non si nutriva alcun dubbio. Nel 1943 però la situazione era completamente diversa. Nel febbraio di quell’anno i Russi ruppero l’assedio di Stalingrado, mettendo in fuga le truppe tedesche e mettendo così fine al piano di Hitler per invadere la Russia, denominato operazione Barbarossa cui anche l’Italia partecipò pagando il prezzo di 80 mila uomini tra morti, dispersi e prigionieri, uomini che il fascismo aveva inviato malvestiti e ancor peggio equipaggiati e che i Russi ancora oggi ricordano per l’umanità dimostrata loro che li distinse nettamente dagli alleati tedeschi. Nel marzo del 1943 in Italia si verificò un generale risveglio delle coscienze che portò ad un sempre più diffuso e conclamato dissenso verso il fascismo. Nelle fabbriche del nord Italia si tennero degli scioperi in favore della pace. Anche in Vaticano, Mussolini da tempo non veniva più considerato l’uomo della provvidenza così come lo era stato ai suoi esordi. Gli alleati il 10 luglio 1943 sbarcarono in Sicilia e da li cominciarono la lenta risalita lungo la nostra penisola. Dopo il voto contrario del gran consiglio del fascismo, il 25 luglio del 1943, il re, per salvare il salvabile, ovvero la monarchia, destituì e fece arrestare Mussolini nominando al suo posto il maresciallo Pietro Badoglio, un uomo dalla reputazione non proprio limpida in quanto considerato il principale responsabile della disfatta italiana durante la campagna in Grecia. Tra questi avvenimenti e l’armistizio intercorsero circa 45 giorni definiti dallo storico Giovanni Procacci “uno di quei periodi storici in cui la farsa si mescola con la tragedia”. L’atteggiamento che il re e Badoglio tennero in quel periodo fu infatti dubbio, duplice. Mentre da un lato riconfermarono la fedeltà all’alleato tedesco dall’altro intavolarono segretamente con gli angloamericani le trattative che avrebbero portato all’armistizio stesso annunciato via radio da Badoglio l’8 settembre 1943. Dopodiché il re e Badoglio ripararono al sud nei territori occupati dagli angloamericani, mentre i tedeschi scesero in Italia conquistandone ¾ al nord con l’intenzione di vendicarsi dei traditori. Uno storico tedesco, Gerard Streinger, fece una stima di tutto ciò che i tedeschi sequestrarono: 1 milione e 300 mila fucili, 39 mila mitragliatrici, 15 mila tra cannoni e mortai 17 mila automezzi e mezzi corazzati, ma soprattutto 700 mila soldati dell’esercito italiano lasciato allo sbando e senza ordini. Soldati che vennero caricati sui carri bestiame e spediti come merci nei campi di sterminio. Tra questi 5 mila erano valtellinesi. La storia, fatta di tante piccole storie, che il signor Zenoni ha raccontato nel libro e sintetizzato questa sera comincia da qui. Un corollario di storie tutte piuttosto simili tra loro. Ventisette storie udite direttamente dalla voce di chi le ha vissute e altre 140 raccolte indirettamente da varie fonti. Storie che, persino per chi ci è passato non sembrano vere. Storie che tutte insieme sembrano creare una sorta di film partorito da uno sceneggiatore folle, un film surreale dove in un lasso di tempo molto breve si passa dalla gioia più sconfinata al dolore più cupo. L’8 settembre l’Italia era in festa. Si pensava che con la proclamazione dell’armistizio fosse finita anche la guerra, si pensava che il peggio fosse passato e che presto si sarebbe potuti tornare a condurre una vita normale in famiglia, tornare dai genitori, dalle mogli, dai figli, al proprio lavoro. Anche e soprattutto i soldati ancora sotto le armi pensavano questo. Un gruppo di valtellinesi di stanza a Vercelli nel reparto carrettieri che non avevano però ancora mai guidato un carro armato, la sera dell’8 settembre stavano in una trattoria a consumare una cena a base di riso e rane innaffiata con vino mentre la radio trasmetteva una canzonetta improvvisamente interrotta per lasciar posto all’annuncio dell’armistizio. Un gruppo di alpini di Merano dopo aver sentito pure alla radio l’annuncio dell’armistizio lanciò un coro di grida dicendo in dialetto “è finita”. Solo un vecchio caporale non condivise la gioia dei commilitoni e borbottava sempre in dialetto “staremo a vedere”. Un altro gruppo di alpini stanziato nella zona del Brennero una volta appresa la notizia dell’armistizio liberò i muli e festeggiò incendiando la paglia nelle stalle. A Busto Arsizio un gruppo di soldati stava in una sala di un cinema a guardare un film sull’impero romano quando entrò un giovane ufficiale a gridare la notizia dell’armistizio. Non trascorse nemmeno un giorno da questa euforia collettiva che subito tutti quelli che si erano sentiti liberi e di nuovo felici si ritrovarono catapultati in orrori ancora peggiori di quelli riservati dalla guerra. Il 9 settembre mentre i capi militari, disordinatamente e con ben poca dignità, fuggivano accalcandosi su una nave messa a disposizione dagli angloamericani sul porto di Ortona, i tedeschi scesero in Italia a disarmare l’esercito ignaro di ciò che stava accadendo e del perché la situazione fosse precipitata in quel modo. In 90 mila si dichiararono subito pronti a collaborare coi tedeschi in 200 mila scapparono e molti di questi ripararono in Svizzera. Chi non riuscì a scappare, ma non volle collaborare coi tedeschi venne caricato sui carri bestiame verso i campi di concentramento del Reich. In vagoni molto stretti venivano stipate anche 40- 50 persone per vagone, costrette a viaggiare ognuno seduto sulle gambe del vicino e costretti a fare i propri bisogni li dove si trovavano davanti a tutti. I viaggi duravano all’incirca dai 4 ai 13 giorni in relazione alla località di partenza ed erano frequenti le soste nelle principali città del Reich come ad esempio Vienna ove gli italiani subivano delle sorte di forche caudine. Fatti scendere dai treni venivano costretti a camminare tra due ali di folla inferocita che tirava loro sassi e altri oggetti chiamandoli traditori e urlando loro “Badoglio” come colui che aveva proclamato l’armistizio. L’ultima parte del viaggio sino ai lager molti la fecero a piedi. Si trattava di campi diversi da quelli di sterminio, dove gli Ebrei morivano. I tedeschi selezionavano i loro prigionieri e ad ogni tipologia destinavano un particolare tipo di punizione. Con gli italiani dopo il 1943 e coi russi colpevoli di averli fatti ritirare da Stalingrado si dimostrarono particolarmente duri. Nonostante i loro campi fossero lontani da quelli dove venivano sterminati Ebrei, omosessuali, oppositori eccetera ai nostri soldati capitò di quando in quando di avere a che fare con questi prigionieri e di assistere a orrori inimmaginabili. Videro partigiani torturati, parlarono con prigionieri che dissero di aver ricevuto, per potersi lavare, il sapone fatto coi cadaveri degli altri prigionieri. Tutti in generale subirono il processo di spersonalizzazione che caratterizzò in modo particolare la realtà dei lager. Effetti personali sequestrati, un numero cucito sulla divisa e tatuato sul braccio come unico identificativo, un numero di molte cifre che nessun prigioniero ha mai più scordato per il resto dei suoi giorni, gli italiani sempre apostrofati Badoglio, un nome ormai divenuto epiteto. Tutti in generale soffrirono la fame e la fatica dei lavori forzati fino alla più nera disperazione, tutti cercavano da mangiare e di sopravvivere come potevano dovendo fare attenzione che i tedeschi non scoprissero mai che ad esempio rovistavano tra i rifiuti per cercare il cibo o che qualcuno aveva tenuto nascosti oggetti personali da barattare con pezzi di pane, perché altrimenti sarebbero stati duramente puniti. Bisogna considerare che i soldati catturati che hanno fornito le testimonianze raccolte nel libro all’epoca avevano 19 anni molti hanno compiuto i 20 durante la prigionia. Erano ragazzi tutto sommato sempre più magri e spossati che vedevano aumentare col tempo l’intensità dei loro patimenti e delle violenze,le beffe di vedersi dare dei biglietti con cui comprare beni nei pochi spacci dei lager dove non c’era mai nulla di quanto sarebbe stato necessario. Ad un certo punto dal 1944 arrivarono i permessi di comunicare con le famiglie e farsi mandare da casa i beni di prima necessità, ma questi pacchi non arrivavano mai a destinazione, perché chi era addetto al loro recapito spesso e volentieri se li teneva per se e poi molto spesso anche le famiglie rimaste a casa vivevano in miseria e non avevano nulla da mandare. Disperati, affamati, laceri, infestati di pidocchi, stipati nei capannoni, era rimasta loro, come unica libertà, quella di raccogliersi in preghiera durante la notte. Nonostante tutto questo, la giovane età e le sofferenze, questi ragazzi rifiutarono per ben tre volte di barattare la libertà in cambio della loro promessa di schierarsi con i tedeschi. La Germania era ormai accerchiata su più fronti dagli Alleati, bombardata, anche i campi venivano bombardati perché vi si fabbricavano tra l’altro armi grazie al lavoro forzato dei prigionieri. Molto spesso i nostri ragazzi vennero mandati a ripulire le macerie e ci andavano volentieri sperando di trovare qualcosa da mangiare, ma fintanto che i bombardamenti avevano luogo tutti rischiavano la loro vita. Man mano che gli Alleati avanzavano liberavano questi campi, ma per gli italiani il fatto di essere liberati dai russi rappresentava un’enorme fonte di preoccupazione, in quanto gli italiani avevano invaso la Russia accanto ai tedeschi e temevano ritorsioni che in qualche caso si sono verificate anche perché la propaganda fascista descriveva i soldati in Germania non come prigionieri, bensì come collaboratori, nonostante i loro ripetuti rifiuti di collaborare. Solo quando i soldati poterono raccontare tutta la verità sulla loro detenzione in Germania le ritorsioni cessarono e i ragazzi furono davvero liberi. La libertà ritrovata li portò ad assaltare le cantine delle famiglie ricche e ad abbuffarsi di ciò che trovavano morendo a volte di indigestione perché i loro stomaci non erano più abituati ad assimilare il cibo, li portò ad ubriacarsi. Mentre i soldati erano prigionieri in Italia nel frattempo si era cominciato a catturare le donne per spedirle in Germania a sostituire gli uomini che andavano a combattere. Alcune di queste, ad esempio le impiegate di una fabbrica di Morbegno, la Bernascone, scioperarono per ben due volte per non essere mandate in Germania e la spuntarono. Tutte in seguito dovettero temere, oltre alle deportazioni, l’esuberanza delle truppe di liberazione. Era un clima davvero molto confuso. In un primo tempo nel cuore degli italiani liberati, in una Germania ridotta ad un cumulo di macerie, c’era spazio solo per un profondo odio verso i tedeschi, poi trovò spazio anche la pietà, soprattutto verso quei carcerieri che si sono dimostrati a loro volta pietosi. Una volta che fecero ritorno in Italia trovarono ad accoglierli un clima di ostilità, freddezza, diffidenza. Le voci dei fascisti che dichiaravano la loro presenza in Germania come frutto di una libera scelta avevano attecchito come una pianta malefica. Nessuno voleva ascoltare le loro storie, la loro sofferenza, il coraggio di continuare a sopportare tutto pur di non aiutare i tedeschi contribuendo in questo modo alla liberazione dell’Italia e costituendo in qualche modo l’altra faccia della Resistenza. Essi furono come disse il già citato storico tedesco Gerard Streinger “traditi, disprezzati e dimenticati” dovendo subire la beffa di non essere nemmeno riconosciuti come prigionieri politici. I tedeschi infatti li avevano internati come IMI cioè internati militari italiani e questo fece si che per lungo tempo si decretò che essi non avevano diritto, come ad esempio gli Ebrei, ad alcun risarcimento che arrivò solo dopo 65 anni e non tutti poterono ritirarlo. Ed è questo il principale motivo per cui il signor Zenoni ha scritto il suo libro. Ricordare vicende poco conosciute, onorare queste persone, le loro vite, i loro sacrifici, per ricordare a tutti su che base poggia la nostra democrazia presente, la nostra costituzione e di quanto dolore è impastato il nostro Paese. Per ricordarlo a tutti, ma soprattutto ai giovani affinchè si ricordino di questi ragazzi di ieri e del loro coraggio. A tal proposito il signor Zenoni ha ricordato, una volta terminato il suo intervento, che la CGL si impegna a risolvere le pratiche burocratiche relative a questi riconoscimenti per cui chiunque avesse uno o più parenti coinvolti in queste vicende vi si può rivolgere gratuitamente.
Si è conclusa così una serata interessante ed istruttiva che ha permesso di dare un valore aggiunto, un tocco più umano alla storia studiata a scuola, una serata ulteriormente arricchita dagli interventi del sindaco Italo Riva e dell’assessore alla cultura Simona Duca nonché di Franco Tarabini, presidente dell’associazione combattenti, che, alle storie raccontate questa sera dal signor Zenoni, hanno voluto aggiungere quelle di loro parenti e conoscenti tutte accomunate dalla reticenza che tutte queste persone hanno nel raccontare tutto ciò che è loro accaduto, una reticenza che spesso comporta la perdita di interi capitoli di Storia, capitoli che invece bisogna impegnarsi a fondo a conservare.
Antonella Alemanni