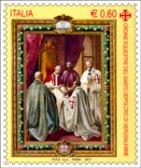Nelle sale di un museo dedicato alla civiltà dell’antico Egitto, ci vengono incontro da ogni parte ibride figure di divinità, le quali su un corpo umano ergono la testa di un leone o di uno sciacallo, oppure statue di animali con la testa umana.
Vediamo immagini di sovrani prostrati in adorazione di un toro. Nelle vetrine si allineano mummie di gatti, di falchi, di coccodrilli, imbalsamate e fasciate di bende con la stessa cura usata per i corpi umani.
Stele raffigurante Anubi -il dio con la testa di sciacallo, Museo del Louvre, sezione Egitto Antico
Divinità egiziana con la testa d’Ariete,Museo del Louvre, Sezione Egitto Antico.
Forse è proprio questo culto degli animali, così vistoso e onnipresente, l’aspetto della cultura egiziana che ci sembra più impenetrabile e più estraneo alla nostra mentalità occidentale, quasi il prodotto di una fantasia insieme esuberante e affascinante. Pure, se proviamo a seguire l’evoluzione storica che sta alla base della concezione degli animali divini, la fede degli Egiziani ci apparirà immediatamente più limpida.
L’Egitto era in origine abitato da tribù nomadi. Non si trattava di una divisione territoriale, quanto di gruppi, relativamente numerosi di individui che si stimavano parenti ma non in base a un concetto di consanguineità simile al nostro: la parentela fra i membri di un clan era dovuta al fatto che essi si consideravano tutti portatori di un medesimo totem.
Il totem è un essere inanimato, molto spesso un animale o una pianta, da cui l’intero gruppo credeva di discendere e che serviva come emblema. E’ inutile dire che vigeva il divieto assoluto di uccidere e di mangiare l’animale-totem.

Le rovine del cortile del toro Api, a Saqqara, dove viveva l’animale sacro, simbolo della fecondità. Alla sua morte i sacerdoti egiziani partivano alla ricerca di un torello che presentasse le “tre macchie tradizionali”,( una macchia nera in forma di scarabeo sulla lingua, una bianca, quadrata, sulla fronte e una sul dorso a forma di aquila) caratteristiche del toro sacro Api.
Col trasformarsi dei clan in unità territoriali dovuto alla crescente importanza dell’agricoltura, la venerazione per l’animale capostipite non venne meno, ma si trasformò tuttavia profondamente, perché l’emblema totemico divenne la divinità locale di ciascun villaggio, il cui simbolo si trova riprodotto come segno di identificazione su vasi, sarcofagi e altri oggetti quotidiani.
Tale è il caso del toro Api, l’animale sacro di Menfi, considerato un simbolo della procreazione, identificato anche col Sole come mostra il disco d’oro che, nelle raffigurazioni pittoriche, porta tra le corna. Proprio quest’ultimo particolare ci dice quanto fosse remota l’antichità del suo culto, perché lo ritroviamo in graffiti preistorici del Sahara libico. L’animale godeva di una profonda venerazione e quando veniva a morte si celebravano per lui esequie che richiamavano un grande concorso di fedeli giunti, cariche di offerte, da tutto il paese. Il corpo era imbalsamato con ogni cura e trasportato in processione in un’isola vicina dove veniva sepolto in un grande sarcofago di granito, nei sotterranei di un tempio.
Se dei tori Api possiamo ancora contemplare i corpi mummificati, circondato di mistero ci appare un altro antico animale sacro, la fenice di Eliopoli intorno a cui fin dall’antichità si intrecciarono strane leggende. Si diceva vivesse cinquecento anni e più tardi si favoleggiò che la fenice fosse immortale. Allorché era vicina alla morte, si costruiva una specie di nido di erbe profumate in cui bruciava, quando per il calore del Sole, quelle prendevano fuoco. Dalle ceneri, la fenice risorgeva giovane e rinnovata.
Io sono quel grande uccello Benu a Eliopoli,
che decide quello che deve e quello che non deve essere.
Chi è questo? Il Benu di Osiride in Eliopoli.
Ciò che è e ciò che sarà è il suo corpo,
è l’eternità e la perpetuità.
Libro dei Morti, capitolo XVII
Nella città di Eliopoli esisteva un particolare tempio dove venivano venerati due aspetti del dio creatore Atum-Ra: il benben, una pietra dalla forma conico-piramidale, e l’uccello benu che i Greci chiameranno fenice. Questo tempio, detto Hat-benben o Hat-benu (Casa della pietra o Casa della fenice), aveva come simbolo la figura di un grande uccello appollaiato al di sopra della pietra conica. Entrambe le parole derivano dal verbo wbn, con il significato di “elevarsi, brillare”, con evidente collegamento all’astro solare, venerato nel santuario.
La fenice e il benben erano strettamente legati nel mito della creazione eliopolitana. Il benben, particolare pietra dalla forma conica, probabilmente un meteorite ritrovato ad Eliopoli in tempi antichissimi, rappresentava la prima terra emersa dall’Oceano Primordiale, il primo atto creativo di Atum, originatasi da una goccia del suo seme caduta nella discesa delle acque. Il benben era il nucleo originario della creazione, perché a partire da esso si sarebbe aggregata tutta la materia dell’universo. Su questa prima terra emersa dalle acque, la Collina Primordiale, il dio Atum si sarebbe manifestato per la prima volta in forma di astro solare per illuminare e vivificare tutto il creato. A questo punto un maestoso uccello, nelle forme di airone grigio (Ardea cinerea), si sarebbe posato su questa prima massa di terra e, aprendo il becco, avrebbe lanciato il suo grido dando inizio ai cicli cosmici temporali. Il grido della fenice, oltre a scandire i ritmi temporali, rappresenta il Logos divino, la Parola Creatrice che dà ordine al creato. Per il suo legame con l’astro solare la pietra benben venne inserita nei principali elementi architettonici per il culto del sole. Con questa parola (usata in alternativa a pyramidion), si indicava quindi il coronamento degli obelischi, dei templi solari e delle piramidi. Si trattava di una pietra rivestita di elettron – lega di oro e argento – che rifletteva i raggi solari e rendeva la punta di questi monumenti luccicante, per ricordare a tutti il loro legame con il sole.
Lucica