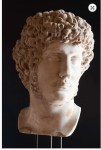PAOLO NICELLI
Parlare delle acquisizioni dei manoscritti africani da parte della Veneranda Biblioteca Ambrosiana dal suo inizio fino ad oggi richiederebbe una relazione lunga che andrebbe ben oltre il tempo a me consentito in questa sede. Tuttavia, celebrando in questo periodo il centenario della nascita di Mons. Enrico Rodolfo Galbiati (1914 – 2004), già Prefetto dell’Ambrosiana e insigne studioso di Sacra Scrittura e di Orientalistica, vorrei ripercorrere il periodo iniziale di tali acquisizioni, che corrisponde alla prima metà del Seicento, e che vede proprio in Mons. Galbiati un attento narratore a partire dalla corrispondenza del Cardinale Federico Borromeo (1564-1631), che racconta questo periodo. Dirò anche dell’importante acquisizione del fondo di Eugenio Griffini (1878 – 1925), eminente orientalista dell’inizio del secolo scorso, che collaborò attivamente allo studio e alla catalogazione di vari manoscritti arabi, etiopici e copti dell’Ambrosiana.
1. RUOLO PROPULSORE DI FEDERICO BORROMEO
La figura centrale all’inizio delle acquisizioni di manoscritti della Veneranda Biblioteca Ambrosiana è quella del Cardinale Federico Borromeo, che fu arcivescovo di Milano, impegnatosi a fondo nella difesa della giurisdizione ecclesiastica contro i governanti spagnoli e nella difesa del Rito Ambrosiano, promuovendo anche l’attuazione della riforma cattolica nei suoi vari aspetti(1) . Federico volle soddisfare un suo grande desiderio, quello cioè di poter avere in Ambrosiana un certo numero di manoscritti provenienti dal Vicino Oriente e dal Nord-Africa(2) . Tale desiderio, andava di pari passo con l’ulteriore desiderio di istituire per il Collegio dei dottori lo studio delle lingue semitiche e orientali in generale, oltreché l’approfondimento delle culture e civiltà ad esse collegate di cui egli era un vero cultore. L’intento fu quello di avere a disposizione degli esperti di Orientalistica che potessero insegnare ai dottori della Veneranda Biblioteca lingue quali: l’arabo, l’ebraico, il copto, l’etiopico, il siriaco e l’armeno, unendosi così a coloro che si dedicavano allo studio del greco, del latino e delle diverse lingue europee. Questa preoccupazione per gli studi orientalistici dimostra l’attenzione che Federico aveva per la cultura in termini generali, ma in modo particolare per le nuove correnti esegetiche, che, dopo Erasmo, ponevano la Filologia e la critica letteraria e testuale alla base del metodo d’indagine e di conoscenza del senso letterale del testo, indispensabile per poi accedere a quello allegorico e anagogico della Sacra Scrittura. Nel suo articolo di presentazione dei primi decenni dell’Orientalistica in Ambrosiana, Mons. Enrico Rodolfo Galbiati, ci dice che tra i manoscritti di Federico vi era una miscellanea catalogata sotto il nome di: Studi sulla lingua ebraica (G 1 inf.)(3) , contenente degli appunti grammaticali e un fascicolo con passi biblici scritti in ebraico con traduzione italiana interlineare. Il manoscritto contiene dei lavori preparatori di opere in via di pubblicazione, con il confronto di alcune frasi della Bibbia latina, dei libri storici (dal Pentateuco alle Cronache), con il testo ebraico citato nella versione latina. In più vi è una versione siriaca, di cui Federico trascrive le parole testuali usando l’ebraico. Tenendo conto che la versione siriaca dell’Antico Testamento fu stampata nel 1645 (Poliglotta di Parigi), si può presumere che Federico si servì di uno dei due manoscritti conservati presso l’Ambrosiana(4) . Lo stesso manoscritto riporta, nella sua terza parte, i primi tre capitoli della Genesi, tradotti da una versione araba. Infatti, in essa vi è un doppio foglio incollato con il testo in arabo del primo capitolo della Genesi. Probabilmente, il doppio foglio proveniva dal Collegio dei Maroniti di Roma(5) , su richiesta di Federico stesso. Da qui possiamo notare il grande interesse che il Borromeo aveva per gli studi orientalistici. Nel manoscritto autografo: Memorie delli libri da scriversi dal Collegio Ambrosiano, Federico scrive che circa le lingue straniere come l’arabo, il persiano, l’armeno, è necessario redigere delle grammatiche e dei dizionari, con in più il bisogno di conoscere quelle lingue per poter leggere e per distinguere bene i loro alfabeti(6) . Questo amore per le lingue orientali delinea il personaggio di Federico Borromeo, amante della sacra Scrittura e dell’Orientalismo. In più denota la portata missionaria e culturale del suo studio, cioè anticipa, in un certo senso, la stessa visione e preoccupazione missionaria che vedremo essere parte dello spirito e delle iniziative di Francesco Ingoli (1579–1649), primo segretario della Congregazione di Propaganda Fide, istituita da Gregorio XV nel 1622(7) . Ingoli richiedeva, infatti, nella formazione dei missionari partenti e già presenti sul campo, la conoscenza approfondita della cultura, dei costumi e delle lingue delle popolazioni presso cui essi andavano, al fine di comprendere la dimensione antropologica, religiosa e sociale di quei popoli. Il tutto era finalizzato a promuovere con efficacia il messaggio e i valori evangelici. Siamo all’inizio del dibattito teologico sull’inculturazione del Vangelo nel tessuto culturale di intere popolazioni che ancora non avevano ascoltato il messaggio salvifico di Cristo. Federico desiderava avere per i suoi futuri dottori un maestro di siriaco e di arabo. Per questo scopo si rivolse ai Maroniti di Roma, tenendo conto del fatto che i maroniti cattolici del Libano di rito antiocheno, cioè siriano, usavano anche la lingua araba, pur conservando quella siriaca(8) nell’uso quotidiano della liturgia.
1) P. PRODI, Borromeo, Federico, in Treccani, L’Enciclopedia Italiana on-line, (www.treccani.it/enciclopedia/federicoborromeo_%28 Dizionario-Biografico%29/ ultima consultazione 27 aprile 2015); vedi anche i diversi contributi nel volume: D. ZARDIN (ed.), Federico Borromeo vescovo, Milano, Biblioteca Ambrosiana – Bulzoni Editore, 2003, (Studia Borromaica 17).
2) Su questi temi vedi i diversi contributi nel volume: M. MARCOCCHI – C. PASINI (edd.), Federico Borromeo, fonti e storiografia, Milano, Biblioteca Ambrosiana – Editrice ITL (Studia Borromaica 15); P. BRANCA, Gli interessi arabistici del cardinal Federico Borromeo nel quadro dello sviluppo degli studi orientali durante il Seicento, in Federico Borromeo, uomo di cultura e di spiritualità, S. BURGIO – L. CERIOTTI (edd.), Milano, Biblioteca Ambrosiana – Bulzoni Editore, 2002, (Studia Borromaica 16), pp. 325-333.
3) E. R. GALBIATI, L’orientalistica nei primi decenni di attività, in A. ANNONI (ed.), Storia dell’Ambrosiana, Il Seicento, Milano, Cariplo – Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, 1992, p. 89. Interessante è l’articolo di A.M. PIEMONTESE, La raccolta vaticana di Orientalia: Asia, Africa ed Europa, in C. MONTUSCHI (ed.), Storia della Biblioteca Apostolica Vaticana III. La Vaticana nel seicento (1590-1700): una biblioteca di biblioteche, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2014, pp. 428-460. Sulla figura di Mons. Enrico Rodolfo Galbiati vedi: M. ADINOLFI – A. PASSONI DELL’ACQUA (edd.), Enrico Rodolfo Galbiati, un maestro, Casale Monferrato, Portalupi Editore, 2004; F. BRASCHI (ed.), Enrico Galbiati, liturgia ed ecumenismo. Per un’esperienza autentica del cammino verso l’unità, Milano, Edizioni La Casa di Matriona, 2014; A. PASSONI DELL’ACQUA (ed.), Enrico R. Galbiati (1914 – 2004): un prete ambrosiano con lo sguardo a Oriente. Convegno 7 maggio 2014, Milano, EDUCatt, 2014; P. FUMAGALLI, Enrico Rodolfo Galbiati, in C. BAFFIONI – R.B. FINAZZI – A. PASSONI DELL’ACQUA – E. VERGANI (edd.),Storia del pensiero religioso del Vicino Oriente. L’età bagratide, Maimonide, Affrate, III Dies Academicus 2012, Roma, Bulzoni Editore, pp. 300-303.
4) Si tratta della Pesittašdel VII secolo (B 21 inf.) e del manoscritto A 144-145 inf., eseguito a Gerusalemme tra il 1613 e il 1615.
5) GALBIATI, L’orientalistica, p. 91.
6) Manoscritto Z 109 sup. 16° loco, 17 loco: «[…] Intorno alle lingue straniere come l’Araba, Persiana, Armena, resta il carico di fare le grammatiche e li dittionari […]»; «[…] Vicina a questa fatica ve n’è un’altra curiosa e insieme utile, mentre si darà alle stampe tutti gl’Alfabeti delle lingue straniere nobili aggiungendovi regole per leggere […] In somiglianti linguaggi non è poco il sapere almeno leggere, et l’uno dall’altro distinguere, et riconoscerlo […]», in E. R. GALBIATI, L’orientalistica, p. 91.
7) Francesco Ingoli (1578-1649), giurista e professore di diritto civile e canonico. Studioso di astronomia, venne nominato da Gregorio XV segretario della Congregazione del Cerimoniale, poi segretario di Propaganda Fide, fondata nel 1622. Contro la politica del Patronato Real, (spagnolo) o Padronado Real (portoghese), Ingoli riformò la struttura stessa delle missioni, istituendo i delegati e i vicari apostolici, direttamente dipendenti da Roma e non dai reggenti di Spagna e Portogallo. Egli favorì la costituzione di seminari locali e la formazione del clero secolare e indigeno contro i privilegi degli ordini religiosi. Promosse il rispetto dei costumi e delle tradizioni dei popoli evangelizzati, promuovendo lo studio delle lingue locali da parte delle nuove generazioni di missionari. Fondò la Tipografia Poliglotta, ora Tipografia Vaticana. Su questo tema vedi: C. PRUDHOMME, Missioni cristiane e colonialismo, Milano, Editoriale Jaca Book, 2006, pp. 35-46; J. COMBY, Duemila anni di evangelizzazione, Torino, Società Editrice Internazionale, 1994, pp. 86-118; R. IANNARONE, La scoperta dell’America e la prima difesa degli Indios: i Domenicani, Bologna, PDUL Edizioni Studio Domenicano, 1992, pp. 145-215. Sull’istituzione di Propaganda Fide e le sue istruzioni ai vicariati apostolici vedi: M. MARCOCCHI, Colonialismo, Cristianesimo e culture extraeuropee. La istruzione di Propaganda Fide ai vicariati apostolici dell’Asia orientale (1659), Milano, Editoriale Jaca Book, 1980, pp. 15-59.
8) Si tratta della lingua siriaca della Mesopotamia settentrionale e della Siria. Lingua, questa, in cui fu scritta buona parte della letteratura cristiana. Nei secoli XVI e XVIII questa lingua veniva chiamata anche “caldaico” senza essere confuso con il “caldeo”, cioè l’aramaico biblico e giudaico. Su lingua e letteratura siriaca, cf. T. MURAOKA, Classical Syriac. A Basic Grammar with a Chrestomathy, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 1997 (Porta Linguarum Orientalium, Neue Serie 19); M. ALBERT, Langue et la littérature syriaque, in Christianismes Orientaux. Introduction à l’étude des langues et des littératures, Paris, Les Éditions du Cerf, 1993, pp. 297-375; S. BROCK, An Introduction to Syriac Studies, Piscataway (NJ), Gorgias Press, 2006.
Nel novembre del 1609, Michele il Maronita(9) fu scelto come maestro di siriaco. Dopo un anno e mezzo d’insegnamento Michele Maronita venne incaricato dal Borromeo di compiere un viaggio lungo e difficoltoso nel Vicino Oriente, alla ricerca di manoscritti siriaci, arabi e persiani, oltreché greci. Michele Maronita poté partire per il suo viaggio il 13 giugno 1611, solo dopo molti mesi di attesa, con le dovute lettere di raccomandazione per l’Arcivescovo di Corfù, ottenute dal veneziano Vincenzo Quirini, il quale aveva già favorito Antonio Salmazia con lettere di presentazione per un precedente viaggio organizzato assieme a Domenico Gerosolimitano, insigne ebreo, convertitosi al Cristianesimo. Dal 1607 al 1608, il Salmazia assieme al Gerosolimitano compirono, delle esplorazioni a Corfù, nelle isole dell’Egeo e in Tessaglia alla ricerca di libri rari(10). Michele Maronita portava con sé anche dei doni per il Patriarca dei maroniti e alcune linee guida sul comportamento da tenere con le autorità locali per ottenere l’acquisto dei manoscritti desiderati: l’affabilità, la gentilezza e là dove fosse possibile una certa famigliarità con le persone che potevano indicare i luoghi di deposito dei manoscritti. Anche l’utilizzo degli interpreti aveva una sua ragion d’essere, per via dei diversi dialetti usati per le trattative di vendita. Poi l’uso discreto e coscienzioso del denaro dato a coloro che con certezza potevano donare dei codici di valore. In questo senso, non si doveva essere avari soprattutto con coloro che fossero stati riluttanti alla vendita dei manoscritti. Bisognava pagare i manoscritti per il loro reale valore, giungendo così allo scopo prefissato. Tuttavia, di fronte a una continua resistenza, si doveva, con scrittura certa, fissare un tetto oltre il quale non si doveva andare(11). Il viaggio di Michele Maronita durò due anni ed ebbe tristemente fine per la malattia mortale che lo colpì nella città di Aleppo alla fine del 1613. Prima di morire, Michele Maronita raggiunse Corfù, Zante e poi Creta, per poi proseguire per Tripoli di Siria, in visita all’Arcivescovo maronita. Da qui un certo numero di manoscritti furono catalogati e spediti a Milano. Poi visitò il monastero di Qannūbīn, sede del Patriarca dei maroniti Pietro Giovanni Maḥlūf, in carica dal 1608 al 1634, per il quale Michele Maronita tradusse una lettera di ringraziamento per i doni liturgici ricevuti da Federico Borromeo(12). Di seguito, Michele Maronita spedì a Milano dei libri caldei e poi si recò a Gerusalemme per preparare una copia dell’Antico Testamento in siriaco. Di tale copia, conservata in due volumi in Ambrosiana (A 144-145 inf.), E. R. Galbiati ci dice: […] che il primo (tomo) porta l’indicazione «scritto a Gerusalemme negli anni 1612-1614 per ordine del cardinal Federico». Al f. 408 r. del primo volume vi è un lungo colophon da cui risulta che quella parte fu scritta a Gerusalemme nel monastero della Madre di Dio Maria, che è chiamato Casa di San Marco, dei siriani ortodossi. Il secondo volume al f. 406 v. porta un lungo colophon: l’Antico Testamento fu continuato dal monaco maronita Elias di Ehden (Libano) e terminato il 25 maggio del 1615. L’incarico fu dato al guardiano dei francescani per eseguire l’ordine del cardinal Federico Borromeo. L’intervento del francescano fu dovuto probabilmente al fatto che nel frattempo Michele era morto(13) . Michele Maronita proseguì poi per Costantinopoli dove trovò il nobile veneziano Marco Paruta, il quale gli fu di grande aiuto nell’acquisto di manoscritti arabi e persiani di medicina, di astronomia e di matematica. Al suo ritorno a Gerusalemme il Nostro acquistò altri codici. In seguito, come già menzionato, Michele Maronita si recò ad Aleppo, città nella quale morì, probabilmente a causa di un’epidemia. Prima della sua visita ad Aleppo, Michele maronita visitò l’Egitto, come era nei suoi programmi, da dove probabilmente spedì dei codici molto importanti a Milano presso la Biblioteca Ambrosiana. Questo spiegherebbe l’arrivo a Milano del massimo tesoro siriaco costituito dai due codici: il B 21 inf., in due volumi, contenenti la famosa Peshitta dell’Antico Testamento, e il C 313 inf.,l’unicum della Versione siro-esaplare(14) . Entrambi i codici furono comperati dal monastero di Santa Maria Madre di Dio nel deserto di Skiti, in Egitto.
9) La lettera da Corfù del 7 agosto 1611 (G 206 bis inf. N. 230), riporta la firma di Michele Maronita, il quale si firmava in questa come in altre lettere con lo pseudonimo di «Michele Micheli», cioè Michele figlio di Michele.
10) S. LUCÀ, L’apporto dell’Italia meridionale alla costituzione del fondo greco dell’Ambrosiana, in C. M. MAZZUCCHI – C. PASINI (edd.), Nuove ricerche sui manoscritti greci dell’Ambrosiana, Atti del Convegno, Milano, 5-6 giugno 2003, Milano, Vita e Pensiero, 2004, p. 198; C. PASINI, La raccolta dei manoscritti greci all’origine dell’Ambrosiana: linee di acquisizione (in particolare la missione di Antonio Salmazia a Corfù negli anni (1616-1631), in Federico Borromeo, fonti e storiografia, M. MARCOCCHI – C. PASINI ( edd.), Milano, Biblioteca Ambrosiana – Editrice ITL, 2001, (Studia Borromaica 15), pp. 59-100.
11) Cfr. GALBIATI, L’orientalistica, p. 106.
12) L’originale della lettera (X 299 inf., ins. 1) è scritto in karšūnī (arabo in alfabeto siriaco) ed è stato tradotto in italiano dallo stesso Michele Maronita (G 206 inf., n. 230 bis).
13) GALBIATI, L’orientalistica, pp. 118-119.
2. CODICI POLIGLOTTI AMBROSIANI
Secondo E.R. Galbiati, sempre a Michele Maronita potrebbe doversi l’acquisizione del manoscritto pentaglotto B 20 inf. A, datato tra il XIII e XIV secolo15 , che contiene le Epistole di San Paolo, nelle cinque lingue etiopica, siriaca, copta, araba e armena – quest’ultima lingua è assente a partire dai ff. 176 fino alla fine; e del manoscritto tetraglotto B 20 inf. B, che contiene le Epistole Canoniche e gli Atti degli Apostoli, con l’esclusione della colonna in lingua armena. Entrambi i codici sono stati scritti in Egitto alla fine del XIV secolo, presso il monastero di san Macario. Da un’osservazione dei manoscritti, si nota la mano di più copisti per via della diversità delle calligrafie e della mancanza di uniformità nelle colonne. Circa il manoscritto B 20 Inf. A, l’impressione sarebbe quella del lavoro di un’équipe multilingue che operò fecondamente nella produzione dell’opera(16) . Una possibile relazione potrebbe esserci tra i manoscritti B 20 inf. A della Biblioteca Ambrosiana e il Salterio poliglotto del XIV secolo, conservato presso la Biblioteca Vaticana (Barberini Orientale 2), ivi giuntovi tramite il padre Agatangelo de Vendôme(17). Essi sarebbero associati alla figura di Rabban Ṣalībā (Maestro della Croce), probabile curatore e acquirente del B 20 inf. A., così come indicato nell’annotazione in B 20 inf. A f. 74 V: «Chiedo dunque a ogni fratello spirituale che sfoglierà questo libro di pregare per il peccatore che, debole e misero e perduto nei peccati, scrisse il libro in siriaco. E pregate per i miei padri, e i miei fratelli e i miei maestri, e per il sacerdote nostro Maestro della Croce, poiché egli si prese cura e acquistò questo tesoro spirituale; e ognuno, in conformità alla sua preghiera, possa ricevere la ricompensa dal Signore. Amen» (18) . Il riferimento al Maestro della Croce potrebbe indicare la persona stessa di Rabban Ṣalībā, ipotesi questa tutta da verificare. Da qui, risulta ancora incerto chi di fatto abbia curato il manoscritto e, più ancora, chi lo abbia acquistato, se Michele il Maronita, come ipotizzato dal Galbiati o Rabban Ṣalībā, come indicato nell’annotazione in B 20 inf. A f. 74 verso19 . Sulla stessa linea, bisognerebbe verificare lo stesso ruolo di Rabban Ṣalībā in relazione al Salterio poliglotto della Biblioteca Vaticana (Barberini Orientale 2). Il manoscritto cartaceo, B. 20 inf. A (Pentaglotto – San Paolo, epistole dall’Apostolo Pentaglotto (etiopico, siriaco, copto, arabo, armeno) include la lettera agli Ebrei e segue il seguente ordine: 1) Lettera ai Romani, (versetti iniziali 3, 29/30 aiḍan li-anna ’llāh wāḥid huwa ’lladī yubarriru ahl-hitān); 2) (46b) Prima lettera ai Corinzi; 3) (99b) Seconda lettera ai Corinzi; 4) (142a) Lettera ai Galati; 5) (160b) Lettera agli Efesini; 6) (176b) Lettera ai Filippesi; 7) (188b) Lettera ai Colossesi; 8) (199b) Prima lettera ai Tessalonicesi; 9) (208b) seconda lettera ai Tessalonicesi; 10) (214a) Lettera agli Ebrei; 11) (246b) Prima lettera a Timoteo; 12) (260a) Seconda lettera a Timoteo; 13) (268a) Lettera a Tito; 14) (273b) Lettera a Filemone. Due note interessanti in arabo ci dicono che la colonna araba del manoscritto originale, di cui non si ha notizia, fu scritta da un sacerdote di nome Ṣalīb (Rabban Ṣalībā) nel monastero dei siriani di Nostra Signora la Vergine (Maria)(20). E. R. Galbiati ci dice invece che nel manoscritto la scrittura etiopica è di tipo arcaico. Il colophon dice: « Sono terminate qui le epistole di Paolo apostolo in 14 libri. Pregate per me che le ho tradotte affinché si ricordi Cristo di me nel suo regno. Amen»(21)
14) GALBIATI, L’orientalistica, p. 108.
15) O. LÖFGREN – R. TRAINI, Catalogue of the Arabic Manuscrips in the Biblioteca Ambrosiana, I, Antico Fondo and Medio Fondo, Vicenza, Neri Pozza Editore, 1975, p. 3.
16) Cfr. E. VERGANI, Colofoni siriaci della Biblioteca Ambrosiana. Scritte e annotazioni, in A. SIRINIAN – G. SHURGAIA (edd.), Colofoni armeni a confronto, Atti del Workshop, Bologna 12 ottobre 2012, (in corso di pubblicazione).
17) Cfr. D.V. PROVERBIO, Barb. or. 2 (Psalterium Pentaglottum), in P. BUZI – D.V. PROVERBIO (edd.), Coptic Treasures from the Vatican Library. A Selection of Coptic, Copto-Arabic and Ethiopic Manuscripts. Papers collected on the occasion of the Tenth International Congress of Coptic Studies (Rome, September 17th-22nd, 2012), Studi e testi, 472, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2012, pp. 163-174.
18) Traduzione ad opera di E. Vergani, che qui ringrazio.
19) Tuttavia, ci troviamo di fronte a delle ipotesi da verificare. Detto questo, non possiamo affermare con certezza che Rabban Ṣalībā abbia acquistato il manoscritto per la Biblioteca Ambrosiana.
20) Cfr. LÖFGREN – TRAINI, Catalogue, p. 3-4. 5
21) E. R. GALBIATI, I manoscritti etiopici dell’Ambrosiana, in Studi in onore di mons. Carlo Castglioni, Milano, Giuffrè Editore, 1957, p. 340. Ricordiamo i contributi di Tedros Abraha, accademico della Classe di Studi Africani della Biblioteca Ambrosiana, sulla Lettera ai Romani e sulla figura di San Paolo, letto dalla tradizione etiopica: T. ABRAHA, La lettera ai Romani. Testo e commentari della versione etiopica, Aethiopistische Forschungen 57. Wiesbaden: Otto Harrassovits Werlag, 2001; IDEM, The Ethiopic Version of the Letters to the Hebrews, Volume 419 di Studi e Testi, Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, 2004; IDEM, Paolo “lingua profumata”. Il maestro delle genti nella tradizione etiopica, in BARTOLOMEO PIRONE – ELENA BOLOGNESI (edd.), San Paolo letto da Oriente: Atti del convegno internazionale in occasione dell’anno paolino, Damasco 23-25 aprile 2009, Studia Orientalia Christiana, Monographiae, 18, Milano, Edizioni Terra Santa, 2010, pp. 179-216; IDEM, The Ethiopic Versions of 1 and 2 Corinthians, Roma, [s.n.] 2014.

Fig. 1 – San Paolo Epistole Pentaglotto (B 20 inf. A, f. 110 recto)
Il manoscritto cartaceo B. 20 inf. B (Tetraglotto – Epistole Canoniche e Atti degli apostoli: Tetraglotto, arabo, copto siriaco, etiopico) fu scritto alla fine del XIV secolo nel monastero di San Macario, in Egitto. Il manoscritto contiene le Epistole Canoniche e gli Atti degli Apostoli in solo quattro delle lingue dei cristiani “monofisiti” (22) . Manca infatti la quinta colonna in Armeno. Esso segue il seguente ordine: A. (1- 54) le sette Epistole Cattoliche: Lettera di Giacomo; (13b) Prima Lettera di Pietro; (27a) Seconda lettera di Pietro; (35b) Prima lettera di Giovanni; (48b) Seconda lettera di Giovanni; (50a) Terza lettera di Giovanni; (51b) Lettera di Giuda. B. (55b-186) Atti degli Apostoli.

Fig. 2 – Epistole canoniche e Atti degli Apostoli – Tetraglotto, Prima lettera di San Giovanni (B. 20 inf. B, ff. 35 verso e 36 recto)
22) Riportiamo il virgolettato per evitare l’uso eresiologico dell’aggettivo “monofisiti”
3. CODICI COPTI AMBROSIANI
Tra i manoscritti siriaci dell’Ambrosiana oltre all’Antico Testamento scritto a Gerusalemme solo i Salmi e Canti Biblici, con la versione in arabo karšūnī (G 31 sup.) e i Canoni Apostolici, Vite di Santi, Omelie (R 15 sup.), in arabo karšūnī, provengono dal Libano. Altri manoscritti cristiani in lingua siriaca, sarebbero stati scritti dai monaci Maroniti di Roma. Tuttavia, sebbene Michele Maronita avesse realizzato solo in parte le sue aspettative di acquisto di libri, si pensa che i manoscritti arabo-cristiani e arabo-islamici catalogati nel Vecchio Fondo(23) siano frutto dell’opera svolta dal Nostro, come coscienzioso servizio svolto a Federico Borromeo, nello svolgimento del suo viaggio in Vicino Oriente. Nella collezione dell’Ambrosiana in lingua etiopica, si trovano alcuni codici provenienti dall’ospizio abissino di Santo Stefano dei Mori, presso il Vaticano. Tali manoscritti sono stati studiati e catalogati dall’illustre orientalista Sylvain Grébaut, il quale trascorse un periodo di ricerca presso la Veneranda Biblioteca durante l’anno 1933 e in quell’occasione stabilì il Catalogo dei manoscritti etiopici pubblicati poi nel Catalogue des Manuscrits Ethiopiens de la Bibliothèque Ambrosienne, «Revue de l’Orient Chrétien», 3e Série, IX (XXIX), 1 et 2 (1933-1934), pp. 3-32. Secondo E.R. Galbiati, si trattava di una serie di cinque manoscritti tra cui i due famosi: Pentaglotto e Tetraglotto già menzionati, riportanti la colonna in lingua etiopica. La metodologia di catalogazione utilizzata dal Grébaut risulta essere diversa rispetto quella utilizzata dall’Ambrosiana. Egli raccolse e catalogò i manoscritti secondo le rispettive lingue, metodologia che lo stesso Galbiati continuerà a completamento del Catalogo del Grébaut, aggiungendo ai codici non ancora catalogati quelli di nuova acquisizione dell’Ambrosiana(24). Di questi manoscritti etiopici presentiamo qui X 104 sup. che nei ff. 3 verso e 4 recto, riportano la parte iniziale del Salterio Etiopico. A seguire, presentiamo X 104 sup. bis., che nei ff. 180 verso e 181 recto, riporta la parte iniziale del Weddāsē Māryām, l’Ufficio della Madonna per i sette giorni della settimana. Le schede di catalogazione sono dello stesso E.R. Galbiati: X 104 sup. (Grébaut n. I), (ff. 3 verso e 4 recto Parte iniziale del Salterio Etiopico) Manoscritto membranaceo (ff. 1-2 cart.); ff. 179; cm. 13,5 X 12; scrittura elegante ed arcaica (la lettera lō senza penducolo e forme angolose). Secolo XV; ff. 1-2 (cartacei, scrittura grossolana. Preghiera magica; inizio di un Calendario, altra invocazione magica; Salmo 132,3; immagine di Davide tolta dal Salterio Etiopico stampato nel 1513, ff. 3-153. Salterio; ogni decade è divisa dalla seguente mediante un fregio; dopo il Salmo 100 (f. 100), una pagina ornata; ff. 154 recto – 169 verso. Cantici dei Profeti (oltre le Odi del Canone Bizzantino la serie etiopica comprende anche il Canto di Ezechia e la Preghiera Apocrifa di Manasse); ff. 170-179. Canto dei Cantici, diviso in 5 sezioni. Il f. 179 V., è occupato da una ornamentazione colorata(25).
23) Per il Vecchio Fondo, vedi O. LÖFGREN – R. TRAINI, Catalogue, of the Arabic Manuscrips in the Biblioteca Ambrosiana, I, Antico Fondo and Medio Fondo, Vicenza, Neri Pozza Editore, 1975; J. VON HAMMER – PURGSTALL, Catalogo dei codici arabi, persiani e turchi della Biblioteca Ambrosiana, «Biblioteca Italiana», 94, 1939, pp. 22-49, 222-348, in Galbiati, L’orientalistica, p. 119.
24) E.R. GALBIATI, I manoscritti etiopici dell’Ambrosiana, in Studi in onore di mons. Carlo Castglioni, Milano, Giuffrè Editore, 1957, pp. 329-353; ID., I fondi orientali minori (siriaco, etiopico, armeno) dell’Ambrosiana, in Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere, Atti del Convegno La Lombardia e l’Oriente (Milano, 11-15 giugno 1962), Milano, Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere, 1963, pp. 190-196. Circa la descrizione dei manoscritti fatta da E. R. Galbiati e di S. Grébaut, essa deve essere contestualizzata e inquadrata a sua volta nel processo di progressivo sviluppo della descrizione e catalogazione dei manoscritti orientali anche come implicita riflessione sui fenomeni culturali più ampi e complessi. Ben sapendo che vi sono altri metodi di catalogazione più moderni, con spirito di riconoscenza verso questi due grandi studiosi, riproponiamo una sintetica presentazione fondata sulla loro descrizioni dei manoscritti.
25) GALBIATI, I manoscritti, p. 141.

Fig. 3 – Salterio Etiopico (X 104 sup., ff. 3 verso e 4 recto) X 104 sup. bis. (Grébaut n. I), (ff. 180 verso e 181 recto. Parte iniziale del Weddāsē Māryām).
Manoscritto cartaceo; cm. 13,5 X 10 circa; scrittura sgraziata per mancanza di mezzi idonei. Sec. XVI. Gli 82 fogli di questo manoscritto, redatto probabilmente a Roma, insieme con i primi due (cartacei) del precedente, furono legati in un sol volume con il precedente membranaceo e più antico, scritto certamente in Abissinia da mano espertissima. Forse la legatura fu fatta dagli Abissini stessi di S. Stefano, essendo abituale nei manoscritti il trovare i salmi, Cantici e la Cantica uniti ai testi in onore di Maria che si trovano in questo manoscritto. Comunque, le due parti, di diversa dimensione, furono separate in due volumi nel restauro fatto a Modena nel 1956, per assicurarne la miglior conservazione. Si è tuttavia lasciata immutata la numerazione dei fogli; ff. 180 verso – 209 R. Weddāsē Māryām, il noto Ufficio della Madonna per i sette giorni della settimana; ff. 209 verso – 224 R. Weddāsē za’ Egze’etena M… anqasa berhān: l’altro consueto Ufficio a Maria «Porta della luce»; ff. 225 verso – 250 R. Anafora di Maria composta da Abbā Giyorgis. È un testo raro: dopo di essere stato portato a Roma (Vat. Et. 15, 193; 18, 122, 24, 138 verso), questo testo scomparve totalmente dall’Abissinia in seguito alle devastazioni belliche del secolo XVI. Ritrovata in una caverna di Kaffa, quest’anafora è in uso soltanto nella cappella reale di Adis Abeba (T. M. Semharay, La Messe Ethiopienne, Roma 1937, p. 98). Essa s’intitola dalle prime parole Ma‘azā Qeddāsē: Profumo di Consacrazione; ff. 250-260. Frammenti diversi: Simbolo di Nicea, Decalogo, Preghiera magica, tracce di un’immagine etiopica, due stampe europee, Calendario dei Santi (f. 257 verso), Preghiera, Mc 7, 31-35. I Colofoni sono ai ff. 179 recto; 209 recto; 224 verso – 225 recto: il proprietario è Kefla- Dengel, l’amanuense è Feqra-‘Egzi’e. Risulta che questo duplice manoscritto apparteneva al fondo Pinelli(26)
26) GALBIATI, I manoscritti, p. 141.

Fig. 4 – Weddāsē Māryām, (X 104 sup. bis., ff. 180 verso e 181 recto)
Un altro manoscritto in lingua etiopica custodito in Ambrosiana, del quale alcune pagine si stanno perdendo a causa dell’eccesiva fragilità, è il B 22 sup., di 182 fogli, scritto con un inchiostro molto corrosivo. Esso fu studiato e catalogato da Mons. E.R. Galbiati, che ne tradusse così il suo titolo: “Questo è (il libro de) le Ore di Kefla-Dengel figlio (spirituale) di Abuna Ewostatēwos, e il mio maestro è Abbā Kefla Seyon figlio di Abbā Tesfā-Hawāryāt”. Il libro delle Ore fu scritto a Roma al tempo di Clemente VIII e del sovrano dell’Etiopia Ya‘qob, che regnò dal 1597 al 1603. Il libro contiene due opere: A) I computi astronomici, composti da: 1) Il computo delle feste mobili nel periodo di 19 anni; 2) Le osservazioni sui moti del sole. B) Horologion, composto da: 1) Una serie di lezioni bibliche; 2) La Preghiera della mezzanotte; 3) La Preghiera del mattino; 4) La Preghiera dell’ora sesta; 5) La preghiera della quiete (Mc 13, 32-37. Custodisci di continuo, o Signore, in questa ora, nella quale hanno potere i demoni, e circondaci di una barriera con la forza degli Angeli, perché ecco il dominatore della notte); 6) L’inno che parafrasa il Pater Noster.
B 22 sup. (E.R. Galbiati), (ff. 1 verso e 2 recto. Parte iniziale de Il libro delle Ore di Kefla-Dengel).

Fig. 5 – Il libro delle Ore di Kefla-Dengel (B 22 sup., ff. 1 verso e 2 recto)
4. FRAMMENTI COPTO-ARABI AMBROSIANI
Nella collezione di manoscritti dell’Ambrosiana in lingua copta vi sono due frammenti in copto-arabo appartenenti al fondo di Eugenio Griffini(27), l’S. P. II. 18. Ter, che fa parte del Rituale copto per il conferimento del Battesimo e benedizioni connesse. I frammenti sono di inestimabile valore, in quanto dopo il Vangelo della presentazione di cui sono indicati i versetti finali (Lc 2, 34-35), viene la Preghiera di benedizione sulla Donna, che ha partorito un figlio maschio. La fotocopia allegata al frammento, qui non riprodotta, traduce il testo con qualche variante, così come è contenuto nell’Edizione cattolica del Rituale copto-arabo. La traduzione autografa di E. Griffini è riportata su alcuni foglietti allegati al frammento.
27) Eugenio Griffini, (1878-1925) fu un insigne orientalista. Fra il 1908 e il 1910 cominciò la catalogazione della prima collezione di 125 manoscritti nella Rivista di Sudi Orientali con il titolo: I manoscritti sud-arabici della Biblioteca Ambrosiana di Milano: saggio del catalogo per materie della prima collezione (coranica, tradizioni, dogmatica, mistica…), Roma 1910. Il catalogo fu poi proseguito con dei nuovi criteri sempre nella Rivista di Sudi Orientali, dal 1910 al 1919 (vedi: Catalogo di manoscritti arabi di Nuovo Fondo della Biblioteca Ambrosiana di Milano, I, Codici 1- 475, ibid. 1920). L’opera del Griffini fu poi ripresa dallo studioso orientalista svedese Oscar Löfgren e proseguita dall’arabista e orientalista Renato Traini. Su questo tema vedi: (http://www.treccani.it/enciclopedia/eugeniogriffini_(Dizionario-Biografico)/ ultima consultazione 27 aprile 2015); cf. P.F. FUMAGALLI, Raccolte significative dei manoscritti: Mosè Lattes, fondo Trotti, Giuseppe Caprotti, in G. VANETTI, Storia dell’Ambrosiana. L’Ottocento, Milano, IntesaBci, 2001, pp. 167-211, 194-206.
(S. P. II. 18. Ter), frammento copto-arabo (Fondo Eugenio Griffini – 1)

Fig. 6 – Frammento del Rituale copto per il conferimento del Battesimo e benedizioni connesse (S. P. II. 18. Ter)
(S. P. II. 18. Ter), frammento Copto Arabo (Fondo Eugenio Griffini – 2).

Fig. 7 – Frammento del Rituale copto per il conferimento del Battesimo e benedizioni connesse (S. P. II. 18. Ter)
CONCLUSIONE
Ciò che abbiamo presentato in questo breve excursus sono solo alcune delle perle preziose che la Veneranda Biblioteca Ambrosiana custodisce con amore. Si tratta di un piccolo campionario dei fondi acquisiti al tempo di Federico Borromeo e in tempi più recenti. Ancora oggi, il Collegio dei Dottori dell’Ambrosiana custodisce con cura queste opere a cui, nel tempo, se ne sono aggiunte delle altre, non solo provenienti dal Nord Africa e dal Vicino Oriente, ma anche dall’Asia centrale e dall’Estremo Oriente. Lo studio delle lingue legato alla ricerca filologica, letteraria e dottrinale delle antichità cristiane, è condotto nel quadro degli studi storici dei testi appartenenti ad altre tradizioni religiose ben oltre il bacino del Mediterraneo. Così dalla Cina, dal Giappone sono giunte delle opere interessanti e una notevole documentazione utile all’attività dell’Accademia Ambrosiana, parte questa, che accanto alla Biblioteca e Pinacoteca, promuove ricerche e studi della Veneranda Biblioteca Ambrosiana. La neonata Classe di Studi Africani, che studia questi manoscritti come altri in lingua araba, copta, etiopica, berbera, si inserisce in un lavoro di ricerca filologica con la precisa ambizione di approfondire lo studio storico e di attualità del mondo culturale mediorientale e africano, prendendo in esame le aree nord africane e coinvolgendo anche quelle sub-sahariane. In questo senso, il desiderio del compianto Gianfranco Fiaccadori, insigne accademico dell’Ambrosiana, ispiratore e fondatore della Classe di studi Africani, era quello di coinvolgere gli studiosi della Classe in un opera di approfondimento delle realtà religiose, sociali e antropologiche dell’Africa, non solo araba, ma anche sub-sahariana. Approfondire la realtà culturale e umana di un continente così vasto e variegato quale quello africano, ancora soggetto a guerre intestine e tribali, dovute a questioni politiche ed economiche regionali e internazionali, non si presenta un compito facile. Tuttavia, è dovere nostro farci promotori di quei valori di giustizia e di pace che solo un dialogo culturale e inter-religioso può veramente favorire al di là di ogni interesse di parte, sia esso politico o economico. In questo senso, si potranno promuovere dei lavori di ricerca interdisciplinare che coinvolgeranno la Classe di studi Africani e le altre Classi dell’Accademia, nello spirito proprio di Federico Borromeo, che ha voluto creare questo luogo aprendolo alla comunicazione del sapere, oltre le frontiere geografiche, ideologiche e religiose. Non è retorico ricordare che lo studio dei manoscritti appartenenti alla tradizione cristiana orientale, come a qualsiasi altra tradizione religiosa, è un vero e proprio contributo alla preservazione e valorizzazione di un patrimonio dell’umanità. La sua custodia, analisi e interpretazione, è un nostro compito fondamentale, in quanto studiosi ed estimatori del loro eccezionale valore culturale, scientifico, storico-formativo e religioso.
PAOLO NICELLI
The Manuscripts of Arabic, Ethiopic and Coptic Africa, Collected at the Time of Federico Borromeo, read and catalogued by Enrico Rodolfo Galbiati and Eugenio Griffini The article briefly introduces the historical events which brought about the collection of Arabic, Ethiopic and Coptic manuscripts belonging to the Veneranda Biblioteca Ambrosiana (Ambrosian Library), at the time of Federico Borromeo (1564-1631), Archibishop of Milan and Founder of the Ambrosian Library. The research is based on the studies and cataloguing of E.R. Galbiati, biblist, orientalist and Prefect of the Ambrosian Library and E. Griffini, orientalist and philologist, who collaborated for several years with the same Library. The article underlines Federico Borromeo’s great interest for orientalist studies, looking at the possible institution of a Collegium of Doctores, which were able to read, translate and write scientific commentaries on these manuscripts. At the same time from this research it comes out Federico Borromeo’s idea of establishing a place of culture in the City of Milan, able to communicate the humanistic sense of learning through the attitude of dialogue, bridging relationships among different thoughts, cultures and peoples.
Nicelli P., [Manoscritti dell’Africa araba, etiopica e copta al tempo
di Federico Borromeo, letti e catalogati da Enrico Rodolfo Galbiati ed
Eugenio Griffini] in Paolo Nicelli (a cura di), L’Africa, l’Oriente
Mediterraneo e l’Europa. Tradizioni e culture a confronto, Biblioteca
Ambrosiana – Bulzoni Editore, Roma 2015, pp. 1-12.
Dr. Padre Paolo Nicelli, PIME
Dottore della Biblioteca Ambrosiana
Direttore della Classe di Studi Africani
Professore di Teologia Dogmatica, Missiologia, Studi Arabi e Islamistica.
Uff. (+39) 02-80692.325
E-mail: pnicelli@ambrosiana.it
website: www.ambrosiana.eu